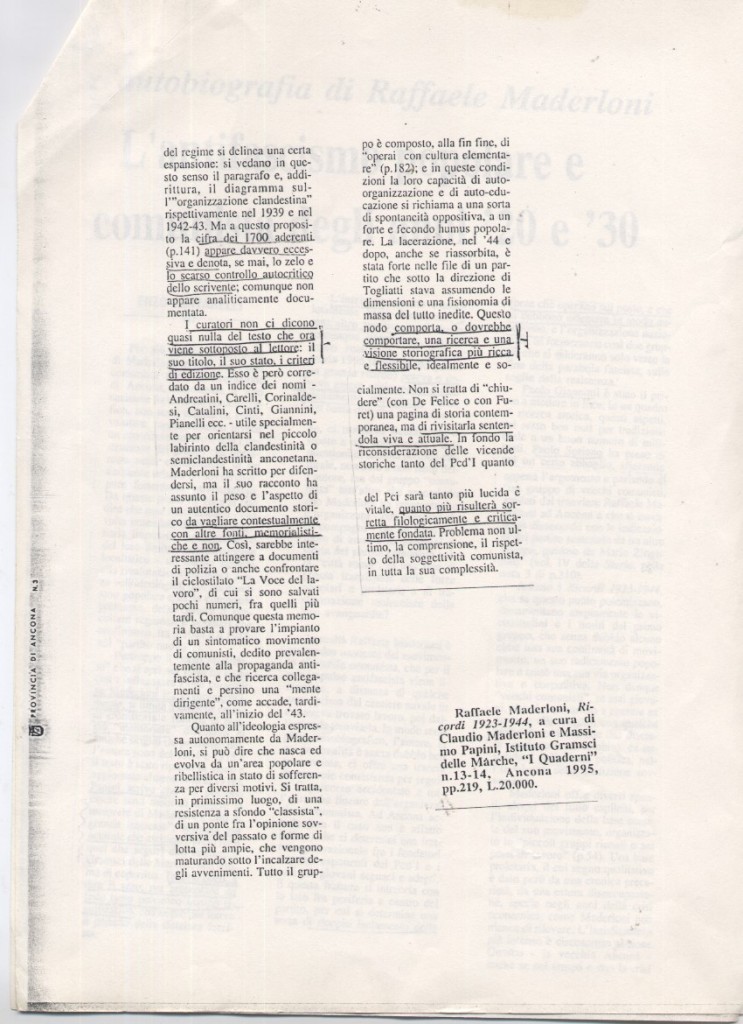Argomenti trattati
1) Tratto da Il prezzo della libertà.
2) La storia di Raffaele Maderloni. Al giornale “Bandiera Rossa”.
3) Per leggere il libro
4) Marisa Saracinelli Presentazione del libro “Raffaele Maderloni. Ricordi 1923 -1944”
5) Enzo Santarelli sull’autobiografia di Raffaele Maderloni

1) Tratto da Il prezzo della Libertà
A cura dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti.
Episodi di lotta antifascista Roma 1958
L’anticamera del tribunale speciale. di Raffaele Maderloni
Verso la fine dell’estate 1932 il IV, il VI e l’VIII braccio di <<Regina Coeli>> erano pieni di detenuti politici. Rappresentavano tutte le province d’Italia. Prelevavano gli operai e i contadini braccianti. Tutti i partiti antifascisti erano rappresentati, ma la grande maggioranza era costituita da comunisti, quasi tutti tra i 20 e i 35 anni di età-
Da mesi il tribunale speciale oziava mentre i detenuti si ammucchiavano sempre più numerosi in celle che dovevano ospitarne uno solo. Una notte il carcere si riempì fino all’inverosimile. Grandi retate di antifascisti erano state effettuate nei Castelli e ora gli arrestati venivano pigiati dentro il carcere romano. La vita, nelle celle, diventava sempre più dura; si desiderava l’inizio dei processi – sembra incredibile a dirsi – per poter andare in una casa di reclusione, augurandosi, magari, di capitare nel penitenziario di Volterra, dove, si diceva, era rinchiuso Mauro Scoccimarro che, si diceva, dava lezioni di economia politica.
Per le celle ricorreva il nome di Clemente Maglietta come quello di uno dei compagni più qualificati che allora si trovassero a <<Regina Coeli>> così come si parlava molto di uno studente universitario comunista: il dottorino (così lo chiamavano) Francesco Scotti e del compagno Mirotti, di Casalpusterlengo. Si narrava, da una cella all’altra, che il padre di Scotti fosse caduto fulminato alla stazione di Milano, non appena il treno che conduceva il figlio al carcere di Roma si era mosso.
Un giorno tutti i detenuti ebbero di che commuoversi profondamente. Dal muraglione del Gianicolo, che sovrasta il carcere e costituisce l’unico panorama dei detenuti, si affacciarono cinque bambini. Guardando verso i bracci presero a urlare con quanto fiato avevano in gola: <<A sor Favillaaaa… a sor Favillaaaa…>> Da una delle celle una voce risponde: <<Annate a casa!>>E i ragazzi in coro: << A papà, non possiamo, semo fori de casa…ci hanno dato lo sfratto…>> Il povero compagno, padre dei cinque bambini, si strappava i capelli per la disperazione. Ma non c’era niente da fare … Eravamo a <<Regina Coeli>>.
Fra i politici prendeva sempre più piede l’idea di una grande protesta collettiva per indurre il Tribunale speciale a riprendere i processi. A dar corpo e inizio a questa intenzione venne la provocazione inscenata da un detenuto comune. Questi, tornato dal processo, si mise alla finestra della sua cella, al VII braccio, e annunciò a squarciagola che il suo avvocato gli aveva garantito che il governo, in occasione del decennale della <<marcia su Roma>>,andava preparando un decreto di amnistia. E fin qui nulla di male, ma poi attaccò una sfilza di evviva al duce, al regime e a quanto altro poté ricordare della gerarchia fascista.
Un finimondo di urli e fischi coprì il provocatorio panegirico, poi le urla <<abbasso Mussolini>>, <<morte al fascismo>> divenne un coro scandito da tutti i politici. Dalle <<Mantellate>> risposero le detenute politiche e per un bel pezzo si sentirono da molto lontano.
Questo episodio servì a creare un’atmosfera sempre più infuocata. Attraverso i normali mezzi di comunicazione funzionanti fra i detenuti, si decise di approfittare della ricorrenza fascista del 28 ottobre per rifiutare il pranzo speciale e fare per un giorno lo sciopero della fame allo scopo di reclamare la ripresa dei processi.
Alla preparazione della agitazione parteciparono Maglietta, Scotti, Mirotti e Premoli, quel Premoli che ci risultava essere stato ad Ancona per riorganizzarvi il Partito Comunista. Va rilevato che, allora, <<radio cella>> affermava che detenuti a <<Regina Coeli >> vi fossero oltre cento tra funzionari e <<corrieri>> del Partito Comunista.
La giornata del 28 ottobre passò in digiuno e tra continue acclamazioni alla Russia del Soviet e vituperi al fascismo.
Nei giorni successivi filtrò da una cella all’altra l’idea di salutare l’alba del 7 Novembre, anniversario della Rivoluzione di Ottobre, con il canto di tutti i detenuti. Inutile dire che si doveva cantare <<l’Internazionale>>.
Sarebbero senz’altro fioccate le punizioni, ma l’entusiasmo andava divampando; si raccontavano gli episodi di fermezza di cui gli antifascisti erano stati protagonisti dinanzi al Tribunale speciale; delle sentenze di condanna accolte al grido di << abbasso il fascismo>> e delle conseguenti supplementari pene irrogate per questo nuovo reato. Destavano anche grande entusiasmo i racconti sui compagni che avevano iniziato il transito dalla stazione di Roma al carcere al canto degli inni proletari e antifascisti. Le condanne che avevano riportato per questo loro atteggiamento ribelle erano per noi incentivo di più.
La notizia della amnistia concessa dal governo fascista per il <<decennale>> gettò olio sul fuoco del nostro entusiasmo. Venne l’alba del 7 novembre. Prima che la campana suonasse la sveglia, nel silenzio che ancora avvolgeva il tetro edificio, nell’imminenza di quanto doveva avvenire, i nostri cuori parvero fermarsi. Bello era dimostrare che il carcere non aveva fiaccato lo spirito degli antifascisti, scrollare di dosso, una volta tanto, il peso del regolamento carcerario, dar sfogo alla prepotente volontà di urlare, di cantare di sentirsi vivi, più vivi.
Il silenzio si ruppe d’un tratto. Una voce giovane, argentina. S’innalzò da una cella intonando <<compagni, avanti, il gran partito …>> centinaia di voce ripresero la strofa: <<noi siamo dei lavoratori…>>. Il poderoso canto si elevò solenne, rimbombando per tutti i bracci del carcere, salendo verso il colle che ospita i monumenti a Garibaldi e ad Anita.
Come una frustata, un grido lacerò l’aria, ancora piena di canti: <<Aiuto compagni, mi ammazzano!>> L’invocazione ci giungeva da una cella del piano sottostante. <<Assassini, lasciatelo! Vigliacchi!>> urlammo da ogni cella. Poi seguì una baraonda infernale. Nella mia cella Antonini, un robusto operaio romano, si lanciò contro la porta, per sfondarla; l’urto poderoso fece volar via lo sportello dello spioncino: certamente non era stato chiuso per sorprenderci mentre cantavamo. In qualche modo la direzione aveva saputo delle nostre intenzioni. Pare che nelle altre celle accadesse quanto avveniva da noi: il frastuono degli sportelli che cadevano un pò dappertutto sui ballatoi aumentava la confusione. Ormai erano più di tremila detenuti che urlavano e chiedevano che le porte venissero aperte. Canti, grida, strepiti, vetri infranti, <<gamellini>> e buglioli che volavano con orribile fracasso mentre i secondini si affannavano a implorare di smetterla, ci giuravano che il compagno che aveva gridato aiuto era stato lasciato in pace e non correva più alcun pericolo.
Poco dopo arrivarono al carcere i primi plotoni di milizia, carabinieri e marinai e lentamente ritornarono calma e silenzio.
Il 9 novembre i primi gruppi di politici amnistiati lasciavano il carcere. Andavano a riprendere la lotta fino alla caduta del fascismo: questo era l’impegno che tutti, prima di lasciare il carcere, si scambiarono.
Rimasero solo alcune decine di detenuti, quelli ritenuti più pericolosi, Tra questi il gruppo di antifascisti anconetani di cui facevo parte. Dovevano passare altri quaranta giorni prima che si decidessero a rilasciare anche noi in quella libertà vigilata che si godeva in Italia fino a che il fascismo non cadde sconfitto.
Raffaele Maderloni ( Raffa)


2 La storia di Raffaele Maderloni.
Al giornale “Bandiera Rossa” – ANCONA
Con preghiera di pubblicazione 1-2
Titolo: Ancora una precisazione sul “caso Maderloni”.
La Commissione Regionale Marchigiana per la qualifica di partigiano ha risposto come doveva all’articolista del “Lucifero”. MADERLONI RAFFAELE E’ PARTIGIANO COMBATTENTE. Ciò è documentato. Rimane da fare un’altra precisazione e cioè quale fu la mia attività politica prima dell’otto settembre 1943 e quale fu la causa che motivò la mia espulsione dal P.C.I.
3 Leggi tutto……..Copia e incolla per leggere il libro
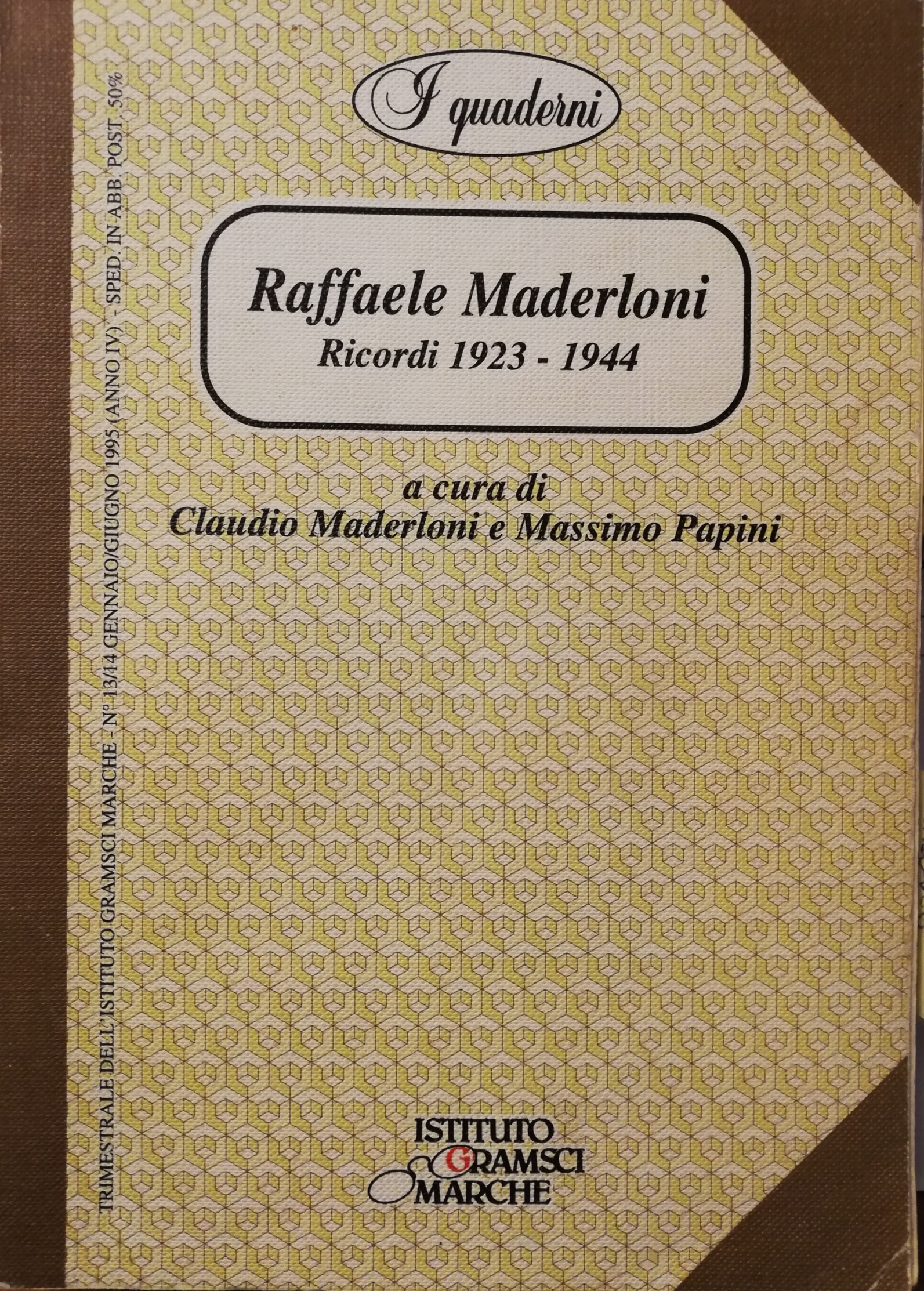
https://istitutogramscimarche.it/wp-content/uploads/quaderni-gramsci/13-14.%20Raffaele%20Maderloni%20UNICO.pdf
di seguito il libro
Dedicato alla memoria di mia madre morta nel 1942, preconizzandoci la vittoria
1923
Sprazzi di luce s’alternano al buio
Lasciando negli occhi il barbaglio del disorientamento
Nel buio, false o nichilistiche voci emergono, mentre la bufera, d’intorno sempre più rugge.
La nera barbaria semina odio e violenza
Che fa crescere sempre più forte l’amore per la verità.
Matteotti, Gramsci ed altri mille martiri cadono, idee che riscaldano il sangue impedendone il raggrumo
1932
L’università ha cambiato sede ed è piena di cimici,nella cella manca l’aria ma, aguzzino, della morte mi hai dato la vita rendendo la mia fede contagiosa.
Batti! Picchia o brigante! L’alba verrà, l’aurora darà un colore ai miei stracci e tu tremerai dalla paura.
Lo spirito evade dall’inferriata, e spazia nell’infinito ebbro di verità che non puoi bruciare come fai con L’Unità
1936
C’è polvere di tutti i paesi d’Italia nella “cella di transito” e c’è scritto: “tira il giusto anello della catena, compagno, vincerai”.
Le carceri, tutti nomi di santi e la Regina Coeli, la “squadretta” di Napoli, Ponza e Ventotene, ma il cuore sempre pieno di benedetta speme.
Compiti la tua prima lettera o donna?!
Ciò che non vide l’antico borgo natio, s’avvera ora, sotto l’influsso del nuovo che preme,
Cammina o Madre, ora stai con le figure del Gorkij.
Vedrai l’essenza di te stessa,e comprendendo vivrai
1943
Vent’anni ed altri enti quaranta; le ore più belle di una santa battaglia che ha dato,un senso alla vita, altrimenti destinata a passare senza aver vissuto.
Presentazione
di Claudio Maderloni
Si sedevano attorno ad un tavolo nella nostra casa a Valle Miano, ed iniziavano interminabili discussioni. Erano i “compagni” di mio padre, quelli che avevano condiviso anni di lotte, di sacrifici, di gioie e di amarezze, sia durante la clandestinità che nella lotta partigiana.
Iniziavano sempre dalle questioni politiche del momento ma finivano inevitabilmente con il parlare dei ricordi.
Quelle storie mi hanno sempre affascinato. Erano storie che parlavano di uomini e donne in carne ed ossa, storie piene di angosce, di gesti semplici che a me sembravano eroici.
Dai loro racconti sentivo molta amarezza, per un fatto in particolare che era accaduto dopo la liberazione, e alcune frasi mi sembravano troppe dure, e non riuscivo a capire.
All’età di sedici anni, come iscritto alla F.G.C.I.: frequentavo la Federazione Provinciale ed ho cominciato a chiedere spiegazioni sulla vicenda di mio padre che dopo tanti anni veniva ancora definita il “caso Maderloni”.
Il tempo passava ed io conoscevo la storia di mio padre attraverso i suoi scritti e i racconti di quei compagni, ma mi mancava la parte ufficiale quella che sicuramente doveva stare negli archivi del partito.
Molti furono i no, i non conosco, i non ricordo.
Riuscii a convincere mio padre a sistemare i suoi ricordi e ne facemmo 40 copie, ma per la pubblicazione non voleva saperne perché non voleva dare un’arma agli avversari da usare contro il partito.
Doveva diventare Segretario della Federazione del PCI Augusto Burattini (1989) perché potessi vedere il materiale, e leggere documenti inediti che riguardavano mio padre che lui stesso non aveva mai potuto vedere, come una lettera inviata dal Segretario della Federazione di Taranto che scriveva al Segretario della Federazione di Ancona ricordandogli il viaggio e l’arresto a Milano nel 1926.
Durante alcune presentazioni del libro “Ottavo chilometro” scritto da Caimmi
Wilfredo e Antomarini Edo molti volevano sapere di quella storia e soprattutto compagni anziani mi chiedevano perchè non venissero pubblicate le memorie di mio padre. Tutti comunque mi confortavano dicendomi di andare fiero di Raffa, che li aveva aiutati a diventare prima di tutto uomini liberi.
Sono convinto che la storia di mio padre sarebbe stata sicuramente un’altra se non avesse avuto al suo fianco una donna come mia madre Rinalda.
Questo lavoro dovrebbe essere dedicato a molte compagne e compagni, ma credo che solo lei possa dire quanto sacrificio gli è costato stare accanto all’uomo che ha amato.
Ed è a lei che lo dedico anche perché in tutto il libro non viene mai menzionata se non per aver risposto di no alla richiesta del partito di lasciare suo marito.
Una donna che resta sempre al suo fianco, nei momenti belli, ma soprattutto in quelli più brutti, che lavora giorno e notte per non far mancare nulla ai suoi figli, per dare dignità alla sua famiglia, che ringrazia il partito di averla fatta diventare una protagonista della storia anche se non viene mai menzionata.
Credo che questo libro possa in qualche modo ristabilire una verità, e riscattare tanti compagni, ne cito uno per tutti, Aldo Pelliccia che è rimasto sempre vicino a mio padre anche quando le circostanze non lo consigliavano.
Un ringraziamento all’Istituto Gramsci Marche.
Introduzione
di Massimo Papini
Ci possono essere tanti modi di leggere le memorie di Maderloni e tutti di grande interesse. Alcuni in particolare. C’è innanzitutto l’autobiografia, che oggi è un genere letterario e storiografico giustamente valorizzato. C’è una testimonianza di primo piano sulla storia del Partito comunista italiano e di quello anconetano in particolare. C’è infine uno spaccato della storia di una città, quella dorica, vista con gli occhi dell’abitante dei quartieri popolari. E proprio da questa angolazione si può partire per avviare un percorso (che ho già intrapreso in un precedente numero di questi “Quaderni”) attraverso le tappe della sua vita e i meandri della sua indubbia personalità.
Ritroviamo allora Maderloni negli anni della sua giovinezza per le vie di un’Ancona normalizzata dal fascismo. La vita sembra scorrere tranquilla. La piccola borghesia del centro e la borghesia del nuovo quartiere adriatico si sentono ben tutelate dal regime e a esso, nonostante a volte ci si infastidisca per certe eccessi di folclorismo nelle sue manifestazioni, esprime il proprio consenso. Del resto il fascismo ha fatto molto per la città, le ha dato un volto “moderno” ed efficiente, ha creato servizi e strutture di pubblica utilità, ma soprattutto le ha dato ordine e tranquillità.
Sì, si respira una tale aria di pace e sicurezza che chi ha vissuto gli anni precedenti l’avvento del fascismo ricorda quasi come un incubo i continui scioperi e tumulti, la violenza fisica e verbale di chi, pur di origini proletarie, esprimeva senza timori la propria arroganza e la propria indole sovvertitrice. Ora, invece, si può passeggiare senza timori per le vie della città, persino nei rioni popolari, dove, an-zi, la sera la gente si chiude in casa. Il “popolo”accetta senza rancori le differenze sociali, ossequia i benestanti e le autorità e, se qualcosa non va, mormora sottovoce il proprio disappunto.
Sovversivi ce ne sono ancora, per la verità, (e del resto Ancona è stata “rossa” per tanto tempo), ma non disturbano la quiete, la polizia li tiene sotto controllo e quando c’è qualche manifestazione del regime con la presenza di gerarchi, finiscono qualche giorno in gattabuia, magari a giocare a carte con il secondino. E poi ora la polizia sa il fatto suo, li ha schedati quasi tutti, li segue, li fa spiare e, all’occorrenza, li arresta senza tanti problemi. E del resto, se per caso è successo qualcosa, i giornali neanche ne parlano. Sono notizie che restano riservate tra la Questura, la Prefettura e il Partito.
Ma se questa è la facciata, vi è anche una realtà poco nota che cova sotto la cenere. Ogni tanto la città si sveglia e sui muri si trovano scritte che inneggiano al comunismo e che disturbano l’immagine di una città ordinata. Per quanto si faccia di tutto per cancellarle il più rapidamente possibile, la notizia passa di bocca in bocca.
Qualcuno, chissà chi, sta operando contro il fascismo, non può venire alla luce, marano i messaggi che egli intendeva diffondere con dei fogli ciclostilati, che a rileggerli oggi ci sembrano quanto meno velleitari e utopistici.
Ma allora non possiamo fare a meno di soffermarci un attimo di più sulle molle che spinsero uomini come Maderloni a perseverare, contro ogni logica e affrontando disagi e sofferenze, nella lotta antifascista. E oggi dobbiamo farlo non solo con ovvia gratitudine, ma anche con una onestà morale e intellettuale che ci permetta di capire un po’ di più la realtà di questo “secolo breve”.
Diremo più avanti qualcosa sul personaggio Maderloni, sul suo carattere e sulla sua incoscienza, ma ora ci preme riflettere un po’ di più sulla molla politica e associare “Raffa” (come veniva chiamato dai “compagni”) a tanti altri giovani come lui, e certi ancora più “esaltati” di lui, come quell’Adelmo Pianelli che preferisce restare in carcere e rifiutare l’amnistia per poter testimoniare apertamente il suo essere comunista. Questa “parolaccia”, infatti, non dirà forse più nulla agli uomini del duemila, ma è ora che riacquisti quel rispetto e quella giusta collocazione nella memoria storica, perché se tante volte è stata associata a regimi repressivi e totalitari, tante altre è stata associata alla dignità e alla liberazione dell’uomo.
E allora diciamo subito che la vita, la testimonianza anche eroica di Maderloni non ha alcun senso se disgiunta dal suo essere un militante del Partito comunista italiano, un militante che per lungo tempo è anche senza partito e che il “partito” gli infliggerà un’umiliazione dolorosissima proprio nel momento in cui gli avrebbe dovuto mostrare la sua riconoscenza. E diciamo che tanti come lui hanno continuato anche nei momenti più duri perché sapevano che da qualche parte, in Italia o all’estero, a Parigi o a Mosca, vi era il Partito, vi era Ercoli e altri come lui, perché vi era l’Unione sovietica, che tutto il mondo temeva e rispettava, e perché vi era Stalin che, come disse una volta Amendola, con la sua “tempra d’acciaio”, che ricordava il terrore giacobino, il proletariato non avrebbe più subito le innumerevoli sconfitte del passato.
E’ stata un’illusione, un tragico abbaglio? Sarebbe stato meglio rifugiarsi all’estero, magari in un territorio neutro come la Svizzera, e aspettare la conclusione dei tragici eventi che hanno portato con la guerra alla fine dei fascismi? Allora sì che avrebbe avuto ragione De Felice, e altri con lui, a vedere nell’8 settembre la fine senza riscatto della dignità nazionale. Vi è stata invece una minoranza che ha riscattato, con la coerenza del proprio antifascismo, l’onore del paese, anche se questa minoranza era fatta per lo più di gente”pericolosa” e un po’ “fanatica”. E quando gli inglesi risalirono la penisola, pur con tutto il rancore che avevano per gli italiani dovettero riconoscere, come ha ricordato lo storico Seton Watson nel suo diario di guerra, che nei centri affidati all’amministrazione alleata i comunisti erano i soli su cui si potesse contare per far funzionare le cose.
Da quel momento cominciarono a vederci con occhi un po’ diversi.
Con ciò ovviamente non si vuol fare l’apologia acritica dell’antifascismo né identificarlo con i comunisti, si vuole semplicemente ristabilire uno sguardo obiettivo allorché il cosiddetto revisionismo storiografico (che pure ha meriti nel voler rivedere luoghi comuni di una certa “vulgata”) insiste nel voler mantenere vivo un anti-comunismo che per tanti anni (e ancor oggi) è stato assai più di una “vulgata”. Sottovalutando inoltre le peculiarità della storia del PCI, o snobbandole (come Furet) o negandole alcuna autonomia, riducendo tutto a tatticismo e a esecuzione di ordini da Mosca, non si offre affatto un servizio alla “verità storica”.
Tanto più che oggi lo svilupparsi della memorialistica e delle ricerche biografiche ci offre un quadro meno ideolicizzato e più reale dei militanti comunisti, sia per quel che riguarda i personaggi più isolati, un po’ avventurosi, un po’ workingclasshero come Maderloni, sia per i quadri di partito, dell’apparato, i “rivoluzionari di professione”, quelli che un po’ enfaticamente Hobsbawm ha paragonato ai monaci e ai cavalieri del Medioevo. Ne emerge un quadro sicuramente meno schematico e omogeneo di quel che si è comunemente pensato per tanto tempo. Certo, la consapevolezza di dover raggiungere grandi obiettivi nel massimo delle difficoltà portava ad una eccessiva fiducia nella disciplina e al suo perpetuarsi anche in contingenze lontane dalla clandestinità, ma non vi è dubbio chela lotta antifascista, anche per chi democratico non era sul piano ideologico, educava i “rivoluzionari” e li conduceva a porre, nel quotidiano operare concreto, la democrazia tra i propri obiettivi primari.
Se dunque l’8 settembre segna, per dirla con Giaime Pintor, “l’ora del riscatto”, che fa sì che l’Italia non si identifichi con “il popolo dei morti”, questo momento è possibile perché vi è chi, come Maderloni (ma anche come Cappellini, Maniera, Zingaretti e tanti altri), ha tenuto duro per tanti anni. Ma “Raffa” aggiunge qualcosa di nuovo e forse di più ai sacrifici degli altri”compagni”. Ha dovuto fare i conti con la disperazione, si è trovato in uno stato di disoccupazione pressoché cronica, nonostante la vicinanza e la solidarietà concreta di alcuni amici. Non ha trovato chi era disposto a dargli lavoro, neanche tra gli stessi abitanti dei quartieri popolari, e quindi ha dovuto fare i conti con i morsi della fame, con la miseria più nera. Ma soprattutto ha dovuto arrangiarsi perché il partito era assente, mancavano direttive e il PCI se lo doveva fare lui, da solo o con qualche altro disposto a rischi e sacrifici.
Del resto il partito lo conosce poco, o almeno quello che ha conosciuto è diverso da quello che si è formato all’estero, tra scontri interni, epurazioni e una rigida disciplina “leninista”. Lui stesso ricorda che “dopo il Congresso di Lione e le leggi eccezionali del 1926 non avevamo più avuto modo di sapere chi incarnava fisica-mente il nostro partito, avevamo sentito i nomi di
Antonio Gramsci, Mauro Scoccimarro e Umberto Terracini in carcere e al confino ma di questi compagni non conoscevamo il valore politico”.
Il partito che Maderloni ha conosciuto è dunque quello di cui, prima dell’avvento del fascismo, aveva sentito parlare nei caffè o al cantiere navale, al Guasco o a Capodimonte, magari in interminabili discussioni con gli anarchici; è quello che poi ha incontrato al carcere o al confino, fatto di esaltazione collettiva nel mito di una Unione sovietica pronta a riscattare il proletariato di tutto il mondo. Ma lui la realtà non la conosce, sa solo che, proprio perché esistono il PCI e l’URSS, il fascismo sarà sconfitto e anche in Italia i proletari potranno prendere il potere.
E poi “Raffa” è un ribelle per natura. E’ cresciuto per strada e all’orfanotrofio.
Non è diventato comunista perché il materialismo storico gli ha dato gli strumenti per comprendere la realtà (che persino i giornali del partito ricorda di averli diffusi ma non letti), ma molto più semplicemente perché ai primi di agosto del ’22, ancora ragazzo, ha visto quello che hanno fatto le squadre fasciste in Ancona e ha cominciato a odiare i nuovi padroni, il loro essere strumento dei veri padroni per schiacciare la volontà di riscatto del proletariato. E allora, ce lo dice lui stesso, ha visto che il PCI era il più conseguentemente antifascista, ben più di quegli anarchici che avevano sempre chiacchierato tanto ma che poi erano spariti. Certo, per lui, forse la disciplina di partito era un po’ eccessiva, ma in fondo era la benvenuta in una prospettiva di guerra totale con il fascismo.
C’è poi da aggiungere che la “vecchia guardia” non c’è più. I dirigenti che erano stati a Livorno, che avevano fondato il partito non ci sono più. Corneli se ne è andato in Argentina, Zingaretti è stato massacrato di botte, tra i giovani Maniera e Del Duca hanno dovuto riparare in Francia, di altri come Rosini non ha forse neppure sentito parlare, ha conosciuto la Breviglieri, ma di sfuggita. Tocca quindi alla seconda generazione, a quelli come lui, rimettere in piedi il partito, e quando Canafoglia, il muratore che si è preso cura di lui, gli assegna questo incarico, non gli sembra vero.
E a quel punto se la dovrà sbrigare da solo. Non può essere certo un “edile” a dargli la linea! Non ha punti di riferimento se non saltuari e vaghi. Gli resta solo “la sensazione – come scriverà nei ricordi – di partecipare a qualcosa di grande”.
L’avventura di Maderloni dirigente è alquanto singolare e assai diversa da quella di altri che oltre ai rigori della clandestinità hanno passato i travagli delle lotte intestine al movimento comunista internazionale. Nei suoi ricordi non c’è eco di fratture tragiche come quelle della “svolta” o delle violente contrapposizioni con i trotzkisti.
Non c’è neppure ombra di quel “sospetto” anche ideologico che avvolge l’attività dei compagni nella clandestinità, Tutto è molto più provinciale e artigianale. Anche la sua grande voglia di sapere e di conoscere non va al di là delle poche letture che riesce a fare (quei pochi libri che gli consiglia l’amico “intellettuale”, Ruggero Giannini, e che si riescono a trovare) descritte ampiamente in una delle pagine più interessanti delle sue memorie.
Ciononostante “Raffa” si dimostra un buon organizzatore e soprattutto un trascinatore. Coinvolge diversi giovani con un ‘immagine del dirigente clandestino assai inusuale rispetto a quella tradizionale del cospiratore che si muove circospetto e che prende innumerevoli precauzioni. Le testimonianze di chi lo ha conosciuto concordano sul suo atteggiamento un po’ troppo spregiudicato e poco attento alle norme della clandestinità. I vecchi “compagni” come Lodovichetti o Galeazzi, o i nuovi al confino, gli consigliano prudenza, ma inutilmente.
Mentre fa il bigliettaio nel tram o mentre passeggia per la città non si tira indietro quando ha da dire la sua. Ma del resto lo conoscono un po’ tutti e la polizia, dopo il primo arresto, lo tiene sempre sotto controllo.
Ma è proprio il suo atteggiamento che affascina ed entusiasma i giovani e se in altre situazioni e soprattutto in presenza del partito, quello controllato dal Centro, sarebbe stato considerato “bruciato” e di lui si sarebbe diffidato, in Ancona diventa il riferimento per tutti coloro che vogliono fare qualcosa contro il fascismo. E, non si riesce a capire come, alla vigilia della guerra abbia messo in piedi un’organizzazione che ha del prodigioso, tanto da indurci a qualche riflessione.
Era il sistema repressivo del regime, almeno in Ancona, così debole (nonostante ciò contraddica i risultati delle ricerche di uno studioso come Ruggero Giacomini), da non riuscire a impedire a un noto comunista di mettere in piedi un’organizzazione clandestina tanto ben strutturata e capillare sul territorio? O Maderloni fu così abile da passare per le maglie dei controlli polizieschi senza essere scoperto? A mio avviso ambedue le cose, ma vi è forse una terza verità, una sorta di via di mezzo tra le due precedenti, che coinvolge anche la questione dei piccoli finanziamenti che Maderloni ricevette dalla Questura e che dopo la liberazione gli procurarono l’espulsione dal partito. Non c’è dubbio allora, e qui De Felice non ha tutti i torti, che il sistema repressivo del fascismo non fu poi così feroce e violento come quello di altri paesi e di altri sistemi. Molto spesso, soprattutto quando gli antifascisti erano noti e avevano già passato il carcere o il confino, e venivano considerati delle teste calde più che dei veri dirigenti del Partito comunista, ci si accontentava di controllarli e di impedire loro di turbare l’ordine pubblico. Anzi, proprio per questo, allorché il soggetto, trovandosi in situazioni economiche disperate, avrebbe potuto compiere gesti inconsulti, per motivi di ordine pubblico veniva sovvenzionato e, si pensava, in un certo modo ammansito. Non fu così impossibile a “Raffa”, soprattutto dopo lo scoppio della guerra, allorché le maglie del controllo si furono allentate, avere una struttura che si rivelerà pronta a intervenire dopo la caduta di Mussolini.
Restavano problemi con il resto del partito, quello”ufficiale”, che si rivolge a Zingaretti e cioè al vecchio fondatore che ha fatto il sarto in apparente silenzio.
Maderloni non si dimostra sereno nei suoi confronti, dimostra di avere ancora risentimento per i compagni che non sono stati dalla sua parte, e così non si rende conto della parzialità della sua verità, del fatto cioè che egli non poteva essere a conoscenza dei comportamenti, e soprattutto delle motivazioni, che gli “altri compagni” avevano deciso di tenere in clandestinità.
Ciononostante come ho accennato, le memorie hanno un indubbio valore testimoniale e ci aiutano a riscoprire la mentalità e la cultura dei comunisti che fecero la guerra al fascismo e la resistenza. Meno “attuale” è ovviamente il testo allorché si dilunga in analisi politiche ed economiche fortemente ideologizzate, e meno felice in quei rari momenti in cui Maderloni non trattiene il rancore e dà (o meglio, ricambia) giudizi pesanti o va alla ricerca di particolari che non nobilitano la memoria di altri comunisti. Certo, ciò è comprensibile alla luce del comportamento del partito nei suoi confronti, allorché nel novembre del 44, a quattro mesi dalla liberazione di Ancona, venne espulso. La vicenda la racconta lui stesso e questi ricordi hanno anche il valore di un’autodifesa sicuramente credibile, tanto che due anni dopo venne riammesso nel partito.
Ma ciò che più colpisce il lettore oggi non è tanto il fatto in sé, che appare comprensibile solo se riportato nella temperie di quegli anni, né il clamore che fece, giustificato dal fatto che la guerra e la resistenza al nord erano ancora in corso, quanto la vastità delle passioni che aveva scatenato. Da una parte un partito che soprattutto doveva difendere l’immagine che si era conquistato nell’eroica lotta di liberazione e che qualche forza politica,strumentalizzando l’episodio, non avrebbe disdetto scalfire, dall’altra una base di militanti che si ribellarono alla decisione o perchè non credevano alle motivazioni dell’accusa o perché a “Raffa” erano pronti a giustificare qualsiasi cosa. Ma tutti coinvolti soprattutto da una reazione emotiva nei confronti del personaggio Maderloni.
Egli infatti non aveva molto della visione tradizionale del dirigente comunista, e ciò veniva avvertito in modo immediato: troppo passionale, troppo “rivoluzionari-sta”, troppo poco incasellabile nel militante obbediente e sempre in linea. Rompeva con la mitologia del combattente antifascista, del comunista tutto d’un pezzo non tanto sul piano ideologico, quanto soprattutto su quello esistenziale, o meglio, dell’immagine. Piaccia o no ancora oggi non suscita atteggiamenti indifferenti, chi poi lo ha conosciuto lo ricorda o con grande affetto e devozione o con silenzi eloquenti che lasciano intravedere una mai cancellata avversione. Per questo possiamo concludere che ci troviamo sicuramente di fronte a un “personaggio”..
Già questo basta per ringraziarlo. Se non altro perchè smentisce l’immagine del comunista privo di personalità, tutto apparato e niente umanità. Con buona pace dei luoghi comuni che ancora ci tormentano alle soglie del duemila.
Ricordi 1923 – 1944 di Raffaele Maderloni
Premessa
Da vari anni mi perseguita l’idea che dovrei scrivere i casi della mia vita. Non mi sono mai deciso a farlo perché ho sempre pensato che in fondo non ne valesse la pena se ciò deve essere fatto per informare la pubblica opinione che giustamente si disinteressa dei miei casi.
Vivo un periodo durante il quale i “memoriali” si sono sprecati. Molta gente li ha pubblicati per spiegare le proprie vicissitudini, per giustificare il proprio operato, il proprio atteggiamento politico, militare, ecc. Credendo di dire, di far sapere, forse, qualche cosa di eccezionale, di diverso, di interessante per gli “altri”.
A torto o a ragione ho sempre dato poca importanza a quello che gli “altri” potevano pensare su quello che dicevo o facevo. Per gli”altri” naturalmente intendo tutti fuorché i miei compagni di fede, la mia famiglia, i miei figli.
Mi appresto a scrivere queste note proprio per questi ultimi, penso di doverlo fare solo per loro, perché ho bisogno di sentire che avrò sempre la loro stima. Fra pochi anni saranno tutti e quattro grandi, uomini e forse saranno posti nella necessità di conoscere la verità su quanto mi è accaduto ed io ho il dovere di informarli anche perché ne traggano insegnamento.
Quindi è soltanto per loro che scrivo e rievoco la mia vita. Non mi sarebbe mai venuto in mente di farlo se non mi avessero brutalmente provocato.
La mia modesta origine di operaio e soprattutto la mia elementare cultura mi avrebbero sempre tenuto lontano da certe tentazioni “letterarie”.
Soltanto alla tentazione di scrivere contro il regime fascista non ho saputo resistere, ma mi è stato imposto dalle circostanze che man mano andrò esponendo, e perché l’ho fatto di mia volontà, il prezzo pagato per aver scritto e stampato contro la tirannide non mi sembrò eccessivamente caro, come cara invece ho pagato la mia buona fede.
Ancona, 1954
Presentazione
La mia è una semplice storia, potrebbe essere scritta da qualche centinaia di giovani operai che dovettero, sin dalla loro adolescenza, scontrarsi con la violenza del fascismo.
Ho scritto i casi della mia vita in seguito ad un episodio in cui mi trovai avviluppato, come una mosca in una ragnatela, nel dicembre 1944.
Ero talmente impreparato a tale caso che non fui capace di difendermi adeguatamente.
Dopo il 18 luglio 1944, con la Liberazione di Ancona, a pieni polmoni respiravo la particolare atmosfera della nuova situazione creatasi con il crollo definitivo del fascismo.
Ero intento a dare il mio modesto contributo alla ricostruzione della città distrutta da centinaia di bombardamenti, quando dovetti sostenere una battaglia, non contro il nemico di classe, anche se non era da escludere il suo zampino, ma dal pregiudizio, dal settarismo nato nel clima di sospetto, di diffidenza, dovuta alla ventennale lotta clandestina contro il regime poliziesco del fascismo, talché un normale episodio assunse, nella mente di chi poco conosceva delle cose d’Italia del ventennio, proporzioni mostruose.
Era giusto che dopo vent’anni di lotta clandestina,senza quartiere, ognuno dei partecipanti dovesse rendere conto del proprio operato, scelto volontariamente. Bisognava rendere trasparente ogni posizione assunta, nel tempo, sottoporla alla critica e all’autocritica in una atmosfera di libertà, di democrazia, di giustizia conforme alle leggi, e ai regolamenti statutari, in modo oggettivo, senza lasciarsi influenzare dalle condizioni del presente, sull’onda del successo favorevole. Invece si volle agire rapidamente, in modo sommario per arrivare ad una conclusione ingiusta, sbagliata. Difficilmente recuperabile, che comunque suona come una condanna definitiva.
Questo dattiloscritto doveva dormire per sempre in un cassetto, ecco perché non è stata curata la forma. Lo affido a mani amiche perché dalla lettura e dalle testimonianze possano rendersi conto della verità.
Ancona,1975
Viaggio interrotto – in carcere
Verso la fine della seconda decade di gennaio del 1926, le porte del carcere giudiziario S. Vittore di Milano si chiusero alle mie spalle, e a quelle di altri due giovani compagni:
– Quinto Amadori, falegname, residente a Pesaro, anni 16;
– Salvatore Resta, operaio, residente ad Andria (Puglia), anni 18.
Io da qualche mese avevo compiuto il 19° anno di età.
Il mattino di quel giorno eravamo stati arrestati dalla polizia politica mentre salivamo al secondo piano di uno stabile situato in via Napo Torriani n. 7 a Milano, dove a quell’epoca aveva sede la redazione del giornale “l’Unità”, organo ufficiale del Partito Comunista d’Italia.
Tutti e tre eravamo stati delegati a rappresentare le rispettive federazioni giovani-li comuniste delle nostre province al III congresso del P.C. d ‘Italia che doveva aver luogo (come infatti avvenne) a Lione in Francia.
Due giorni prima, come molti altri giovani provenienti da numerose province dell’Italia centrale e meridionale, ero giunto da Ancona a Bologna.
Il segretario della sezione comunista di Ancona, Arturo Medici, mi aveva detto: «Domani a mezzodì devi trovarti alla trattoria delle Due Torri, a Bologna. Qualcuno che già ti conosce, ti avvicinerà, vedi tu che cosa c’è da fare!».
Veramente lo stesso giorno avrei dovuto partire per Taranto, per essere regolarmente arruolato per il servizio di leva nella regia marina militare. Ma pensai che tutt’al più avrei portato un insignificante ritardo di un giorno o due.
Un po’ intimidito dall’ambiente frequentato da studenti universitari, il giorno dopo, alla trattoria Due Torri di Bologna chiesi da mangiare e mentre con molto impaccio, che rivelava la mia origine operaia, tentavo di utilizzare il coltello e la forchetta, con gran sollievo vidi in un tavolo vicino un viso noto. Era il compagno del centro del partito che qualche mese prima, nel 1925, aveva presieduto il nostro congresso provinciale giovanile comunista avvenuto clandestinamente nella trattoria del “Gobbo de Taiarì” un locale isolato alla periferia di Ancona nei paraggi delle “Rupi di Galina”.
Poco più tardi, Bruno – tale era il suo nome di battaglia – uscì dalla trattoria facendomi cenno di seguirlo e poco dopo mi ritrovai con numerosi altri giovani delegati e tra questi quelli di Bari, Lecce, Taranto.
Il “funzionario” (che secondo il compagno Gennazzini Gino di Pesaro presente a quella riunione si faceva chiamare “Poggi” ma che sarebbe stato il compagno Luigi Longo, allora responsabile della gioventù), ci riunì in gruppi di tre ed io capitai con il Resta e l’Amadori. Per l’intero gruppo mi consegnò £. 500 e senza dirci nulla circa i motivi della nostra presenza in Bologna, ci comunicò che l’indomani avremmo dovuto prendere ad una certa ora iltreno per Milano dove avremmo ricevuto altre indicazioni e intanto ci invitò ad andare a dormire nelle rispettive camere già stabilite onde deviare i pericoli che avrebbero potuto minacciarci gironzolando per Bologna.
Rivedemmo “Bruno” il giorno dopo al treno. Ci comunicò che non appena scesi alla stazione di Milano, dovevamo salire su un treno in partenza per Torino. I biglietti per il nuovo percorso dovevamo farli in treno.
Poi aggiunse: «Scendete a Chivasso, fuori della stazione c’è una piazza, poi un viale all’inizio del quale troverete una “birreria”. Entrate ed attendete».
Così facemmo, sicuri che così fosse perché vedemmo scendere alla stazione di Chivasso anche il gruppo composto dai delegati di Lecce, Bari e Taranto. Con il delegato di quest’ultima città, il compagno Giuseppe
La Torre il giorno prima avevo avuto uno scambio di idee e il suo indirizzo per poter trovare nella sua città, dove appunto, come ho detto, avrei dovuto recarmi per ilservizio militare.
Giunti a Chiasso, imboccammo il viale, vedemmo una specie di trattoria, pensando che fosse la “birreria” indicataci entrammo e attendemmo gli eventi. Purtroppo soltanto tre mesi dopo dal compagno La Torre, ad una riunione a Taranto, seppi che saremmo dovuti entrare in un piccolo albergo situato nella piazza della stazione ferroviaria.
Con pazienza attendemmo tutto il giorno senza muoverci da quella “osteria” e non vedendo alcuno la nostra inquietudine aumentava ogni ora. Sul far della sera, preoccupati di aver sbagliato paese e poiché nel suo discorso “Bruno” aveva accennato a Santià, un paese vicino a Chivasso, tutti d’accordo decidemmo che mi portassi a Santià. Ritornai sconsolato. Decisamente il paese indicato da”Bruno” era Chivasso. Girammo a turno queste paese, con la speranza di incontrare qualche compagno, poi decidemmo di andare a letto e al mattino stabilire il da farsi.
Il mattino dopo, non essendosi verificate novità, decidemmo di tornare a Milano, presentarci alla redazione de “l’Unità” in via NapoTorriani, indirizzo questo che leggemmo in una copia del giornale che acquistammo a Milano e consigliarci con quei compagni.
Così facemmo con il risultato che mentre salivamo le scale vedemmo la “lucerna” dei carabinieri che scendevano, pensammo che avessero visitato la redazione, riscendemmo, uscimmo dal portone, ci infilammo in un bar dietro 1’angolo della strada, ma subito dopo entrò un tale che qualificandosi “Commissario di P.S.” ci fece uscire dal locale, ci fece salire su un furgone che rapidamente ci condusse alla questura di Milano.
Interrogati separatamente. Ciascuno si difese per proprio conto. Intanto non ci conoscevamo, eravamo arrivati la stessa mattina dal sud. Io dissi che mi trovavo a Milano per salutare dei parenti prima di partire per Taranto a fare il soldato, ma che di questi avevo perduto l’indirizzo. Durante il viaggio verso la questura mi era riuscito di far sparire il biglietto ferroviario, testimone che venivamo tutti e tre da Chivasso mentre non mi era riuscito di gettare la copia de “l’Unità” che mi trovarono in tasca.
Me la cavai dichiarando di averla acquistata alla stazione di Piacenza dove avevo chiesto ad uno strillone un giornale qualsiasi.
Nessuno dei tre comunque potemmo dire la verità per il semplice fatto che ignoravamo assolutamente dove eravamo diretti ed eravamo mille miglia dal pensare che dovevamo attraversare clandestinamente la frontiera italo-francese per essere presenti al III Congresso Nazionale del Partito Comunista d’Italia che si sarebbe svolto a Lione.
Terminato l’interrogatorio ci consegnarono alle guardie di custodia del carcere giudiziario S. Vittore di Milano.
Mi rividi con i compagni Amadori e Resta due o tre giorni dopo, all’”aria” nei cubicoli. Vi erano altri detenuti e tra questi uno dei fascisti imputati dell’assassinio dell’On. Giacomo Matteotti. Costui, un macellaio, credo, un bestione alto, gigantesco, giurava, parlando con altri detenuti, che avrebbe strozzato il primo comunista che avesse incontrato per strada (credo che fosse o Dumini o Malacria). Non nascondo che eravamo preoccupati fosse venuto a conoscere la nostra qualifica di “politici”. .
Non ho rivisto più il compagno Resta, mentre nel 1941, in un giro di riorganizzazione del partito della regione marchigiana, durante un incontro con alcuni compagni di Pesaro nella frazione di S. Pietro in Calibano, essendo presenti un paio di vecchi compagni, chiesi se conoscevano il giovane compagno che nel gennaio 1926 era stato delegato a rappresentare la federazione giovanile al III Congresso. Amadori era tra i presenti ma non ci eravamo riconosciuti. Il tempo e il resto avevano cambiato i nostri connotati.
Il 7 febbraio 1926, dopo aver subito un sermone in questura di Milano venni rilasciato e munito di “foglio di via” venni spedito alla questura di Ancona, dove giunsi la notte con una fame da lupo.
In casa trovai mia madre in preda all’angoscia. Era stata informata del mio “fermo” a Milano e pensava alle cose più brutte. Nel vedermi si rasserenò e parve rinascere, mi accarezzò senza dirmi neppure una parola, senza un rimprovero.
Il giorno dopo mi presentai in questura per gli obblighi imposti dal “foglio di via”. Le formalità si svolsero rapidamente e senza alcun riferimento all’arresto di Milano.
A questo punto devo ricordare che nel febbraio 1926, le “leggi eccezionali” erano in gestazione, pertanto i partiti politici erano ancora “legali”, anche se la loro attività doveva svolgersi clandestinamente per evitare la violenza squadrista quasi sempre accompagnata dall’ appoggio delle forze dell’ordine.
A distanza di anni a questo racconto devo apportare una variazione: non eravamo affatto diretti a Lione per partecipare al III Congresso del P.C.d’I., ma a Candelo tra il biellese e il vercellese per partecipare al Congresso della Gioventù Comunista. Questa variazione è dovuta al fatto che tra le mani mi è capitato il volume I Comunisti raccontano, vol. I, Edizioni del Calendario, dove a pag. 90, 91 e 92 il compagno Berardo Taddei narra del suo viaggio da Teramo a Bologna per incontrarsi con il compagno Poggi al secolo Lorenzo Focon, allora interregionale del Partito. L’appuntamento sotto la Torre della Garisenda (mentre con me l’appuntamento era nella vicina trattoria delle DueTorri).
Poi il viaggio a Milano, Biella fino ad un casolare abbandonato nella periferia di Candelo dove il compagno Luigi Longo apre i lavori del Congresso che dureranno tre giorni e tre notti tra il 31 gennaio e il 3 febbraio 1926. Intervennero Berti, Dozza, D’Onofrio, Luciano Marchi, Antonio Roasio e fra gli altri anche il compagno Giuseppe La Torre di Taranto. Ho già detto come incontrando di nuovo La Torre ad una riunione di partito a Taranto, sentendo la sua relazione su quanto era accaduto a Lione, pensai in sostanza che nel viaggio che si era concluso al carcere di Milano, l’obiettivo era di raggiungere Lione. Date le circostanze non pensai affatto a chiedere ragguagli al compagno La Torre, con il quale avevo parlato a Bologna per incontrarci a Taranto e che avevo visto scendere a Chivasso. E questo aveva dato luogo all’equivoco che in omaggio alla verità ho inteso chiarire a distanza di vari anni.
Nella Regia Marina – “Lista nera”
Con una ventina di giorni di ritardo sulla data indicata dal Comando Marina, il 9 febbraio 1926, mi presentai come recluta al posto di guardia del Deposito Corpo Reale Equipaggi di Taranto.
Giunti regolarmente prima di me trovai numerosi compagni di Ancona, della mia stessa classe, tra questi ricordo: Volturno Pugnaloni, Remo Garbati, Ramiro Paniconi, Cafiero Cecili, ecc.
Dopo qualche giorno mi comunicarono che ero destinato al “Battaglione S. Marco”, un corpo speciale di fanteria da sbarco. Ancora qualche giorno, mi viene ordinato di presentarmi al Comando Marina. Qui il Capitano di vascello Falangola mi riceve e senza tanti preamboli mi avverte che sono stato segnalato dagli organi di polizia quale “sovversivo”. Non faccio in tempo a formulare una obiezione che egli continua: «Non c’è “ma” che tenga; se sarete veduto frequentare borghesi sospetti vi farò passare tutto il tempo della “ferma” (28 mesi) in carcere. Marsch!». Mi girai sui tacchi e uscii dall’ufficio.
Fin da ragazzo sapevo che un giorno avrei dovuto prestare il servizio militare. Il fatto di saperlo molti anni prima predispone l’animo ad accettare passivamente questo tipo di dovere, convinti che non ci si può ribellare, pertanto quando è giunta l’ora si accetta la nuova vita, così, come per destino, senza eccessivo malumore, ma presto mi convinsi che la mia vita “sotto le armi” sarebbe stata più dura del normale, specie quando intesi l’ufficiale capo delegazione venuto a prelevare il contingente destinato al Battaglione S. Marco, dire: «Questo delinquente rosso non lo voglio!». Nel mio fascicolo personale, dalla informazione della P.S. risultava la mia posizione di giovane comunista.
Passai i primi quaranta giorni come gli altri compagni, ma dopo la cerimonia del “giuramento”, ogni giorno all’assemblea del mattino udivo i nomi di amici e compagni che venivano trasferiti ai loro posti di servizio su torpedini, sommergibili, incrociatori, ecc., comunque se ne andavano dall’inferno del deposito, dalle grinfie del “Capo aiutante” il quale ogni 48 ore godeva nel chiamare per il servizio di picchetto: «Maderloni – Prima muta alla porta». Una mattina decisi di reclamare, ma non feci in tempo a fare il gesto per chiedere di parlare che Capo Bologna prorompe: «Se parli ti spacco la testa, bandiera rossa la vai a fare al paese tuo!».
Poi qualche giorno più tardi ricevetti l’ordine di sloggiare. Abbandonai il camerone delle reclute per raggiungere un camerone destinato ad una particolare categoria di marinai indicata col nome “Lista nera”.
Raggiunto il mio nuovo posto, tirai la branda e mi guardai attorno. Lo spettacolo era insolito. Lo stanzone occupava una sessantina di uomini con le rispettive brande. Lo strano consisteva nel fatto che questi vestivano le fogge più anormale per dei soldati.
Qualcuno aveva la divisa da marinaio, altri pantaloni da marinaio e giacca dell’esercito, altri ancora mezzo vestiti civili e mezzo militari. Uno, un livornese, certo Langella, aveva la giacca da fante e la cravatta della brigata “Regina”, cioè rossa.
In poche parole mi trovavo in un reparto composto di marinai provenienti dalle case di reclusione, dalle compagnie di disciplina che dovevano, dopo aver scontato la condanna, terminare il periodo di “ferma”, oltre che da marinai giunti alle “armi” già pregiudicati per motivi comuni o, come me, sospetti o già schedati come “sovversivi”.
Durante i primi mesi di questa nuova vita avevo notato che l’aiutante trattava altre due giovani reclute come usava fare con me. Qualche ora dopo anche questi due marinai raggiungevano lo stesso mio camerone. Mi ero ripromesso di stare attento ai provocatori e quindi stavo in guardia ma era tanto il bisogno di rompere l’isolamento che non esitai ad avvicinare questi due. Erano siciliani. Uno era un compagno – Vito Gafà studente di Chiaramonte Gulfi -l’altro un anarchico: Failla Alfonso, barbiere di Siracusa.
Raccontai la mia storia, essi la loro. Vito Gafà era uscito da poco dal carcere per aver tentato di varcare clandestinamente la frontiera a Chambery, Alfonso Failla anche egli già carcerato per aver rintuzzato violenze fasciste. Tutt’e due della classe 1906.
Naturalmente diventammo subito amici e sentivamo di essere estranei all’ ambiente nel quale eravamo immersi. I reduci dalla galera militare generalmente erano pieni di tatuaggi nel corpo, portavano baffi, barbe, basette alla “guappa”, così come “guappo” era tutto il loro atteggiamento. Raggruppati secondo la città o la regione erano sempre alle prese con conciliaboli misteriosi. Passavano il tempo a giocarsi i loro indumenti alle carte, sfidarsi al duello rusticano, qualche volta a ferirsi anche gravemente e spesso andavano in “franchigia” per rimediare con un “taccheggio” di un portafogli il denaro per le loro esigenze.
Qualche ufficiale cercò di portare un po’ di disciplina ma non riuscì mai a far fare a costoro esercitazioni militari e il bello è che pure noi in mezzo a loro dovevamo comportarci allo stesso modo. Non potevamo sottrarci all’influenza dell’ambiente.
Da appena tre mesi sotto le armi, durante una “franchigia” decisi di andare all’indirizzo avuto dal compagno Giuseppe La Torre nell’incontro di Bologna già narrato. Con Gafà e Failla partecipai a delle riunioni di partito e durante una di queste potemmo ascoltare una relazione del compagno La Torre, da poco reduce dalla Francia dove aveva partecipato al Congresso di Lione. Conoscemmo il compagno Voccoli, i fratelli Mellone, sarti, ed altri. Poi la “Lista nera” venne inviata per un lungo tempo all’isola militare S. Paolo, nel golfo di Taranto e quando venne riportata al Deposito, la reazione fascista aveva decapitato l’organizzazione comunista tarantina con l’arre-sto di numerosi compagni.
Al deposito continuammo a far perno per tutti i giovani comunisti anconitani sotto le armi e tra questi ricordo Ruggero Giannini, Adone Pierfederici, Adrio Andreatini e gli altri già indicati.
Il 24 aprile 1927, venni trasferito a bordo della Casermetta Arsenale di Taranto, ma il5 maggio seguente, mi respinsero di nuovo al Deposito per il fatto che il primo maggio manifestini antifascisti erano stati lanciati all’Arsenale Militare, al Cantiere Tosi ed in altri posti di lavoro. Poi ancora una volta la “Lista nera” venne confinata all’Isola di S. Paolo dove finalmente terminai il servizio militare e il 13 marzo 1928, congedato tornai ad Ancona.
Erano trascorsi 26 mesi, durante i quali avevo fatto un’esperienza. Con Gafà e Failla avevo corso il rischio di essere denunciato al tribunale militare per non essere stati tutti e tre presenti ad un’assemblea indetta per celebrare il “28 ottobre 1923”, ma a fare le nostre difese fu il Capo Aiutante Greco il quale dichiarando di avere esperienza dei giovani marinai, disse che tra questi i più disciplinati erano quelli indicati come comunisti, infatti noi tre non avevamo mai avuto una punizione.
Tomo ad Ancona nel marzo 1928. Nei rioni popolari, la sera, tutti gli abitanti si tappano in casa. A sei anni dalla “marcia su Roma” e a due dalla promulgazione delle “Leggi eccezionali” con cui sono stati sciolti e aboliti tutti i partiti di opposizione al fascismo, sembra che questi abbia avuto ragione dei suoi avversari.
Nel 1924, il delitto Matteotti aveva rivelato che il gigante poggiava su piedi di argilla e per provocarne il crollo sarebbe stata sufficiente l’unione dei partiti antifascisti che avrebbero così impedito al fascismo di portare l’Italia alla catastrofe. La mancanza di questa unione e peggio ancora, la discordia fra i partiti di opposizione, costituirono la base della forza del fascismo. Le leggi eccezionali (che sono una prova di quanto il fascismo si rendesse conto della propria debolezza) vengono applicate spingendo definitivamente i vari avversari del fascismo nella illegalità e obbligandoli all’ attività clandestina.
Gli anni 1926-27, sono quelli più infami perché ogni cittadino, a causa delle leggi eccezionali, è alla mercé della polizia politica ed amministrativa. Per non essere gettato in un’isola di deportazione, in galera, bastonato, comunque perseguitato, non essere ossequiente alla nuova legge che interdisce ogni attività contro il fascismo, occorre anche essere “puliti”, cioè non averla svolta anche nel passato, quando questa attività era “legale” e non un reato. Il valore retroattivo di questa infame legge o della sua interpretazione, è una diabolica trovata per indurre gli avversari più deboli a prostrarsi ai vincitori, tenerli sotto la minaccia della persecuzione, obbligarli ai più bassi servizi di provocazione e di spionaggio.
Nel 1927, in Ancona, erano state effettuate retatedi comunisti causate dal “basso servizio” fatto fare dall’O.V.R.A. all’ex segretario del partito di Ancona Arturo Me-dici, cioè lo stesso elemento che nel 1926 mi avevainviato a Bologna come ho già narrato. Da ciò una situazione di disagio, di diffidenza, di sospetti che mi induce alla riflessione e a riesaminare il mio passato.
Ricordi d’infanzia
Nato il 13 ottobre 1906, nel 1911 rimango orfano del genitore, vittima di una malattia conseguente ad infortunio sul lavoro.
Nel 1912, mia madre costretta a lavorare per vivere, non può lasciarmi in mezzo alla strada del rione Capodimonte dove abitiamo. Pertanto ottiene di farmi ricoverare, malgrado non abbia io ancora compiuto i prescritti sette anni, in un orfanotrofio situato a poche decine di metri dalla mia casa, nello stesso rione e così può vedermi ogni giorno. Rimango ricoverato in questo Istituto, dopo aver compiuto la 3 a classe elementare, sino all’alba del tragico 24 maggio 1915, dopo essere stato estratto da sotto le macerie dell’edificio crollato sotto i colpi di cannone delle navi austro-ungariche che avevano bombardato Ancona.
Durante questi tre anni di semi-clausura l’esperienza mi insegna che quando l’ambiente in cui si è costretti a vivere contiene in se stesso elementi di ostilità, bisogna reagire anche a costo di pagare lo scotto, purché cambi. Nelle collettività guai ai deboli se l’ordinamento interno non provvedeva proteggerli.
Alla prepotenza di un ragazzo più grande devo rispondere con un pugno che mi costa un giorno di cella a pane e acqua. Penso che sia un’ingiustizia, perché dovrebbero punire il prepotente e soprattutto organizzare la sorveglianza perché i grandi non vessino i più piccoli.
Alla prepotenza, la ribellione e a questa segue l’ingiustizia. A ciò fa da contrappeso il primo atto di solidarietà che mi commuove: la mano di un ignoto piccolo amico, rischiando una punizione, dal corridoio adiacente alla cella, attraverso l’inferriata della finestrella mi getta un’arancia di cui si è privato. L’episodio serve a darmi un certo coraggio malgrado l’isolamento e il buio della cella.
Nel 1917 frequento per alcune settimane la va classe elementare, poi a causa di una lunga malattia di mia madre, dei frequenti allarmi per l’apparire di aerei austriaci, delle tristi condizioni sociali a causa del perdurare della prima guerra mondiale, la penuria dei generi alimentari tesserati, lascio la scuola e dopo una breve esperienza fatta con una banda di coetanei che cercavano comunque di sfamarsi, a 12 anni mi occupo in un laboratorio di pasticceria e inizio così la mia esperienza di lavoratore.
Più che per la volontà di lavorare, alla proposta fattami dall’amico Vincenzo Tonini, aderii perché egli mi affermò che nella pasticceria era possibile mangiare residui di paste, biscotti e bere anche qualche uova.
Il proprietario, un vecchio piemontese, Domenico Scaglia, aveva una rivendita di caffè con pasticceria in vicolo Benincasa, una traversa tra il Corso Mazzini e l’allora Corso Vittorio Emanuele, oggi Garibaldi. Apriva il suo locale nelle prime ore del giorno, servendo contadini che all’alba giungevano dalla campagna portando sulle teste enormi ceste piene di verdura che avrebbero venduto sulla vicina Piazza delle erbe. Pescivendoli che si recavano al mercato, vetturini (fiacheristi come si chiamavano allora) che attendevano stazionando con le loro carrozzelle a cavalli, nella vicina piazza Roma, spazzini, fornai, ecc., cioè gente laboriosa che all’alba andava al loro posto di lavoro.
Sicché quando arrivavo nel locale verso le sei del mattino, sul banco vi era già una caterva di bicchieri, tazze, ecc. da lavare con un’acqua gelata che mi mordeva le mani. Dodici ore di lavoro al giorno, dovermi alzar dal letto all’ alba, camminare per le strade malamente illuminate dai lampioni a gas, mentre quasi tutta la città dormiva.
La casa fredda, il misero giaciglio di foglie secche di granoturco, la fioca illuminazione a candela, le scarpe usate e scartate da altri, ed altre piacevolezze della vita proletaria le consideravo come fatti normali, naturali perché così doveva essere. Osservavo tutto con curiosità, leggevo avidamente qualsiasi cosa scritta mi capitasse per le mani.
Gli anni che seguono al fine della guerra 1915-18 registrano un susseguirsi di fatti che mettono in subbuglio Ancona che a quell’epoca è una città di provincia poco industrializzata, dove prevale una economia piccolo-borghese-artigiana, ove, quindi, predominano ideologie politiche corrispondenti.
La città è meta costante di anarchici famosi come Errico Malatesta, Armando Borghi, Erasmo Abate e di repubblicani di destra e di sinistra. Quando cortei di questi raggruppamenti passano davanti alle chiese cattoliche, le loro rosse bandiere vengono abbassate in segno di disprezzo anticlericale.
Nei comizi le parole “rivoluzione”, “barricate” sono all’ordine del giorno. Infuocate canzoni rivoluzionarie si sentono cantare la sera nei rioni popolari, nei circoli, nei “club” dai nomi misteriosi come “Picconieri”, “Gabroche”, “Ginestra”, ecc.; si declamano le poesie di Pietro Gori, anarchico, gonfie di amore per l’umanità, la libertà e di odio per il ricco padrone responsabile della miseria popolare.
Ancona città rossa
Ancona è una città turbolenta dove si scontrano le ideologie piccolo-borghesi con quelle collettiviste del piccolo nucleo di classe operaia; repubblicani e anarchici contro i socialisti che spesso finivano col picchiarsi.
Nel 1920, così, mi trovo tra la gente che agisce per indurre i commercianti a ridurre del 50% il prezzo della merce. I commercianti per evitare il saccheggio dei loro negozi si affrettano a consegnare le chiavi alla Camera del Lavoro situata nel rione Archi o alle autorità di polizia.
Malintenzionati saccheggiano negozi e magazzini in via Loggia e gettano stoffe dalla finestra. Qualcuno grida: «Tutto deve essere portato alla Casa del Proletariato!». Partecipo con calore all’azione della massa popolare e mi sento trasportato dalle mille voci della folla assiepata in piazza delle Muse che assiste agli inutili sforzi di un “delegato” di P.S. tendenti a far agire un plotone di soldati che appaiono inde-cisi ad ubbidire agli ordini ed agli squilli di tromba, che anzi fraternizzano con la folla e accettano di bere del vino che viene loro offerto da alcuni animosi.
Nel giugno 1920, un mattino pieno di sole, sto risalendo la via Fazioli per portare latte nella casa dei padroni quando uno strano silenzio incombe su tutte le cose. La gente che incontro sembra in attesa di qualche evento. Ad un tratto il silenzio viene interrotto da colpi di fucile che vengono da1la non lontana Caserma Villarey. L’XI Reggimento Bersaglieri si è ammutinato per non partire a partecipare all’aggressione contro l’Albania. I bersaglieri stanno per avere la peggio, tentano una “sortita” e proprio in quell’istante un’autoblinda in loro possesso inizia la discesa della via Fazioli facendo girare minacciosamente la canna della mitragliatrice che sporge dalla torretta.
Impaurito mi infilo nel cunicolo di un fossato coperto, poi non appena passata, mi affretto a fare il mio servizio, ritorno sui miei passi ma trovo tutti i negozi chiusi e rari i passanti; ritorno a casa e corro al Duomo da dove si può osservare quello che sta accadendo sotto l’arco di Porta Pia dove dei ribelli si sono asserragliati e contro i quali si sparerà con il cannone da una regia nave giunta nel porto di Ancona. Dopo tre giorni di fucilate, cannonate, arresti, perquisizioni la guardia regia ha il sopravvento, gli ammutinati sconfitti e la ribelli soffocata. Questo fatto non può non lasciare traccia nel mio animo di lavoratore. Non so perché, ma sento di essere fiero di essere un anconetano.
Nello stesso anno 1920 lascio il lavoro di aiutante pasticciere per occuparmi come giovane barista in un caffè sito in piazza Roma che in seguito al cambio di gestione diventa il locale pubblico più frequentato da un gruppo di giovani socialisti i quali, nel 1921, dopo il Congresso di Livorno, fondano in Ancona la prima sezione del Partito Comunista d’Italia.
Durante le mie ore di lavoro, specialmente quelle serali, attraverso le discussioni, qualche volta accese, che si svolgono tra i clienti del locale (dialoghi, dispute che duravano, alle volte, sino alla chiusura del locale, alla mezzanotte), arrivava sino a 24me l’eco di questi gruppi o partiti politici contro lo squadrismo fascista che andava rafforzandosi in altre parti d’Italia, gli scioperi di categoria, le riunioni alla “Casa del Proletariato”, i comizi del 1° maggio- festa dei lavoratori -le violenze della Guardia Regia, tutto eccitava la mia curiosità e mi spronava a capire. Ma tutto mi appariva inverosimilmente intrecciato come una matassa, confuso, avvolto nella nebbia di disordini in cui non riuscivo a trovare un nesso, ma mi sentivo attratto dalle parole: giustizia, libertà, fratellanza, che assumevano per me uno strano sapore collegandole con quanto costituiva la mia esperienza.
In quel periodo i lavoratori d’albergo e mensa scendono in lotta per alcune rivendicazioni economiche. Lo sciopero dell’intera categoria dura 45 giorni. Giorni lunghi e duri da passare, e si traduce in una sconfitta per i lavoratori. La lotta arricchisce la mia esperienza attraverso la partecipazione alle riunioni in mezzo ad uomini maturi di cui ascoltavo le parole di lotta e di speranza.
Nel tempo ricordo i comizi, i cortei, le rosse bandiere, sento ancora l’entusiasmo con cui il popolo ricordava le “giornate del ’20”, la partecipazione popolare in aiuto all’XI Bersaglieri contrario a partire per la guerra d’aggressione all’Albania.
L’agonia della democrazia
L’argomento principale trattato dai comunisti che frequentano il Caffè Roma, dove lavoro, è la violenza fascista che sempre più dispiega la sua virulenza in tutta l’Italia. In verità, durante il 1921, lo sparuto gruppetto di fascisti di Ancona si limita a frequentare il Caffè Garelli al centro della città,gruppetto sempre protetto dalla polizia.
Alcuni politici danno vita a “squadre di arditi del popolo”, ma in sostanza, che io sappia, soltanto una volta si ha uno scontro di un certo rilievo: quello che avviene la sera del 22 giugno 1922, tra i fascisti Negroni, Olivieri e Flauto e gli anarchici Bruno Stecconi, Lorenzini e Spartaco Cecili con feriti da arma da fuoco da ambo le parti.
L’atmosfera della città si riscalda ancora più per due fattacci: il primo causato dal fascista Remo Veroli che temendo un’aggressione spara e uccide un cameriere, certo Taragoni, che dopo il lavoro tornava pacificamente alla sua abitazione; il secondo episodio dovuto certamente alla tensione sempre più aspra che si andava creando nel paese, una guardia regia di servizio in una strada della città senza motivo alcuno spara ed uccide un pacifico giovane tipografo, un certo Melloni, che si trovava a transitare per quella strada.
Durante il primo semestre dell’anno 1922 è sempre più all’ordine del giorno la violenza squadrista, scatenata in tutta l’Italia, sostenuta dalle “forze dell’ordine” e nell’agosto 1922, dopo aver compiuto violenze in tutta la regione marchigiana, provenienti da diverse regioni d’Italia, i fascisti invadono Ancona.
Attratto da un’invincibile curiosità, che costituiva la disperazione di mia madre, attendo le orde fasciste, in piazza Roma, provengono da via XXIX Settembre, e li vedo mentre risalgono il corso Vittorio Emanuele, oggi Garibaldi, avanzano su tre cordoni in fila indiana, sono migliaia, armati con rivoltelle, bombe a mano che, munite di sicura, fanno rotolare per la strada, forse per far vedere che non hanno paura di morire, agitano gagliardetti neri ornati di teschi bianchi, hanno tutti la “camicia nera” e alcuni un fez nero in testa, mentre altri portano l’elmetto militare del “fante”. Brandendo bastoni urlano minacce di morte contro i comunisti.
Seguo un gruppo che s’inoltra per il popolare rione di Capodimonte, in via Podesti una decina di loro caricano di botte un portuale di cui conosco soltanto il soprannome “Boccalà” e lo lasciano steso in terra in un lago di sangue. I rari passanti che indugiano per la strada, forse estranei alla politica, per curiosare, vengono provocati da un gruppo di fascisti che offrono un giornale il cui titolo non ricordo ma che suonava così: «… giornale fascista chi non lo compra è un comunista».
Insieme a me, altro curioso, c’è un giovane socialista: Leonardo Felice. Confidiamo nella nostra giovane età. Effettivamente passiamo inosservati, sarà perché portiamo i calzoni corti, sopra il ginocchio; raggiungo Piazza del Forte da dove nella sotto-stante via Marconi vedo la “Casa del Proletariato” in fiamme, cioè la stessa sorte toccata a diversi circoli o club operai.
Vado ancora in giro per la città e in via Carducci assisto ancora a violenze. Questa volta riconosco un aggressore, uno degli aggressori che picchiano un certo “Cagnò” un gelataio. Il picchiatore è uno dei figli del Conte Ferretti. Saprò poi che sono diversi i nobili che partecipano allo squadrismo.
Mi reco in Piazza Cavour dove assisto ad uno spettacolo indegno: fascisti avvinazzati cantano e danzano al suono di un pianoforte certamente fornito da una delle ricche famiglie che abitano nei pressi. Mi avvicino Caffè Clementi situato sotto i portici di Piazza Cavour e in quel mentre una guardia regia indicandomi a degli squadristi dice: «Quel ragazzo giorni fa leggeva “Il comunista”!». Non mi danno neppure il tempo di aprire bocca che pugni e schiaffi tormentano il mio volto e il corpo. Interviene uno di Ancona che dice: «Ma non vedete che è un ragazzo?! Lasciatelo andare!». Mi ingiungono di filare se non voglio morire ammazzato…
Tomo a casa con il cuore gonfio di rabbia, dopo aver aiutato la madre dei fratelli Romani, cognati dell’on. Albano Corneli, deputato comunista, a gettare acqua, che prelevavo con un secchi o alle “Tredici Cannelle”, sul chiosco per la rivendita di giornali che i fascisti avevano dato alle fiamme.
La canea fascista durò qualche giorno, poi gli squadristi tornarono alle loro città, ma le violenze contro gli antifascisti continuarono ad opera dei fascisti anconetani bramosi di vendicarsi di una città che tanto aveva resistito alle loro voglie.
Qualche giorno dopo l’occupazione di Ancona da parte delle squadracce fasciste e il ritorno di queste nelle loro regioni, la città tornava pian piano alla normalità, almeno per ciò che riguardava il lavoro. Ripresero la loro attività i negozi, gli artigiani, i pubblici esercizi e anch’io tornai al Caffè Roma.
Fra i comunisti che frequentavano il locale, i più noti dovettero prendere provvedimenti per evitare le violenze che invece, purtroppo, furono fatte subire all’ on. Albano Corneli, ai fratelli Romani, Araldo Desideri e qualche altro.
Poi riprese anche la vita politica, anche se in tono minore e semiclandestina, ma comunque il piccolo nucleo di fascisti anconetani non era ancora in grado d’imporre a suo piacimento la fine dell’opposizione, anche se è vero che con il tesseramento per l’anno 1923 gli iscritti alla sezione anconetana del P.C. d’I. raggiungono appena gli 80.
Fatto degno di nota, il sindaco del Comune di Ancona, repubblicano, Pacetti, con un certo numero di consiglieri, è andato incontro ai fascisti, il giorno del loro arrivo, consegnando loro le chiavi della città e l’amministrazione stessa al fascista Fabi.
Adesione alla gioventù comunista
All’inizio dell’anno 1923, capisco che il barista non è un mestiere che garantisca un certo posto di lavoro, con un po’ di volontà è una attività che molti possono fare, invece io voglio imparare un mestiere.
Poco dopo vengo assunto al Cantiere Navale di Ancona e adibito alla demolizione di alcuni vecchi cacciatorpediniere: trancia e mazza sono gli utensili. Non è un mestiere, è una vita da cani, all’aperto, sul mare,sotto il morso del freddo terribile, con la paga di 50 centesimi all’ora, ma spero di essere messo in un’altra sezione di lavoro. Infatti poco dopo vengo assegnato all’officina dei “fucinatori navali” in qualità di allievo. Il maestro è un operaio repubblicano mentre il manovale è un cosiddetto “disertore della vanga”, cioè un contadino che ha abbandonato la terra, come con il tempo faranno migliaia di altri e come farebbero milioni di altri italiani se il fascismo non intervenisse con leggi schiaviste tenendo legato il contadino alla terra.
Col tempo comincio a notare che qualche cosa di nuovo accade in me. Ho notato che centinaia di operai adulti e giovani all’urlo della sirena entrano nello stabilimento e ne escono. Siamo tutti sottoposti alla stessa disciplina fatta rispettare da un complesso di guardiani (generalmente ex carabinieri o guardie regie), abbiamo gli stessi problemi, le stesse viviamo la stessa triste realtà, i medesimi pensieri di fronte alla “stessa paga”. Notavo anche che pur facendo ognuno un tipo di lavoro – fresatore, tornitore, falegname, calderaio, carpentiere, fonditore, ecc. – il piroscafo sugli scali era il risultato di un’attività collettiva.
Precedentemente avevo inteso le speranze di altri ragazzi par mio. :~ Ognuno sperava in rapporto alla propria categoria. Il garzone barbiere sperava, una volta uomo, di aprire bottega per proprio conto e liberarsi dello sfruttamento del padrone, così altri giovani in attività artigiane e negozi, ma i giovani operai come avrebbero potuto sperare un giorno in una condizione migliore?! Trovandomi tutti i giorni in mezzo a centinaia di altri lavoratori non mi sentivo più solo, ma accomunato al destino di altri e, con gli altri, uniti, avremmo potuto modificare, migliorare la nostra situazione.
Naturalmente tutte queste sensazioni sono informi in me. Non conosco ancora il ruolo di strumento di lotta di classe che il fascismo gioca in favore del capitalismo ma una cosa è certa: i fascisti devastano le cooperative operaie, incendiano le Camere del Lavoro, sedi di partiti democratici, giornali dei lavoratori, assassinano dirigenti politici e sindacali tentano di impedire qualsiasi dimostrazione democratica.
Nel Cantiere i fascisti reclutati tra gli ex arditi di guerra, ex guardie regie, ex carabinieri, terrorizzano gli operai impedendo ogni rimostranza per il taglio dei cottimi, ogni attività sindacale. Pertanto essendo i fascisti al servizio dei padroni vanno combattuti. E per combatterli e vincerli bisogna essere uniti. Ma come?
Devo prendere una decisione. Ma non è facile. Ho veduto le violenze fasciste, io stesso le ho patite, ma vedo che a quella lotta rinunciano centinaia, migliaia, forse, di uomini maturi per l’età, l’educazione, con cultura, esperienza e cariche di responsabilità. Nulla e nessuno può pretendere da me un impegno, fare ciò che altri invece sfuggono.
Può darsi che io abbia fatto queste considerazioni ma rimane il fatto che ho avuto modo di conoscere da tempo un comunista, Luigi Mercanti, barbiere, al quale da piccino mia madre ha dato il latte dalle sue mammelle. Questi ha subito violenze dai fascisti. Vado a trovarlo e gli chiedo che mi faccia iscrivere nella gioventù comunista. Rimango deluso, ero convinto che molti fossero i giovani comunisti. Invece in Ancona, e siamo nel 1923, non c’è ancora una sezione di giovani di questo partito. L’ufficio della federazione giovanile comunista è a Jesi. Una cittadina a circa 30 km. da Ancona, fortemente industrializzata.
Dico a Mercanti che vi sono altri giovani del Cantiere Navale che vogliono iscriversi e che possiamo creare una sezione giovanile comunista anconetana. Mercanti risponde: «Va bene, vediamo, vieni con gli altri!».Qualche giorno più tardi ci troviamo riuniti: Remo Garbati, Biondi, Gino Marasà, Simoncelli, Umberto Costantini e Maderloni.
Una lettera all”Avanguardia” organo della gioventù comunista informa che è nata la sezione giovanile comunista anconetana. La lettera è stata compilata dalla moglie di un vecchio operaio calderaio del Cantiere Navale, Maria Parmiani Ciasca che un giorno sarà mia suocera perché sposerò nel 1933 la figlia Rinalda.
Mentre nasce entro le mura del Cantiere Navale di Ancona la Sezione Giovanile Comunista, qual è la situazione del Partito nella città?
Il compagno Gino Lodovichetti è il segretario della sezione e il compagno Aldo Pignanesi ne è il segretario amministrativo. Le riunioni dei compagni si svolgono in case private e in particolare in casa del compagno Artemio Tibolla, portuale. A curare l’organizzazione e l’orientamento politico della sezione giovanile viene delegato un adulto, il compagno Romolo Garbati. Il compagno on. Albano Corneli, per sfuggire alle persecuzioni fasciste ha dovuto riparare all’estero, ma il partito nei suoi prende il provvedimento d’espulsione.
Il compagno Allegrezza sorpreso dai fascisti mentre ritira un pacco di stampa del partito, scaraventa il pacco contro gli aggressori e riesce a sfuggire. Attraverso varie vicissitudini ripara in Unione Sovietica e muore nella stessa clinica ove è ricoverato il compagno cinese Mao TzeTung. Viene bastonato dai fascisti fino a morirne il compagno Giordano Innamorati, uno dei dirigenti la Sezione di Ancona. I fascisti hanno prelevato da casa il compagno Mario Zingaretti, segretario della Camera del
Lavoro di Ancona, e credendo di averlo assassinato,lo gettano in un burrone.
Purtroppo si hanno anche delle defezioni tra elementi una volta aderenti al partito. Si fanno i nomi di Maurilli di Falconara Marittima e di Ionna un capo stazione delle FF.SS. che passerà all’O.V.R.A. facendo opera deleteria in tutta l’Italia.
Nello stesso anno 1923 alla illegalità fascista si unisce quella della magistratura che organizza un processo contro una cinquantina di comunisti marchigiani. Molti compagni ferrovieri sono stati licenziati dal posto di lavoro e per poter trovare un’attività dovranno emigrare così come saranno obbligati a fare numerosi altri compagni conosciuti dai fascisti o dalla polizia.
La situazione non è affatto incoraggiante, malgrado ciò sarà proprio questo piccolo nucleo di giovanissimi che col tempo dovrà assumersi la responsabilità della continuazione dell’attività politica antifascista, conalterna fortuna, nella regione, sino al crollo della dittatura fascista.
Aderisco, con gli altri giovani, alla organizzazione comunista, reagendo così alla violenza fascista, all’ aumentato sfruttamento in Cantiere, al taglio dei cottimi, all’ aumento del ritmo di lavoro, all’ obbligo di lavo-rare dieci ore al giorno, allo spadroneggiamento delle “camicie nere”.
Non fu certo maturità politica ad orientarmi verso il Partito comunista anziché verso un altro dei partiti antifascisti che si trovavano allora sulla scena politica italiana. Una qualche influenza devo averla ricevuta dal contatto avuto nel 19211 allorché lavoravo al Caffè Roma, ma determinante fu il fascismo con la sua azione persecutoria contro i comunisti, con la sua propaganda anticomunista.
Chiedendo di unirsi agli altri giovani comunisti il gruppo di giovani del cantiere navale non pensava di fare una scelta ideologica fra i partiti antifascisti; essi sapevano soltanto che i comunisti erano indicati come il nemico numero uno degli stessi fascisti. Visto che il fascismo dava il suo appoggio alla classe padronale e che conduceva una selvaggia guerra contro le organizzazioni di difesa della classe operaia, bisognava combatterlo. Per combattere il fascismo pensai che non vi fosse strada migliore che avvicinarsi al partito comunista ritenendolo il più conseguentemente antifascista.
La disciplina di cui si diceva fosse permeato il Partito comunista (specie di accusa formulata dagli anarchici) non mi spaventava perché abituato a considerare la disciplina come un fattore costruttivo sul piano della produzione. Anzi, ciò mi dava un senso di fiducia, in quanto, in parte, si attribuiva la sconfitta delle forze popolari, nella lotta contro il fascismo, proprio alla mancanza di disciplina, di coesione, e quindi di organizzazione delle forze dell’antifascismo e alla concezione anarcoide della lotta. Si ricordava quanto accaduto nel 1922 e il manifesto della “Alleanza del Lavoro”, affisso sui muri della città, con cui si invitavano i lavoratori a difendere i loro rioni, le loro case, con conseguente indebolimento delle forze antifasciste.
La Sezione Giovanile Comunista, ufficialmente costituita, non tarda a fare prose-liti sia tra i giovani del Cantiere Navale che nei rioni popolari della città. Essa si rafforza particolarmente nel rione Guasco e a S. Pietro. Non abbiamo grandi pretese; ma abbiamo la sensazione di partecipare a qualche cosa di grande e che comunque esce dalle azioni normali.
È ovvio che oltre ai motivi contingenti indicati, a determinare l’orientamento dei giovani operai sono stati anche gli avvenimenti che si sono succeduti dal 1913 in poi. La “settimana rossa” del 1914, i lavoratori assassinati dalle “forze dell’ordine”, gli orrori della guerra 1914-18, con tutte le funeste conseguenze per i lavoratori, la Rivoluzione Russa nel 1917, i moti di Ancona del 20 con la ribellione dell’XI reggimento bersaglieri, e gli anni di violenza fascista.
Interessa enormemente quello che sta accadendo in Russia. Le notizie che circolano sull’Unione Sovietica sono contraddittorie, suscitano scalpore e accese polemiche, determinano sempre più una morbosa curiosità.
La parola “rivoluzione” è di per sé piena di fascino per la gioventù. Persino i movimenti dittatoriali borghesi (come quello fascista) hanno bisogno di usare questo vocabolo per ingannare parte dei giovani. Il fatto che il capitalismo mondiale si contro i “bolscevichi” e contro il loro governo, è la prova che in quella stessa parte del mondo è veramente la classe operaia e i suoi alleati che hanno preso il potere economico e politico.
Come il vecchio vive di ricordi, il giovane vive ed è attratto dalla novità, pertanto, pur non conoscendo nulla di questo sterminato Paese, molti giovani operai sentono di amarlo e nasce un sentimento di solidarietà con quegli uomini che togliendosi di dosso i parassiti iniziano il più grande esperimento sociale della storia umana di tutti i tempi. L’epiteto di “bolscevico” rivolto da
i fascisti ai comunisti italiani, accomuna questi alle vicende, alla lotta, alle sofferenze del popolo sovietico e la gioventù comunista segue con estremo interesse l’evolversi degli avvenimenti con sconfinato amore e fiducia che rasenta, con il tempo, l’idolatria.
Nel 1924 le condizioni generali politiche sono tali che l’organizzazione giovanile non può che porsi ristretti obiettivi. Fra questi il più importante è quello della diffusione della stampa del partito che i fascisti accaniscono a non far vendere legalmente minacciando i rivenditori e bruciando le loro edicole.
All’opera di trasporto e di diffusione della stampa sono chiamati i giovani che quasi ogni giorno si recano in via Nazionale, oggi via Marconi, sotto il cavalcavia, nel locale “pronto soccorso” dell’Associazione Volontaria Assistenza “Croce Gialla”, dove il compagno Spartaco Lodovichetti (già impiegato alle poste e telegrafi e licenziato perché comunista) occupato presso questaAssociazione come custode, consegna loro pacchi di “Stato Operaio”, “Ordine Nuovo”, “l’Unità”, “Seme” (giornale dei contadini), “Compagna” (giornale delle donne) e “L’Avanguardia” (giornale della gioventù comunista).
Nello stesso anno, in occasione del III anniversario della fondazione del partito organizziamo un lancio di manifestini contemporaneamente in un teatro e due cinematografi. Il materiale da lanciare lo preleva, insieme al compagno Atlantico Galeazzi, un portuale, nella abitazione della compagna Adalgisa Breviglieri, una insegnante di scuola elementare, che in quell’epoca aveva anche l’incarico di segretaria amministrativa della sezione comunista. Questa compagna abitava in via Mamiani ed è deceduta il9 marzo 1925. La sua tomba al cimitero delle Tavernelle di Ancona, per tutto il ventennio fascista fu meta di omaggio di numerosi giovani compagni.
La sera del 21 gennaio 1924 nella casa del compagno Aristodemo Maniera sita in via Cialdini 6, la sorte indica i componenti del gruppo e il posto dove il gruppo deve operare. Maniera, Enrico Di Nardo (Testolina), Solustri e Adrio Andreatini al Teatro Vittorio Emanuele; Francesco Favagriccia e Giulio Rossi alla Sala Dorica; Bruno Marcianesi e Raffaele Maderloni al cinema teatro Goldoni. Date le condizioni politiche del tempo, l’azione provocò molto rumore perché era un segno che l’antifascismo, malgrado tutto non si dava per vinto.
L’assassinio dell’on. Giacomo Matteotti, deputato socialista, provoca una grande sensazione, ci aspettiamo qualche cosa di nuovo che faccia modificare la situazione, ma gradatamente si ritorna a fondo, anche se la sezione giovanile comunista continua nella sua opera di reclutamento anche in zone già sotto l’influenza anarchica e repubblicana.
Agli inizi del 1925, la polizia mette in opera una grande provocazione. In seguito ad una perquisizione domiciliare in casa del compagno Manzotti di Jesi la polizia rinviene dei documenti che rivelano la posizione di segretario della federazione giovanile comunista del compagno Idilio Romagnoli, che arrestato viene associato al carcere giudiziario anconitano. In un doppio fon do di un cassettone in casa Romagnoli, la polizia trova altri documenti sull’organizzazione.
Il partito è ancora legale, ma la polizia, obbedendo a disposizioni del governo fascista, denuncia numerosi compagni alla magistratura per associazione a delinquere.
Nel carcere anconitano vengono associati i compagni Profili di Fabriano,Coleffi di Porto San Giorgio e numerosi altri.
Sono oltre trenta i compagni arrestati, trattenuti illegalmente per diverso tempo poi prosciolti perché il fatto non costituiva reato. Alcuni godono dell’amnistia con-cessa dal re Vittorio Emanuele III per il XXV anniversario della sua ascensione al trono d’Italia.
Durante l’arresto il “soccorso rosso” provvede all’invio alle porte del carcere giudiziario di Santa Palazia di pacchi per i detenuti politici, contenenti il pasto giornaliero per i compagni non anconitani.
Ogni giorno, in casa del compagno Atlantico Galeazzi abitante in Vicolo del Padrone nel rione Porto, la moglie Irma Benigni provvede a cuocere il pasto per una ventina di detenuti, confeziona altrettanti pacchi che messi in una cesta di vimini dai giovani comunisti vengono consegnati alla porta del carcere. Una parte di questi compagni saranno ripresi poi dalla polizia e avviati al confine con un provvedimento di carattere amministrativo come se fossero delinquenti comuni.
Nell’ottobre 1925 per l’anniversario della rivoluzione sovietica numerose bandiere rosse vengono esposte nei punti più adatti della città. Con l’ausilio del compagno Cesare Canafoglia, eludendo la vigilanza dei carabinieri, riesco ad entrare nel Palazzo del Governo e issare sul pennone della torre comunale di Piazza Plebiscito una grande bandiera rossa che all’alba del giorno dopo provocherà grande emozione e sfortunatamente anche l’arresto dell’intera famiglia del custode della torre: Orfeo Bedini.
Passata la bufera, per fronteggiare la situazione che si fa sempre più dura, il nostro partito sente la necessità di prendere alcuni provvedimenti di carattere organizzativo. Per quello che ricordo mi sembra che venne creato l’Ufficio “B” (organizzazione parallela clandestina), la cui direzione venne affidata al compagno Pignanesi che per i collegamenti epistolari si servì degli indirizzi privati di due lavoratori portuali: Artemio Tibolla ed Eugenio arena.
Il 1925 è un anno carico di violenze fasciste, sembrano inferociti per la paura subita dopo l’assassinio Matteotti, malgrado ciò in vista del III° Congresso Nazionale del P.c. d’I. . Si organizzano i congressi provinciali e interprovinciali che naturalmente devono svolgersi nella clandestinità con i risultati che chiunque può comprendere. Il Congresso della Sezione Comunista di Ancona affida la carica di segretario al falegname Arturo Medici e delega al Congresso Nazionale il meccani-co Americo Quaquarini, il quale presentatosi nel gennaio 1926 alla frontiera italofrancese, per recarsi a Lione, perché in possesso di passaporto falsificato, finisce in carcere.
L’attività dei giovani oltre agli aspetti organizzativi si concreta nella distribuzione della stampa. Anche questi organizzano il loro congresso che avrà luogo al primo piano di una sala interna di una trattoria popolare allora in zona periferica della città, in località “Passetto” gestita dal “Gobbo de Taiarì”, figura notissima agli anconetani dell’epoca.
Il congresso si svolte senza incidenti di sorta e si constata che l’adesione al movimento da parte di giovani operai è in continuo aumento. La carica di segretario della federazione viene affidata al compagno Iobbe Simoncelli, mentre si soprassiede alla nomina del compagno che dovrà rappresentare la federazione giovanile di Ancona al III° congresso nazionale.
Il 1° maggio 1925, celebro la Festa dei Lavoratori non presentandomi al lavoro. Il giorno appresso nella portineria del Cantiere trovo “medaglia nera”. Sono licenziato. Per uno che vive del proprio lavoro, il licenziamento non è mai notizia gradevole anche se si hanno vent’ anni, età in cui poche cosa spaventano. Comunque rientro nel mio rione un po’ preoccupato per la disoccupazione, anche se attendevo da un giorno all’altro la chiamata per il servizio militare.
Sto risalendo la via del Comune per recarmi alla mia abitazione in vicolo dei Tribunali 21, aggirandomi tra le numerose bancarelle dei venditori ambulanti che hanno invaso tutta la zona per la Fiera di S. Ciriaco,quando un rude colpo ad uno stinco mi fa voltare per vedere chi è il mascalzone. Sono cinque fascisti in vena di provocazione. Protesto ed essi mi vengono addosso tutti insieme, mi difendo come posso, cercano di portarmi dentro un portone, ma lafolla presente interviene in mio favore e i cinque devono mollare… l’osso.
Il giorno dopo i cinque mascalzoni e vagabondi sono ancora nel rione con la solita vena, ma stavolta incappano nel mio tutore, un anarchico di vecchio stampo che mi chiede: «Non sono quelli di ieri?». Conoscendo il suo carattere, per evitare grane, nego. Ma egli afferra un catorcio di ferro e li affronta e li mette in fuga. Intervengono due bersaglieri, poi i carabinieri e tutti finiscono in questura, situata allora sotto l’Arco di
Carola, in via Jesina, oggi Matteotti.
Riferisco il dialogo tra il Bedini e il commissario di P.S.:
«- Voi Bedini avete aggredito questi cinque giovani che facevano i fatti loro!
– Signor Commissario quei cinque lì, ieri hanno aggredito un mio figlioccio, sappia signor Commissario che io sono una persona seria ed onesta!
– Risulta, Bedini, che nel 1898, durante il Ministero Crispi siete stato inviato al “domicilio coatto” all’isola di Favignana!
– Ebbene, signor Commissario, questo dimostra che sono una persona seria ed onesta e a me quelli là non mi mettono paura!»
Mentre continuo la mia attività per l’organizzazione della gioventù comunista cerco e trovo lavoro presso un cantiere per la demolizione di un piroscafo, poi nel luglio del 1925 vengo assunto presso l’Azienda Tranviaria di Ancona, dove rimango occupato sino ai primi del gennaio del 1926, dovendo raggiungere poi Taranto per i 28 mesi di servizio di leva nella regia Marina.
Ho già narrato come prima di partire per Taranto, eseguendo l’invito del Partito comunicatomi tramite Arturo Medici – segretario della Sezione – mi sono presentato a Bologna e quindi l’avventura che si concluse con l’arresto e la detenzione nel carcere milanese di S. Vittore.
Come già scritto, il 14 marzo 1928, libero ormai dal servizio militare, torno ad Ancona. Impellente si presenta il problema dell’occupazione. Due anni e più di lontananza dalla città devono aver messo nel dimenticatoio l’episodio del gennaio 1926. Infatti passa qualche settimana e nessuna si occupa di me. E perché lo dovrebbero?! L’attività che ho dato per il partito tra il 1923 e il 1926 è stata forzatamente clandestina, quindi nessuno mi infastidisce, neppure i… compagni.
Presento domanda di riammissione pressa l’Azienda Tranviaria dove mi si ripromette la riassunzione come avventizia per il periodo estivo. In attesa di essere chiamata mi sprofondo nella lettura. Mi sono abbonato ad una libreria circolante e versando tre lire al mese posso leggere quanti libri vaglio, sempre, s’intende, prelevandone una alla volta. Ciò non toglie che qualche conversazione con qualche compagno del rione avvenga, ma senza impegno.
Aspetto che siano gli altri a prendere l’iniziativa, ma forse tutti stiamo vivendo un periodo di attesa. E si spiega con tutto quello che sta accadendo. Qualche tempo prima nel circolo rionale fascista “G. Neri” in viaVolto dei Seniori, i fascisti hanno massacrata di batte il compagno Argentino Bontempi che morirà poco tempo dopo all’Ospedale Civile.
La libreria offre soltanto libri ameni che non mi sono di alcun aiuto per quello che io cerco di sapere. Classi, latta di classe, ferree leggi dell’economia, diritto, morale, religione, la Stato con le sue sovrastrutture, mi è ignoto: Nota e convincente c’è soltanto la mia condizione di lavoratore in preda alla necessità dell’esistenza e sono convinto che tutti gli altri lavoratori la pensino come me. Una confusa idea della presenza di Dio in ogni luogo, l’amore per la Patria, il non dover toccare la roba altrui, residuo di ciò che mi è stato insegnato alla scuola elementare, prima di essere avviato, dal bisogno, a guadagnarmi il pane, costituiscono i miei unici principi e unica norma morale.
Già prima dell’arrivo delle squadracce fasciste nell’ ottobre 1922, per tema della violenza, malti si sono disfatti dei libri che avrebbero potuto essermi utili, anche se data la mia elementare cultura, avrei potuto afferrarci poco. La stampa del partito che ho distribuito tra il 1923 e il 1926 è passata tra le mie mani senza lasciare traccia, preoccupato soltanto della sua diffusione.
La situazione dei lavoratori e la fiducia nel partito: ecco il punto di partenza. Per la classe operaia il fascismo si condanna da sé, con la sua realtà di ogni giorno. Ma con che cosa soddisfare la brama di sapere, di conoscere, della gioventù operaia e antifascista? Sento che la mia visuale politica è fortemente condizionata dalla mia elementare educazione e cultura.
Nel luglio 1928, vengo riassunto al lavoro, in qualità di bigliettaio avventizio, dall’ Azienda Tranviaria anconetana.
Ricostruzione del partito
Cesare Canafoglia, nato nel 1901, aveva aderito al Partito comunista nel 1921 appena tornato dal servizio militare. Di carattere taciturno, introverso direi, aveva imparato bene il mestiere di muratore e piuttosto che andare a padrone preferiva guadagnarsi da vivere prendendo piccoli appalti che portava avanti con un manovale.
Ci eravamo conosciuti nel 1923, una sera, mentre in una strada del popolare rione “Porto” stavo disegnando sul muro una “falce e martello”. Me lo trovai dietro le spalle, mi misi sulla difensiva, ma scorgendo il suo sorriso alla luce del fanale a gas, compresi che era uno dei “nostri”.
Non ci conoscevamo perché io abitavo nel vicino rione “Duomo” indicato anche come la “Città Leonina”, fulcro della vecchia e feudale città. Diventammo amici e cominciamo a frequentarci specialmente la sera, dopo il lavoro, al centro del rione nella piazza del Comune dove solitamente convenivano tutti i giovani amici.
Nel 1925, trovato in possesso di manifestini antifascisti, era stato arrestato, schedato dalla polizia, ma dopo qualche giorno rilasciato. Aveva un hobby: avere sempre a disposizione un’arma, o bianca o da fuoco, ma possibilmente tutt’e due.
Lo consideravo un bravo compagno, avevo fiducia in lui, pertanto non mi meravigliai quando appartati in un angolo della piazza del Comune, una sera, mi disse che doveva parlarmi del partito. Meravigliato, invece, lo fui quando sentii dirmi che faceva affidamento sulla mia collaborazione per la riorganizzazione del partito, riprendendone le maglie là dove la violenza fascista le aveva spezzate.
Malgrado l’esperienza passata: S. Vittore di Milano, la “lista nera”. ecc. sentivo di essere ancora “un ragazzo” e mi sembrava di essere un presuntuoso accettando la proposta di un incarico che a quanto sembrava, come si dice, faceva “tremare i polsi” ad altri con più capacità, esperienza, cultura, ecc. Mi venne l’idea di rifiutare, feci qualche obiezione, poi non ebbi il coraggio di dire di no; aggiunsi che avrei incominciato nel rione poi avrei passato la mano ad altri compagni più capaci di me nel portare avanti il lavoro. Canafoglia concluse: «Non ti preoccupare, fra non molto avremo materiale stampato a disposizione e avremo altri aiuti!».
Iniziando il mio lavoro di riaggancio, pensai che in fondo si trattava di dare un senso più concreto ai legami tuttora esistenti, sul piano dell’amicizia, con tutti i giovani già aderenti all’organizzazione giovanile nata ad Ancona nei rioni Porto e Duomo nel 1923. Approfondire questi legami, sondare se il modo di pensare di cinque o sei anni prima, si fosse deteriorato per quanto accaduto, sul piano politico, in quegli anni. Bisognava fare estrema attenzione a non fare passi falsi che avrebbero potuto compromettere sin dall’inizio questa ripresa organizzativa.
Tentare questi approcci non mi sembrò difficile e in effetti non lo fu, dati i rapporti già esistenti. Nel 1929/30 le condizioni degli operai, degli artigiani erano, come sempre miserrime, con l’aggravante della crisi economica mondiale in corso. Queste cattive condizioni potevano influire in tre modi: lottare contro il regime, estraniarsi da ogni attività politica, cioè neutralizzarsi, o prendere la tessera del partito fascista per ottenere appoggi per trovare un lavoro con meno difficoltà.
Giunto a questo punto è necessario ricordare che erano trascorsi diversi anni dalla maggiore recrudescenza della violenza squadrista, fatti di questo tipo si facevano sempre più sporadici perché sistemare gli avversari politici ormai era compito della magistratura in generale o del “tribunale speciale”, in particolare in base alle “leggi eccezionali” promulgate nel 1926.
«Non c’è più nulla da fare!». Questa era la frase che generalmente veniva pronunciata in risposta alla domanda rivolta così, semplicemente: «Come vedi la situazione politica?». Era un segno indubbio dei guasti prodotti dall’isolamento, dall’assenza totale della libera stampa, dalla mancanza di contatti tra operai, dovuto alla preoccupazione di non subire persecuzioni dal regime e dai padroni.
Esistevano le condizioni per essere antifascisti ma a che pro’ esserlo se non vi era nulla da fare, se non si ha fiducia nelle possibilità di combattere e vincere il nemico; rischiare anni e anni di galera senza avere una probabilità di vittoria, come è possibile battersi?
E in effetti ormai, da anni, il partito fascista era padrone di tutto, ogni cosa era al suo servizio:la legge, la magistratura, la chiesa con i preti, i dirigenti delle forze armate,le diverse polizie (quelle ufficiali), prefettura, questure, commissariati, carabinieri, le diverse milizie del regime (quelle segrete) come l’O.V.R.A.. Tutto era a disposizione dei gerarchi: le banche, la radio, la stampa (E.I.A.R.), la burocrazia statale, ecc. E noi proletari: inermi.
Bisognava credere che quello che animava noi animasse pure, di certo, milioni di altri lavoratori delle altre province d’Italia. E tutti uniti avremmo potuto riconquistare la libertà. Il fascismo con la sua azione cercava di tenerci divisi, noi dovevamo lavorare per unirci ed essere più forti. Ecco l’obiettivo da raggiungere.
Necessitava infondere fiducia, credere nella possibilità di avere una probabilità di vittoria bisognava scrollarsi di dosso il terrore della violenza, credere in se stessi; in sostanza aver della vita un senso eroico e non di avvilimento con la disposizione ad ogni compromesso, e solo per non subire persecuzioni, quando tutta la vita è persecuzione ed umiliazione. Necessitava infondere fiducia in noi stessi e nella classe che rappresentavamo, ma per aver risultati tangibili, bisognava che si realizzasse alme-no una delle premesse di Cesare Canafoglia, cioè ci venisse consegnato materiale di propaganda da parte del Partito
La via della cultura
Dal lontano 1922 in poi, il fascismo provvide che tutto ciò che potesse sembrare “sovversivo” sparisse dalla circolazione e con l’inoltrarsi del “regime” nulla sfuggiva al controllo politico dell’apparato poliziesco dello Stato.
Quello che riusciva ad entrare clandestinamente in Italia non era che una goccia d’acqua in un deserto arido che chiedeva invece acqua torrenziale.
Già nel 1924/25 ogni attività degna di rilievo, da parte dei partiti antifascisti, aveva dovuto cessare sotto l’imperversare della violenza squadrista e, poco dopo, anche alla stampa d’informazione quotidiana di opposizione, con le leggi eccezionali, venne messo il bavaglio. Purtroppo anche la paura del peggio ha contribuito a far fuori materiale prezioso e all’ infuori dei ricordi di ciò che si è visto con i propri occhi, e inteso con le proprie orecchie non vi è quasi più traccia di ciò che è stato detto e scritto prima della dittatura fascista.
Alla gioventù operaia, lavoratrice, rimase in pasto soltanto ciò che circolava clandestinamente, e ciò che a bella posta, era stato lasciato in circolazione più o meno autorizzata e fra questo materiale la produzione letteraria di individualisti, tipo Mario Mariani, che esprimeva l’amarezza della situazione sociale del dopoguerra 1915-18. Tipo di letteratura antiborghese sì, ma anche antisocialista anzitutto compreso 11ussolini, ma nulla che indicasse la via per un mondo diverso.
In attesa di meglio ci si scambia clandestinamente libri del Mariani, ubriacandoci col nichilismo distruttore de La casa dell’Uomo, Povero Cristo, Le meditazioni di un pazzo, ecc.; e di Notari il vieto anticlericalismo del Maiale nero, o la satira del Tre ladri.
Leggiamo tutto ciò che capita e questa volta è di turno Victor Hugo con I miserabili, L’uomo che ride, Napoleone il piccolo e altri libri di questo scrittore francese che trattano il colpo di stato di Luigi Napoleone Bonaparte.
Poi è la volta dell’anarchismo, di Menzogne convenzionali di Max Nordaux e dell’anticomunismo di Stato e rivoluzione di Luigi Fabbri e dei Saggi sulla rivoluzione di Carlo Pisacane.
Sul finire del 1929 mi interessò il primo volume dei Fratelli Rupe di Leonida Repaci, fino al punto che con il compagno Ruggero Giannini scrissi una lettera all’ autore per avere notizie circa il secondo volume, ma non ricevetti alcuna risposta.
In quel periodo di ripresa organizzativa vengo, per caso, a conoscenza che all’ Agenzia giornalistica Solferini, sita in Largo Sacramento, giungono periodicamente alcune copie di una rivista stampata a Genova diretta da Antonio Rigola (un socialdemocratico) dal titolo “I problemi del Lavoro”. Leggiamo con avidità il contenuto di questa rivista ma ci accorgiamo, e con una certa meraviglia (che testimonia la nostra buonafede) e non senza amarezza, che è sul terreno della collaborazione con il regime fascista e che forse serve a dare un tono di rispettabilità al fascismo stesso, nel senso che potrebbe far sostenere che in Italia vi è la libertà di stampa.
Come detto, c’interessa enormemente l’Unione Sovietica e leggiamo volentieri tutto ciò che riguarda questo Paese. Quindi leggiamo L’ Odissea del Celuschin di Polledro e Galletto e, pur di sapere, leggiamo anche i libri di cui il fascismo lascia inondare il mercato librario come: L’Impero del lavoro forzato di L. Barzini, Dall’aquila imperiale alla bandiera rossa del generale bianco Crasnov, poi Giudizio sul bolscevismo di G. Ciocca.
Quello che accade fuori d’Italia lo cerchiamo sulla stampa estera e in particolare sui giornali reazionari francesi che giungono in Italia e su “L’Osservatore Romano” di Città del Vaticano, oltre, s’intende, sui giornali del regime, per tentare di scoprire lembi di verità tra le righe.
La ricerca nelle bancarelle conduce alla scoperta di libri che parlano al cuore e ai libri già indicati precedentemente si aggiungono: lo popolo dell’abisso, Martin Eden, Il tallone di ferro di Jack London, poi La spia e La Madre di Massimo Gorki.
Grande entusiasmo genera l’opera del prof. Ettore Ciccotti: Il tramonto della schiavitù.
Un giorno, con il compagno Ruggero Giannini, dotato di cultura umanista, figlio di ferroviere licenziato da Mussolini nel 1923, ormai legati da grande amicizia, ci rechiamo dal libraio Fogola con negozio al corso V. Emanuele, chiediamo se ha del materiale per studiare l’Esperanto. Il Fogola mi guarda, sorride, poi risponde: «No, ormai non c’è più nulla da sperare!». Ci permettiamo di fare un sorrisetto e usciamo senza salutare. Fogola è un fascista. Egli non sa che abbiamo il cuore pieno, colmo speranza, anzi di certezza. E il tempo ci darà ragione.
Nel 1929 nei luoghi di lavoro continua a regnare il terrore. L’adesione al partito fascista è scarsa e se qualcuno chiede la tessera è perché certi datori di lavoro esigono l’iscrizione al P.N.F. o almeno la tessera dei sindacati “tricolori”. Più tardi l’iscrizione al partito fascista diverrà una pura formalità. La sigla “P.N.P.” verrà a significare “Per Necessità Famiglia” e non adesione al partito. Ai lavoratori che si iscriveranno al partito dopo il 1932, purché siano “ex combattenti” la data d’iscrizione concessa sarà quella dell’anno 1925.
A dimostrazione di quanto sto scrivendo, come risulta dal rapporto della Questura di Ancona, su nove denunciati al tribunale speciale nel 1932, due erano iscritti alla “Gioventù del Littorio” ed un terzo, oltre che tesserato fascista, era anche un dirigente sindacale fascista dei lavoratori dell’impiego privato. I primi due si chiamava-no: Adelmo Pianelli, Aldo Magistrelli; il terzo si chiama: Gisleno Elia.
Un altro episodio: nel 1929, tentiamo la creazione di un “fronte unico” con gli anarchici. L’incontro avviene in casa del compagno Socrate Bemacchia, sita in via Guasco. A rappresentare gli anarchici erano: Remeto Ercoli, Valenti detto “il re degli straccioni”, Vero Candelaresi. Quest’ultimo giunto da poco dalla Francia dove si era recato per lavoro, che nel 1938 aderirà alla nostra organizzazione, in quella circostanza porta nella discussione l’eco di vecchie questioni e pregiudizi e l’influsso della lotta che si svolge negli ambienti dell’emigrazione antifascista, dove si palleggiano le responsabilità del fascismo, con la conseguenza che la frattura tra anarchici e comunisti continuerà a tutto vantaggio del fascismo.
Ebbene nel 1932, il Candelaresi, operaio presso la Direzione d’artiglieria di Ancona, come risulta da documenti d’archivio era già iscritto al partito fascista. In ciò nulla di straordinario, lo riferisco soltanto come esempio, perché si abbia chiara la situazione.
Intanto il comitato procede alla ricostituzione del partito. Canafoglia per i contatti con il “centro”, Felice per quelli con la provincia e Maderloni per il collegamento delle diverse cellule della città di Ancona e i diversi gruppi già organizzati dal 1923.
In attesa che arrivi il materiale del partito, il compagno Gisleno Elia, ci prepara un manifestino di propaganda utilizzando un duplicatore che abbiamo acquistato.
Nel 1930, un certo numero di lettere, spedite tramite la posta, vengono recapitate a destinatari che secondo gli anonimi mittenti sono antifascisti. Le lettere contengono l’invito a dattilografare altre sei copie e inviarle per posta ad altrettanti amici che si ritengono di eguale pensiero politico, che vengono invitati a loro volta a ripetere la lettera e così via fino a costruire una catena che si allunga e si allarga all’infinito, con poco pericolo, così si suppone.
Ma qualcuno dei destinatari crede sia una provocazione e consegna la copia ricevuta alle autorità che a loro volta procedono ad indagini che portano all’arresto di:
– tre “popolari”: Albertini, Gagliardi e Smuraglia, impiegati;
– tre socialisti: Fiore, Murgi (avvocati) e Renzi, rappresentante di commercio;
– un comunista: Angelo Sorgoni, insegnante;
– un anarchico: Domenico Nacci, proprietario tipografia;
– un indipendente: Sibilla, commerciante.
Deferiti al tribunale speciale, dopo un anno di detenzione preventiva vengono condannati: il Murgi a due anni e gli altri ad un anno di carcere (già scontato). Ma anche l’avv. Murgi uscirà poco dopo la sentenza.
È trascorso un anno dal primo incontro con i compagni e l’organizzazione si allarga, si potenzia e poiché, malgrado le promesse, nulla giunge dalla “centrale” decidiamo di sostituire il foglio a ciclostile con un foglio a vera stampa tipografica.
Da un rivenditore di oggetti usati acquisto per poche lire un vecchio copialettere a manopola: sarà la pressa. Il compagno Adelmo Pianelli, occupato come tipografo presso una stamperia, coadiuvato da Felice Leonardo, ogni giorno “arrangia” caratteri tipografici corpo 8 corrente, spazi, linee, ecc. Insieme all’occorrente, tutto questo materiale viene portato dentro il “buco stampa”, situato tra le fondamenta di un antico palazzo della “Città Leonina”, cioè il rione Guasco (che è la parte più antica di Ancona). Per accedere a questo locale bisognava passare per una botola situata sotto il letto dei coniugi Bernacchia che avevano accettato di ospitarci malgrado il disturbo in quanto il lavoro si svolgeva prevalentemente di notte.
Tutto procede regolarmente sino alla notte del 31 dicembre 1931.
Qualche tempo prima un deputato fascista, l’On. Fernando Bartolini era stato incaricato dagli uffici romani del suo partito di svolgere un’inchiesta in una federazione fascista dell’Alta Italia. Generalmente le “magagne” dei gerarchi fascisti si risolvono con un “cambio della guardia”, ma questa volta deve trattarsi di cosa importante se i gerarchi presi con le mani nel sacco hanno bisogno di recuperare e comunque bruciare i documenti che il Bartolini ha portato in Ancona e depositato nello studio che egli divide con il notaio Giulio Massi.
Un pregiudicato anconetano, certo Imola, viene incaricato di provvedere. Costui avvicina due disoccupati anconetani, li invoglia e li spinge ad operare un furto nello studio del Bartolini e del Massi, a dar fuoco a tutti i documenti che troveranno, approfittando della notte di Capodanno. I due lavoratori, circuiti dal bisogno (il Bernacchia, un edile disoccupato padre di tre bambini), attratti anche dalla facilità del compito, eseguono il consiglio malvagio e dopo il fatto nascondono la refurtiva (macchina da scrivere, carta, ecc.) proprio nel “buco stampa” dell’organizzazione.
Il 2 gennaio 1932, il tipografo compagno Adelmo Pianelli va come solito la notte per mettersi al lavoro nel “buco” e vede in un angolo del locale materiale che non appartiene all’organizzazione. Poiché sulla stampa locale, con la notizia del furto e dell’incendio, c’è anche un elenco delle cose rubate, indovina l’origine di quel materiale. È preoccupato, anche perché trattandosi di un deputato fascista, il fatto ha destato grande rumore tanto che da Roma hanno mandatoispettori della polizia politi-ca. Avverte subito i compagni responsabili, i quali dispongono l’immediata evacuazione del locale.
Il giorno quattro, lo stesso Imola, pregiudicato e confidente della polizia, fa arrestare il Bernacchia e il suo compagno, il falegname disoccupato Dino Toderi, anarchico, che vengono associati al carcere giudiziario di Ancona, Santa Palazia.
A questo punto ritengo utile riportare parte di una relazione scritta dal Questore di Ancona dell’epoca, rivolta al Tribunale Speciale, come documento di accompagno di nove detenuti inviati a Regina Coe1i di Roma, per l’istruttoria del processo penale.
Relazione per il “Tribunale Speciale”
Avvenuto in Ancona, nella notte dal 31 dicembre U.s. allo gennaio corrente anno, un grave reato contro il patrimonio in danno dell’On. Avv. Fernando Bartolini e del notaio Giulio Massi, e cioè un furto aggravato da più elementi, fra cui l’incendio appiccato negli studi dei predetti, siti in uno stabile di questa città e conseguitasi con il recupero della refurtiva, l’identificazione e l’arresto degli autori nelle persone di Toderi Dino, Bontempi Aniello e Bernacchia Socrate, si poteva stabilire che uno dei responsabili, e precisamente il Bernacchia, nel domicilio del quale era stata scoperta la refurtiva, era uno di quelli che aveva frequenti contatti con altri individui pericolosi e sospetti in linea politica.
Gli indizi affiorati sul Bernacchia medesimo, sorvegliato non solo per la sua capacità a commettere reati comuni in quanto privo o disoccupato, da tempo, faceva ritenere che dal delitto traesse il necessario per sostenere sé e la sua famiglia, ma altresì per la sua condotta dubbia nel campo politico – egli era ritornato da alcuni mesi dalla Francia ove si era recato per ragioni di lavoro quale minatore, trovarono conferma nel fatto che in occasione delle perquisizioni eseguite presso il domicilio di lui e locali attigui, fu rinvenuto un pezzo di carta bianca stampato a caratteri asimmetrici, contenenti, incomplete, frasi offensive al decoro di S.E. il Capo del Governo e di eccitamento all’ odio di classe – appena leggibili – tra un mucchio di ceneri, residuo di carta bruciata, di cui vennero sequestrati i quattro pezzettini annessi, e che senza dubbio, anche per qualche parola leggibile, devono essere avanzi di stampati di carattere sovversivo distrutto a fuoco. L’esame di detto pezzo di carta convinse il sottoscritto, che si trattasse diparte di un campione di manifesto clandestino mal riuscito e stampato qui.
In possesso delle chiavi del sotterraneo del Bernacchia, disposi subito ulteriori diligentissime (sic) ricerche e ricognizioni le quali portarono al sequestro di un manifestino intestato “Proclama al popolo italiano” e che termina con le parole
L’Internazionale comunista – La Federazione Comunista d’Italia”, col contenuto specificato in oggetto; manifestino trovato tra due mattoni del muro sito di fronte’ alla scala del sotterraneo annesso all’ abitazione del Bernacchia, ben celato.
In possesso di tali importanti elementi, i funzionari, procedevano a ripetuti interrogatori di esso Bernacchia e dei corresponsabili del furto, i quali furono per lunga pezza completamente e ostinatamente negativi .
Successivamente, perseverandosi senza tregua, nelle contestazioni, si ottenne che il Toderi Dino, correo del Bernacchia, e la cui attività della delinquenza comune è risultato completamente disgiunta da quella del campo politico, si determinava infine a rivelare fatti, circostanze e persone, che erano venute occasionalmente, a sua conoscenza, nel frequentare la compagnia del Bernacchia.
Le rivelazioni del Toderi, prima parziali e tali da confermare già gli elementi acquisiti e poi più ampie ed esplicite convinsero anche della necessità di agire immediatamente a carico di tutti gli individui sospetti di attività criminosa sovversiva.
E si poteva così stabilire che da alcuni mesi era stata ricostituita in Ancona una organizzazione giovanile comunista, la quale esplicava con ogni circospezione ed abilità, opera di propaganda e di proselitismo specie tra elementi giovanili della classe operaia, e dell’impiego privato sfruttando le attuali condizioni disagevoli degli stessi, creando e deformando episodi politici, facendo apparire prossimo il verificarsi di gravi avvenimenti e che la propaganda era fatta sia oralmente sia a mezzo di manifestini che venivano prima scritti a mano, poi riprodotti col ciclostile a caratteri tipografici che era stato acquistato in questa città e si era quindi impiantata una tipografia clandestina in un magazzino sotterraneo in via Guasco 17, per il cui funzionamento era stato acquistato presso un rivenditore
di oggetti usati un torchio adibito a pressa tipografica, a mezzo ,della quale tipografia erano state stampate numerose copie del “Proclama al popolo italiano”,mettendolo in circolazione tra i compagni di fede, che si adoperavano con tutti i mezzi per infiltrarsi nelle organizzazioni del regime specie giovanili, che si provvedeva alla raccolta di fondi mediante quote settimanali destinate sia a mantenere in vita la ricostituita associazione, sia a sviluppare i mezzi di propaganda, di assistenza ai compagni, ecc.
Gli arrestati ammontano a 20; eccoli:
1) Bernacchia Socrate, di anni 27 manovale, disoccupato; 2) Pianelli Adelmo, di anni 21, tipografo, disoccupato; 3) Maderloni Raffaele, di anni 25, tranviere; 4) Felice Leonardo, di anni 25, viaggiatore di commercio; 5) Pavoni Teodoro, di anni 28, facchino; 6) Elia Gisleno, di anni 30, impiegato privato; 7) Giannini Ruggero, di anni 24, impiegato privato; 8) Magistrelli Aldo,di anni 20,giornaliero, disoccupato;9) Puca Luigi, di anni 27,fornaio, disoccupato; l0) Canafoglia Cesare, di anni 30,muratore; 11) GiuliodoriUmberto, di anni 23, cementista;12) AndreatiniAdrio, di anni 26, giornaliero, disoccupato;13) Mariotti Guido,di anni 18,tracciatore, disoccupato;14) TestaferriAldo, di anni 22,carpentiere, disoccupato; 15) Gagliardi Luigi, di anni 22,giornaliero, disoccupato;16) Agostinelli Ianello, di anni 25, muratore;17) PucaMario, di anni 23,panettiere; 18) Mariotti Mario,di anni 22,calderaio, disoccupato; 19) Puca Guido,di anni 18,pasticcere, disoccupato;20) Pavani Ferruccio, di anni 22,calzolaio.
Gli elencati compresi dal n. 12 al 20 hanno tutti negato di aver conoscenza della tipografia e dei manifestini. Tuttavia non v’è dubbio che essi costituissero la schiera giovanile a disposizione dei dirigenti comunisti, infatti l’Andreatini, il Testaferri, il Gagliardi e il Mariotti Guido, sono sovversivi già noti per aver riportato nel dicembre u.s, una condanna per il canto di “Bandiera Rossa”.
Si fa presene che l’attività criminosa sovversiva degli indicati è pure confermata dal Toderi Dino il quale dichiara anche di aver sentito che il Felice fosse l’agente viaggiatore del partito comunista.
Da quanto sopra esposto evince in modo preciso che l’associazione comunista qui ricostituita, aveva potuto raccogliere elementi che la ponevano in grado di assicurarle l’attività e il funzionamento per esplicare una proficua propaganda fra gli operai e realizzare così scopi di disgregazione e di sovvertimento.
Senza l’intervento tempestivo della polizia, la subdola associazione avrebbe disteso i suoi tentacoli di piovra malefica tra le masse operaie di questa provincia, permeando sempre più, specie di questo periodo di disagio economico, della sua velenosa propaganda gli ambienti più sensibili e tentando ancora di estendere ed approfondire l’opera di penetrazione nelle organizzazioni giovanili del regime.
I reperti sono depositati presso questo Ufficio a disposizione di codesto On.Tribunale Speciale.
Il Questore di Ancona, Lorito
Ho voluto riportare ampio stralcio del rapporto del Questore in servizio in Ancona nel 1932, come diretta testimonianza di quanto sin qui ho scritto circa le misere condizioni economiche della classe operaia in quel tempo.
- È il Questore ad affermare che l’organizzazione comunista “sfruttando le attuali condizioni disagevoli” riusciva ad ottenere successi di proselitismo tra gli operai.
- La subdola associazione avrebbe disteso i suoi tentacoli di piovra malefica tra le masse operaie “specie in questo periodo di disagi economico”.
- L’organizzazione “tentava ancora di estendere ed approfondire l’opera di penetrazione nelle organizzazioni giovanili del Regime”.
- Dei venti compagni denunciati al tribunale speciale, tutti residenti nello stesso rione, il Guasco, ben dieci risultano disoccupati.
- La prova come la polizia faceva spiare, volontariamente o no, i suoi clienti dai gestori di caffè, osterie, ecc.
- Il concetto del questurino che considera il disoccupato (Bernacchia) “da sorvegliare per la sua capacità a commettere reati comuni in quanto privo di mezzi e disoccupato da tempo, faceva ritenere che dal delitto traesse il necessario per sostenere sé e la sua famiglia”.
Sono queste tristi condizioni economiche che facilitano il nostro lavoro politico. A quell’ epoca oltre un centinaio sono i lavoratori organizzati in piccoli gruppi rionali o nei posti di lavoro. L’organizzazione è diffusa tra i tranvieri, portuali, arsenalotti, calzolai, barbieri, in prevalenza giovani. Discreto il numero dei simpatizzanti. Ciò che è incoraggiante è l’adesione di giovani provenienti da ambienti repubblicani, anarchici e, più tardi, dei giovani lavoratori cattolici.
Ed è proprio un mese prima dell’arresto del 24 gennaio 1932, che scrivo una lettera firmata a un deputato fascista denunciando l’ignobile trattamento a cui sono sottoposti i tranvieri avventizi che per otto ore di lavoro percepiscono £. 10,80 e un giorno di riposo ogni 15 giorni e quel giorno senza paga.
Faccio leggere la lettera ai colleghi invitandoli a non aver paura di protestare anche con i sindacati fascisti.
Ancora tra le grinfie della bestia
L’alba del 25 gennaio 1932 mi trova rinchiuso in una cella d’isolamento nel carcere giudiziario di Ancona “Santa Palazia”. Non sapevo ancora come la polizia era venuta a conoscenza del mio nome e nostra attività politica e “tipografica”. Non mi facevo soverchie illusioni.
Passo le prime ore di cl1ausura a riflettere sul come ridurre al le responsabilità dei compagni e se possibile le mie. Erroneamente pensavo che trovato un manifestino nel sotterraneo di Bernacchia, la polizia, caricato quest’ultimo di botte, aveva ottenuto i nostri nomi invece erano stati fatti dall’ anarchico Dino Toderi amico del Bernacchia e che avendo potuto osservare nel “buco talpa” l’apparecchiatura della stamperia, doveva aver pensato di attenuare la propria responsabilità per il furto orientando la polizia a scoprire i responsabili di un reato molto impegnativo del furto stesso. I
Se sotto le botte, Bernacchia aveva fatto qualche nome, di più non poteva aver detto perché egli non conosceva che la nostra atti “diciamo così, tipografica, non conosceva nulla della nostra organizzazione cellulare che d’altra parte era ignota anche a tutti gli altri arrestai.
Attraverso “radio cella” riesco a conoscere i nomi degli altri fermati pericolo c’è l’organizzazione della tipografica e alcuni compagni del rione Guasco. Faccio in modo di invitare i compagni a star calmi, negare o appartenenza all’organizzazione, ecc. Per coloro che risultino comunque implicati nell’uso, nel trasporto, di qualche pugno di caratteri tipografici affermare di essersi prestati senza sapere di che si trattava, comunque presentare la cosa come una “ragazzata”, nulla di veramente importante.
In effetti tutti i compagni si portarono bene, soltanto Leonardo Felice quando non volle, cito le sue testuali parole: «assumermi la paternità una cosa che non è mia».
Si trattava del “duplicatore” che mentre è strano possa essere di proprietà di un tranviere, può esserlo di un rappresentante di commercio con tanto di ufficio, come appunto era il Felice.
Visto che egli insistette che non era il suo dovetti dire che era dove lo avevo acquistato, il che significò l’arresto del compagno Ruggero Giannini perché la polizia interrogando il negoziante seppe che a fare l’acquisto di tale materiale era stato questo compagno.
La linea di difesa servì poco almeno per alcuni di noi e pertanto fummo deferiti al Tribunale speciale.
Da un carcere all’altro
Accompagnati da un maresciallo, un sergente, un caporale e dodici carabinieri, lasciata “S. Palazia”, carcere giudiziario di Ancona all’alba del 14 febbraio 1932, dopo un penoso viaggio, a notte inoltrata, venimmo consegnati ai “secondini” di “Regina Coeli” carcere giudiziario di Roma. Dopo la perquisizione nelle cosce e nel corpo con la relativa divaricazione delle cosce, da una guardia di custodia venni condotto alla cella n. 460 sita al 40 piano del braccio del carcere.
Gli altri cinque compagni, Ruggero Giannini, Teodoro Pavoni, Leonardo Felice, Adelmo Pianelli, Gisleno Elia, erano stati misteriosamente inghiottiti dalla penombra dei corridoi e dal silenzio che gravava, opprimente, in quell’ora, su tutto il tetro edificio. Qualche giorno dopo giunsero a Regina Coeli anche i compagni Canafoglia, Magistrelli e Luigi Puca. Considerati i diversi capi d’imputazione c’era da attendersi un congruo numero di anni di reclusione.
Il giorno prima della partenza dal carcere anconetano, la polizia aveva dovuto avvertire la mia famiglia del mio trasferimento. Mi avevano arrestato il 24 gennaio al termine del lavoro nel turno di notte, in Piazza del Comune, insieme al compagno Felice, prima che arrivassi alla mia abitazione e quindi ancora in “divisa” da tranviere.
La voce del trasferimento degli arrestati si era diffusa ed era legittima la curiosità, oltre che la preoccupazione, di conoscere chi fossero i partenti. Nella notte ancora fonda, le porte di numerose case del popolare rione si erano aperte lasciando passare donne, bambini, uomini che andarono ad appostarsi nelle adiacenze del carcere, in attesa che uscissero i detenuti per essere caricati sul furgone che dovevano condurli alla stazione ferroviaria. Cercai di vincere il buio di quell’alba invernale, per scorgere il volto di mia madre, con la segreta speranza che non fosse tra i presenti. Infatti non aveva avuto il coraggio di venirmi a vedere con gli “schiavettoni” ai polsi e legato alla catena con gli altri compagni.
Dal buio, sino al nostro gruppo, giunse qualche parola di arrivederci e di incoraggiamento, poi il furgone si mosse rapidamente portandoci verso la stazione ferroviaria dove venimmo immessi in un vagone riservato. Sotto la pensilina altra gente era venuta a darci un fraterno saluto di solidarietà.
Nel freddo e buio braccio della “terza sezione”, segregati nella loro cella di S. Palazia, rimanevano una ventina di “sospetti” che sarebbero stati rilasciati dopo ben quattro mesi di detenzione. Soltanto dopo la “sveglia” si sarebbero accorti della nostra partenza avvenuta durante la notte, alla chetichella, nel più rigoroso silenzio, come se avessimo dovuto andare ad un ennesimo interrogatorio. Soltanto tre di loro ci avrebbero raggiunto a Roma: Cesare Canafoglia, Eldo Magistrelli, Luigi Puca.
Dalla notte dell’arresto ero stato gettato in una cella dove la luce del giorno arrivava a malapena di riflesso e per qualche ora del giorno. Da oltre venti giorni non vedevo né il cielo, né il sole, relegato in una cella priva di ogni forma di illuminazione e pertanto costretto a stare sempre al buio.
Ero assetato di luce, aria e igiene.
Entrato nella cella mi precipitai alla finestra gettando uno sguardo attraverso le “gelosie” di vetro che permettevano di guardare verso l’alto e diedi un sospiro di sollievo: nel cielo vedevo brillare una stella che mi parve oltremodo scintillante. Mi guardai attorno e mi accorsi che una lampadina dietro una piccola graticciata, dentro un buco nel muro, in alto sopra la porta, emanava una luce abbastanza chiara per vedere che i muri non portavano tracce di sangue come quelli di S. Palazia, per il gran numero di cimici che vi erano state schiacciate. In un angolo, vicino al bugliolo, un monticello di segatura di legno lasciava capire che le norme igieniche regolamentari erano osservate. Mi gettai di peso sulla branda, mi fregai per qualche attimo i polsi, indolenziti e gonfi, per gli “schiavettoni” portati per tutto il giorno, e con l’animo rasserenato mi addormentai di un sonno senza sogni.
Fu una campana a darmi la sveglia. Mi guardai attorno, incuriosito, senza fretta.
Poco dopo, vestito, ero assorto nella contemplazione di quanto vedevo. Gli spiragli delle “gelosie” lasciavano vedere le mura del Gianicolo sotto il Faro degli Argentini. Vidi anche persone che si affacciavano a quelle mura guardando la città e forse anche il carcere.
Il mio sguardo si immergeva nel verde degli alberi che coprivano i fianchi del colle e si sperdevano nell’azzurro del cielo romano… quando alcuni cauti colpi battuti sul muro alla mia destra attrassero la mia attenzione… Dopo un attimo di silenzio i colpi vennero ripetuti. Essi andavano dalla porta alla finestra come se colui che picchiava avesse considerato che io andassi in quella direzione. Rimasi un poco in forse, temendo un tranello, poi smanioso di affrontare l’incognita, e di parlare con qualcuno, dopo tanto tempo, misi da parte ogni prudenza e avvicina tomi alla finestra mi misi a tossire.
Con accento toscano una voce fioca giunse fino a me:
– Metti l’orecchio al muro. Mentre altri colpi venivano battuti allo stesso punto. Seguii il consiglio e con sorpresa una voce gradevole giunse ai miei timpani, come attraverso un apparecchio telefonico.
– Chi sei?
– Dissi il mio nome aggiungendo: «Ancona!».
– Di che cosa sei accusato?
– Politica, ribattei.
– lo sono di Empoli e anch’io sono un politico. Di qua siamo in tre.
Fatti coraggio e tieni duro che tutto passa.
Poi una serie di insegnamenti come passare il tempo e di avvertimenti. Mi consigliò di non chiamare se non in caso di estrema necessità per non essere sorpresi dai “secondini” che ci avrebbero condotti in cella di punizione.
Così ebbe termine il primo colloquio fatto attraverso il muro del carcere. La voce amica, le fraterne parole ebbero il potere di sollevarmi ancor più lo spirito e farmi adattare con più coraggio alla nuova vita e ad attendere più serenamente gli eventi futuri.
Nei giorni seguenti attesi che l’empolese chiamasse ancora, ma compresi che essendo egli in compagnia non aveva alcun desiderio di sfidare i rigori del regolamento carcerario.
Ritenni giusto il desiderio dei compagni della cella 459, ma incominciai a prestare più attenzione ai rumori che mi giungevano dalla cella 461, cercando di capire se fosse abitata da detenuti o invece fosse utilizzata come ripostiglio dagli agenti di custodia o da detenuti con funzione di scopini.
Avevo 26 anni di età, esuberante di vita, l’ozio assoluto e il silenzio erano terribilmente pesanti. Cercai di passare il tempo facendo “spinelli” per fumare, spaccare in quattro un fiammifero svedese con un ago, per economia, mi allenai con l’alfabeto del carcerato, mi misi a leggere a rovescio l’unico libro che settimanalmente veniva distribuito dalla biblioteca del carcere, acquistai la “Domenica del Corriere” anche perché conteneva il gioco delle parole incrociate che cercai di risolvere servendomi dei carboncini ottenuti con i fiammiferi svedesi immersi nell’ acqua appena accesi. Ma il tempo era maledettamente lungo. I minuti, le ore, le giornate non passavano mai ed erano snervanti. Intanto nessuna notizia da parte della magistratura.
Un giorno decisi di conoscere chi fosse il vicino della cella 461.
Seguendo la tattica insegnatami dall’ empolese picchiai al muro e attesi con una certa curiosità. Dalla finestra mi giunse:
– Chi è?
– Metti l’orecchio al muro!
Ci presentammo e seppi che si chiamava Vindice Cavallera, studente universitario e, mi sembra, figlio di un ex deputato socialista.
Anche lui detenuto per motivi politici. Era di Saluzzo.
Per qualche tempo ci “telefonammo” dandoci il buon giorno e brevissime conversazioni, poi un giorno notai un fatto che ci diede la possibilità di passare molto tempo al telefono murale con maggior sicurezza. Tornando in cella dalla solita ora d’aria avevo notato che il ballatoio ove era la mia cella terminava appena passata quella indicata col n. 461, sicché per andare davanti a questa, bisognava passare davanti alla 460, cioè la mia. Durante l’andirivieni su e giù per la cella avevo notato, all’altezza dello “spioncino” un piccolo foro, da cui, di giorno, filtrava un filo di luce, proveniente dalla grande vetrata che delimitava il braccio. Rilevai che allorquando qualcuno passava dinanzi alla porta della mia cella la luce spariva dal foro per riapparire subito dopo il passaggio.
Con la pazienza propria del carcere allargai il foro per acquistare una maggiore sicurezza, cambiai il posto alla branda in modo da star comodo con l’orecchio al muro e l’occhio fissato sul foro e attesi il “nemico” che amava camminare sul ballatoio con le scarpe felpate. Disteso sul letto, feci più volte la prova fino a quando non fui sicuro di essere in grado di dalla sorpresa l’amico Cavallera e di non farmi sorprendere dal secondino. Dopo di che comunicai la lieta notizia all’ inquilino della cella accanto e ci felicitammo in quanto acquistavamo una maggiore libertà di conversare senza correre il rischio di essere puniti.
L’isolamento, di mesi ormai, ci parve meno pesante. Durante la segregazione in quella cella intrecciammo lunghe conversazioni senza conoscere i nostri rispettivi connotati. Eravamo sottoposti a “grande sorveglianza” e pertanto anche quando venivamo condotti a prendere la giornaliera razione di aria nei “cunicoli” i secondini dovevano fare in modo che, sia nello scendere che nel salire le scale, non dovevamo mai incontrarci.
Sui motivi degli arresti non ci chiedemmo mai nulla, per reciproca delicatezza (anche se ormai io avevo poco da nascondere), parlavamo della nostra posizione familiare, dei nostri cari, sul quando si sarebbero celebrati i processi e a testimoniare la calma, lui membro del movimento clandestino di “Giustizia e Libertà” in attesa di un processo che senz’ altro lo avrebbe portato per vari anni in tristi case di reclusione, attraverso il muro del carcere mi leggeva le sue composizioni poetiche scritte e “limate” su di un pezzo di sapone e io a chiedergli notizie utili per risolvere i miei “puzzle”.
Una sera, tornando in cella dopo un estenuante interrogatorio, nel corso del quale il giudice istruttore, in divisa di ufficiale della milizia fascista, mi aveva promesso la condanna a 12 anni di reclusione, dimenticando che la sera precedente me ne aveva promessi venti, lo chiamai “al telefono”, gli raccontai l’episodio e ne ridemmo come bambini felici che avessi scontato otto anni di carcere nel breve giro di 24 ore.
Una sera stavo passeggiando cercando di vincere la tristezza dell’”ora del carcerato” quando sentii alcuni piccoli colpi picchiati al muro della cella di Cavallera, forse anche lui in preda all’ora serotina. Stavo per rispondere con altri colpi (il buio della sera non mi permetteva di fruire del foro nella porta) quando sento la voce irosa del secondino che rimproverava Vindice e pochi istanti dopo la voce della guardia che mi avvertiva che avrebbe fatto rapporto.
Due giorni dopo questo episodio la commissione di disciplina mi affibbiava cinque giorni di punizione a pane e acqua e cambio della cella. Da allora di Cavalleria non seppi più nulla.
Poche settimane dopo la Liberazione di Ancona, nell’ agosto ’44 ero al mio posto di lavoro quale segretario della federazione anconetana del P.C.I., quando mi venne annunciata una visita. Guardai il volto ignoro di colui che avevano fatto entrare e attesi mi chiarisse il motivo della visita. Egli mi guardò un attimo, poi pronunciò: «1932 – Roma – 4° braccio – Regina Coe1i – cella n.46l!».
Esclamai: «Cella 460 – Presente!». Commossi, fraternamente ci abbracciammo. Erano passati 12 anni di lotta ed eravamo vincitori.
Non ci vedemmo più. Egli era ispettore regionale del Partito d’Azione.
Ero da poco entrato nella cella di punizione e stavo rallegrandomi per il fatto che essendoci un vetro della “gelosia” rotto avrei potuto vedere detenuti mentre prendevano “aria”, con la speranza di vedere qualche compagno. Poi intesi un dialogo tra due detenuti da celle diverse. Mi parve di riconoscere una voce. Infatti era quella di Leonardo Felice.
Dopo le prime notizie sulla salute, mi comunicò che in alcuni processi celebrati in quei giorni, ai membri dei comitati direttivi delle organizzazioni clandestine il tribunale speciale aveva erogato 12 anni di reclusione, il che mi spiegò la minaccia del giudice istruttore.
Non aveva ancora terminato che la voce del secondino mi promise altra razione di punizione. Accidenti, la cosa era grave. Il regolamento carcerario fascista per i detenuti prevedeva un solo pasto ogni 24 ore: un piatto di fetida minestra e 50 grammi di pane. In caso di punizione niente minestra salvo il giovedì e la domenica. Ma la preannunciata nuova punizione non riuscì ad amareggiare il piacere di aver inteso la voce del compagno. Questa volta i giorni di punizione furono tre. Mangiai il pane con un fazzoletto sotto la bocca per non mandare a male le molliche.
Attraverso il vuoto del vetro rotto ho rivisto il compagno Ruggero Giannini durante la sua ora di “aria”. Qualche giorno dopo il Giannini venne liberato perché prosciolto in Camera di Consiglio. Ero riuscito a convincere il giudice che avevo sorpreso la sua buona fede nel fargli acquistare il duplicatore senza che sapesse lo scopo politico.
I compagni di cella
A luglio, dopo sei mesi di isolamento, mi hanno cambiato cella e messo in compagnia. Questo fatto ha degli aspetti positivi, ma anche aspetti negativi.
I primi consistono nel poter scambiare parola, ascoltare notizie e fatti, passare meglio il tempo, l’attesa. I secondi sono soprattutto il dover fare di fronte ad altri quello che generalmente si fa in un gabinetto da soli. E questa è stata per me la cosa più scabrosa.
Appena entrato nella nuova cella, guardo con curiosità i due detenuti che sono già ospiti di essa. Mi presento ad essi che dicono di conoscere il mio nome perché pochi minuti prima il terzo ospite era un altro anconetano, cioè il tipografo Adelmo Pianelli.
Mi dicono che aveva chiesto di cambiare compagnia. Chiedo: «avete litigato, forse?». «No, si era stancato di stare con noi!».
Chi risponde è Vincenzo Plazzota. Ex capitano degli alpini nel reggimento comandato da quel colonnello Zaniboni, già condannato dal fascismo per aver organizzato un fallito attentato al duce. È figlio dell’ex presidente delle Cooperative Carniche Socialiste.
Il Plazzota è accusato di spionaggio a favore di una potenza straniera. È un aviatore, mentre volava, con un apparecchio dalla Francia diretto a Malta, costretto ad ammarare allargo della Sardegna era stato arrestato dalla milizia italiana. Trovato in possesso di molto denaro in valuta straniera era detenuto in attesa di processo. Era anche accusato di complicità con antifascisti di “Giustizia e Libertà”. Racconterà poi di essere amico di Bassanesi, l’aviatore che ha gettato manifestini antifascisti su Milano e che egli stesso aveva portato sul lago di Garda sacchi di materiale antifascista.
Il secondo detenuto è un compagno romano. Si chiama Duilio, abita alla Valle dell’Inferno. È accusato di aver diffuso materiale antifascista ed è in attesa di processo.
Sono tutti e due senza una lira, ed io mi sto consumando i pochi soldi che mia madre ha rimediato per l’avvocato difensore. Acquisto allo spaccio tabacco per tutti e tre e ogni giorno compro due razioni di patate o di fagioli e dividiamo fraternamente in tre.
Passiamo il tempo a parlare di politica e di esperienze personali. Il Plazzota ha molta immaginazione e racconta fatti relativi alla sua attività di spionaggio. Molte saranno bugie ma poiché in un momento eh abbandono narra di essere stato nell’Unione Sovietica e, mi par di capire per conto dello spionaggio inglese, sento di non poterlo più sopportare e decido di chiedere il cambio di compagnia. Il Pllazzota verrà poi condannato a l0 anni di reclusione per spionaggio e qualche anno dopo mi farà pervenire i saluti da parte di Cola Cafiero, un compagno con il quale è stato recluso.
Vengo condotto al VI braccio e messo nella cella n.670. Gli ospiti che ci trovo sono due compagni, il romano Armando Antognini e un romagnolo di Lavezuola di cui non ricordo il nome. Il primo un edile, il secondo un bracciante. In fatto di cultura sono del mio stesso calibro: elementare ma anche loro sono pieni di coraggio e di speranza. Le accuse solite: adesione al Partito comunista.
“Vogliamo i processi!”
Nella cella 670 l’atmosfera è più fraterna di quella che regnava al 421. Si discute tutto il giorno. Argomenti politici, le speranze per l’avvenire, : ‘Unione Sovietica, la situazione politica in Germania dove ancora il nazismo non è al potere.
Si attende con una certa ansia l’arrivo in cella delle “carte processuali” e quindi il processo e l’avvio alla casa di reclusione, con la speranza di capitare con compagni che siano più preparati di noi. Ognuno si augura di essere mandato alla casa di pena di Volterra, “Il Mastio”, dove è recluso il compagno Mauro Scoccimarro che, in camerata, dà lezioni di economia politica. Altro nome che si sente nominare spesso, come compagno preparato, è quello di Umberto Terracini.
Nel VI braccio la disciplina carceraria è allentata. Nel vicino “cameroncino” i detenuti sono cinque, parlano e le loro voci giungono sino alla nostra cella. Qualche volta cantano in coro: è così che, scrivendo con il sapone sul vetro della finestra, impariamo musica e parole di due canzoni: “L’inno del lavoro” e “La guardia Rossa”, che anche noi canteremo sommessamente andando avanti e indietro, tra la porta della cella e la finestra, incolonnati. Qualche volta una guardia di custodia che abbiamo soprannominato “La guardia rossa”, durante il suo turno ci passa il “Giornale d’Italia”, così cerchiamo di seguire gli avvenimenti del mondo.
All’ufficio scientifico mi hanno ancora una volta preso le impronte digitali, mi hanno misurato per lungo e per largo. Al ritorno, per un errore della guardia, mi trovo in un’altra cella tra le braccia del compagno Teodoro Pavoni, ma è per un attimo perché riaprono la porta e mi riconducono nella mia.
Ho inteso ancora una volta la voce del compagno Felice e quella del compagno Luigi Puca che si trova nel vicino cameroncino insieme a Clemente Maglietta, futuro deputato del P. C.I. Che si respiri un’atmosfera di entusiasmo è dimostrato dall’atteggiamento del compagno Adelmo Pianelli che in una lettera ai giudici del tribunale speciale scrive una “dichiarazione di fede al comunismo”.
Nell’agosto la polizia ha effettuato massicci arresti di antifascisti nei Castelli
Romani, il carcere è affollatissimo, nelle celle manca l’aria e di processi non se ne parla. Si avvicina l’anniversario della “marcia su Roma” e servendoci delle normali vie di comunicazione tra detenuti, si organizza per il giorno 28 ottobre il rifiuto del “pranzo speciale”. Motivo: vogliamo i processi.
Nel carcere si creò un’atmosfera di nervosismo, che andò continuamente aumentando quando un detenuto comune tornato dal suo processo, alla finestra della sua cella situata al VII braccio, annunciò a squarciagola che il suo avvocato gli aveva garantito che in occasione del decennale della marcia su Roma, il governo avrebbe varato un decreto di amnistia. Fin qui nulla di male, poi attaccò una sfilza di evviva “er duce”, ecc.
Un finimondo di urla, di fischi, di “abbasso Mussolini” e di evviva il comunismo.
Dal carcere femminile, “Le Mantellate”, giungevano fino a noi gli urli delle nostre compagne detenute.
Nei giorni successivi filtrò l’idea di salutare l’alba del sette novembre – anniversario della Rivoluzione di Ottobre – con il canto di tutti i detenuti; inno da intonare: l’internazionale. Il mattino del sette novembre, una voce, ancora prima del suono della campana per la sveglia, intonò: «Compagni avanti il gran partito…» – centinaia di voci ripresero la strofa – «… noi siamo dei lavoratori…» – poi improvvisamente un urlo: -Aiuto compagni mi ammazzano!».
L’invocazione veniva da una cella del nostro braccio, seguì una baraonda infernale, sportelli che cadevano, brande tirate contro la porta, vetri infranti, l’urlo: «Assassini, lasciatelo!». Tutti i tremila detenuti di Regina Coeli, comuni e politici erano preda dell’isterismo. E ci volle l’assicurazione delle guardie di custodia che il compagno era stato l’asciato in pace perché il silenzio tornasse.
Amninistia
Verso la metà di novembre de1 1932, per effetto dell’ ”amnistia del decennale”, Regina Coeli incomincia a vuotarsi dei detenuti politici e comuni. Vengono liberati Cesare Canafoglia, Gisleno Elia, Luigi Puca e Aldo Magistrelli. Ho già scritto che per sentenza della Camera di Consiglio anche Giannini era tornato ad Ancona nel maggio. Nel carcere siamo rimasti Leonardo Felice, Teodoro Pavoni, Adelmo Pianelli e io, ritenuti maggiormente responsabili, così suppongo.
I miei due compagni di cella sono già stati liberati. Dal 4° piano del ”1° braccio mi hanno fatto scendere al 1I ° piano e mi sono trovato con due nuovi compagni: Vittorio Raffaelli di uno dei Castelli Romani, e l’altro Salvatori di Roma.
Veramente la notizia che diversi anconetani erano stati liberati mi aveva aperto l’animo alla speranza talché intesa la sacramentale frase: «Maderloni Raffaele, fuori con tutta la roba!», pensai: «Ci siamo!». In un attimo raccolgo tutto nella coperta e scendo le scale seguendo la guardia. Giunto al primo piano mi fanno entrare nella cella 624, la porta viene rinchiusa senza proferir parola. Attendo, poco dopo la porta si riapre ed entrano Raffaelli e Salvatori. Qualche minuto dopo, dallo spioncino la guardia dice: «Non andate a letto?». Pensiamo che ormai è tardi, che forse sarà per domani la liberazione. Ma i giorni passano e la speranza si dilegua.
Ora si tratta di tornare a ricostruire nell’ intimo la forza necessaria per affrontare la condanna e il carcere. Passano così altri giorni e ai primi di dicembre mi giunge la notizia che anche Adelmo Pianelli è stato amnistiato. La notizia mi riempie di gioia, perché so che Adelmo è malato ed ha bisogno di cure.
Il 14 dicembre sono all’aria nel “cubicolo”, si avvicina il capo guardia che mi dice: «Ti piacerebbe essere messo in cella con i tuoi paesani?». Rispondo: «Certo, perché significa che siamo prosciolti anche noi!». «Infatti così è!» risponde.
Qualche ora più tardi nella cella dove sono rimasto solo entrano Teodoro Pavoni e Leonardo Felice. Commossi ci abbracciamo e ci si scambia le prime impressioni.
Invio un telegramma a mia madre per comunicare che sono prosciolto ma che rimango a disposizione della Questura di Ancona.
Da Pavoni sappiamo i motivi del silenzio da parte del partito dal 1928 al 1931. Il mistero è stato chiarito da un funzionario del Partito: Premoli, che, in cella con il Pavoni, gli accenna che molte volte presentatosi a Luigi Mercanti, con la parola di riconoscimento e con le valigie piene di materiale destinato alla nostra organizzazione, non aveva potuto consegnarle perché il Mercanti si ostinava a far finta di non capire. Il comportamento di questo compagno ci addolora anche perché se fossimo entrati in possesso di quel materiale non saremmo stati obbligati a stampare e non sarebbe successo quello che è successo. Comunque ora sappiamo che il partito è in piedi e lavora, questo per noi è motivo di incoraggiamento.
Il 23 dicembre 1932, con le solite manette ai polsi, stiamo viaggiando in cellulare diretti al carcere di Ancona, quando a Jesi, da un detenuto sappiamo che uno dei compagni amnistiati è di nuovo incarcere. Ci chiediamo: «Chi sarà?».
A S. Palazia siamo di nuovo isolati, ma al mattino protestiamo e chiediamo di essere messi tutti insieme. Si vede che “nulla osta” perché poco dopo mi trovo in cella di nuovo con Felice e Pavoni. Siamo insieme da pochi minuti e ci chiediamo cosa vorrà fare di noi la questura, quando la porta torna ad aprirsi e il compagno Pianelli viene fatto entrare.
Molto commossi, ci abbracciamo, poi gli chiediamo come mai lo hanno preso di nuovo. Egli racconta la storia della “dichiarazione di fede al comunismo” inviata ai giudici del tribunale speciale e continua dicendo che il questore gli ha chiesto di ritirare quella dichiarazione. Egli si era rifiutato e pertanto lo avevano denunciato alla Commissione provinciale per il confino, ed era in attesa della decisione.
Ha appena terminato il racconto che la porta torna ad aprirsi ed ancora la sacramentale frase: «Maderloni, Felice e Pavoni – fuori con tutta la roba!». Un attimo di smarrimento; come: lasciare solo il compagno Pianelli! Ma non c’è nulla da fare. Abbracci, parole di incoraggiamento e di solidarietà. Si vede che è commosso. Poi dobbiamo lasciarlo.
Consegnati dai poliziotti alla questura senza altra formalità, veniamo rilasciati e con i nostri cari torniamo a casa. Dal giorno dell’arresto sono trascorsi esattamente 11 mesi.
Un atto di fede
Nella mia ventennale lotta al fascismo mi sono imbattuto in vari tipi di compagni di strada: da colui che alla prima avvisaglia di pericolo si ritrae per non pagare il suo antifascismo con la persecuzione e si mette in congedo illimitato; all’altro compagno che ha contatto con altri combattenti, di fronte alle maggiori ostilità, si entusiasma e continua la lotta con una volontà, direi sadica.
Questo è il caso del compagno Adelmo Pianelli. Nel gennaio 1932, ha appena compiuto 21 anni, deve rispondere di numerosi reati politici che contemplano numerosi anni di galera. All’inizio nel fetido carcere anconetano subisce, com’ è umano, uno scossone, poi si riprende e reagisce. Tradotto in carcere a Roma per essere processato dal Tribunale speciale, non lascia passare tanto tempo che darà dimostrazione che intende continuare la lotta e che il carcere, la segregazione, l’avvenire non gli hanno messo paura, che nuova linfa trae per alimentare la sua fede dal contatto con altri combattenti che incontra nel carcere.
Generalmente chi attende di essere giudicato non compie atti che possono aggravare la sua posizione dinanzi ai giudici, qualcuno forse pensa di chiedere clemenza, Adelmo Pianelli invece indirizza ai giudici del Tribunale Speciale, una dichiarazione di fede negli ideali comunisti, atto di fede che generalmente il partito invita a fare di fronte ai giudici, quando lo ritiene necessario, in certe straordinarie circostanze.
Lo scopo di queste righe è quello di documentare con quale spirito si combatteva la violenza fascista, tenendo conto che nel 1932 nessuno spiraglio consentiva di vedere la luce della libertà. Dovevano passare ancora dieci anni prima di poter salutare la vittoria di Stalingrado.
Il compagno Adelmo Pianelli pagò con otto anni di deportazione- da un’isola all’altra e con numerosi arresti la sua audacia. Combatté la sua battaglia contro il fascismo, in carcere, al confino, nella Resistenza meritandosi per il suo spirito agonico, malgrado le cattive condizioni del suo fisico, l’appellativo” Agonia”. Ha sempre desiderato vivere e morire in Ancona. Desiderio non soddisfatto perché le sue ossa sono sotterrate nel cimitero di Milano.
La lotta continua
L’arresto del gennaio 1932 aveva decapitato l’organizzazione, ma all’infuori della cellula operante nel rione Guasco, tutto era rimasto intatto. Date le condizioni esistenti allora nessuno aveva preso, né poteva prendere, iniziative tendenti a riallacciare il collegamento.
Qualche cosa però era successo. Il partito aveva avuto notizia dei nostri arresti e aveva mandato un funzionario per esaminare la situazione e questa volta Luigi Mercanti non aveva avuto modo di sfuggire alle sue responsabilità che nessuno gli imponeva, sarebbe stato sufficiente che avesse detto che non poteva più assolvere quel compito.
Comunque questa volta mette in contatto il funzionario con un compagno al quale viene consegnato un “clichè” per stampare alcunecentinaia di manifestini antifascisti.
Come avvenivano, o meglio come avrebbero dovuto avvenire, i contatti tra L. Mercanti e gli emissari del partito? Il Mercanti aveva un negozio di barbiere dirimpetto all’albergo “Roma e Pace”, in via G. Leopardidi Ancona. Quando un cliente dell’albergo desiderava il servizio di barbiere da eseguirsi in camera, l’incarico veniva dato al Mercanti con il quale aveva un contratto 1’albergo. Ad un certo momento del servizio alcune parole e segni convenzionali segnalavano al barbiere che quel cliente era un compagno.
Purtroppo sappiamo già per dichiarazione fatta dal compagno Premoli a Pavoni, ambedue detenuti al carcere romano, che il Mercantidiverse volte tra il 1929 e il 1931 fece finta di non capire e pertanto l’emissario del partito dovette riportare indietro il contenuto del doppio fondo delle sue valigie.
«Quando tornate ad Ancona dategli una lezione!» dirà Premoli a Pavoni. Ma al nostro ritorno Mercanti non è più in Ancona, è emigrato a Milano e andandosene si è portato appresso £. 2.000 che gli sono state consegnate da Cino Del Duca, un compagno che nel 1923 ha dovuto abbandonare Ancona
e riparare a Milano per non continuare a subire le violenze fasciste. Si è dedicato ad attività editoriale, ha fatto fortuna. TI denaro è per i compagni detenuti a Roma, ma si vede che Mercanti si considera più bisognoso dei detenuti e si è tenuto le duemila lire. Allegria!
Ad utilizzare il “clichè” e alla diffusione delle copie del manifestino antifascista ci pensano i compagni Gino Grilli, Remo Garbati, Adrio Andreatini, Pio Montironi, ecc. In particolare viene lanciato entro le mura del cantiere navale e questa è l’unica attività svolta durante l’anno 1932.
Nel febbraio 1933, chiamato ad una riunione mi trovo davanti a nuovi compagni.Essi sono: Augusto Dino Carelli, Fazio Mercanti e Gino Grilli.
Il primo è un diplomato, capitano di macchina, insomma ha fatto:’Istituto Nautico, è impiegato privato. La moglie Anna Mondaini è anch’essa diplomata e insegnante in una scuola elementare. Hanno due figli di pochissimi anni. Carelli che non ha ancora trenta anni, è originario della parte più sana della gioventù repubblicana. Anche il Fazio Mercanti -~ un diplomato ed è impiegato comunale, celibe, stessa origine del compagno Carelli. Gino Grilli, nato nel 1906, ha conseguito il diploma delle scuole tecniche, ed è impiegato presso l’Azienda Autonoma della Strada (AA.SS.). Il padre ha un laboratorio di pelletteria.
Intendo dire che questi compagni sul piano sociale,classista, appartengono al “ceto medio”; si avvicinano al Partito comunista nel momento ~ in cui c’è tutto da rimettere e niente da guadagnare. Non sono spinti dalle condizioni di miseria, hanno operato una libera scelta. Stanno a dimostrare l’influenza che già il P.C.I. esercitava anche sugli altri ceti.
Alla riunione è presente anche Leonardo Felice e insieme esaminiamo la situazione. Essa va peggiorando. Il regime fascista non accenna a lasciare la presa, la disoccupazione è in continuo aumento e con essa aumenta la concorrenza tra i lavora-tori occupati (e mal pagati) e quelli disoccupati. La fame indebolisce, avvilisce, invigliacchisce e mette gli uni contro gli altri. E su questo il fascismo fa conto.
Per fronteggiare il malcontento tra i lavoratori, aumenta la vigilanza da parte dei “Circoli rionali fascisti”, dell’Ovra, dei carabinieri, delle diverse milizie fasciste e della polizia. La maggioranza degli italiani è irreggimentata qualunque sia l’età: i figli della lupa, balilla, avanguardisti, giovani fascisti, gruppi universitari fascisti; partito fascista, la milizia fascista portuaria, confinaria, ferroviaria, forestale e quella cittadina divisa in manipoli, coorti, legioni, ecc. E numerose altre organizzazioni sindacali maschili e femminili. Il tutto sotto il controllo dell’apparato statale fascista.
Concludiamo che è proprio questo apparato di difesa che indica quanto il fascismo si senta impopolare e che anche in Italia l’opposizione lavori e lotti è dimostrato dal gran numero di operai, contadini, studenti che erano e sono in carcere. Così come il gran numero di “funzionari”, “corrieri” del partito comunista arrestati dimostra che il Partito dei lavoratori è in piedi e presente, attivo.
Decidiamo che, tutti e cinque, costituiamo il nuovo comitato direttivo dell’organizzazione che si propone:
- a) cercare di riprendere il contatto con il “centro”;
- b) riprendere il contatto con i gruppi e le cellule della città e della provincia;
- c) allargare i contatto con i compagni delle Marche;
- d) organizzare un centro per la stampa e la diffusione del materiale antifascista.
Sul piano internazionale le cose non vanno come abbiamo sperato. Si seguiva quanto avveniva in Spagna e in Germania augurandoci che la situazione si fosse evoluta in senso favorevole al proletariato di questi paesi e naturalmente che ciò potesse beneficamente influire sull’andamento della politica in Italia.
Una provocazione
I “conosciuti” per i precedenti politici non potevano avere vita faci1e.. . Avevano contro tutte le polizie del regime oltre che i fascisti, gli opportunisti di vario genere, i parenti degli amici, i genitori dei giovani che temevano sempre la maligna influenza degli attivisti antifascisti
La vita continuava normalmente e tutto sembrava andare per il meglio. Il regime si consolidava, almeno apparentemente, e passava, a dire degli organi d’informazione, di vittoria in vittoria. Nei ritrovi del proletariato, in cartoni affissi al muro, si poteva leggere: qui non si parla di politica.
Sarebbe stato possibile tentare un reinserimento nella vita normale. Mettersi in finestra, sorridere a destra e manca, fare i propri interessi, fare quello che in fondo il fascismo voleva dai suoi avversari, e attendere lo sviluppo della situazione come altri hanno fatto. Ciò avrebbe significato totale disinteressamento alla politica. Ma si vede che non confaceva al mio temperamento.
Comunque, uscendo dal carcere alla vigilia di Natale 1932, mi trovai senza lavoro, poiché l’Azienda Tranviaria, prendendo a pretesto che ero stato assente dal lavoro oltre cinque giorni senza giustificazione, mi aveva licenziato in tronco. Senza mezzi di fortuna, senza un mestiere da professare in forma autonoma, l’avvenire non si presentava roseo. Né potevo sperare in aiuti dai lavoratori, date le difficili condizioni della classe operaia. Non si dimentichi che dei venti compagni arrestati nel gennaio 1932, ben dieci risultavano disoccupati.
È vero che ancora ero celibe, ma avevo una madre che cominciava a farsi vecchia e inoltre avevo dei doveri, sia pure morali, nei riguardi della mia fidanzata, che malgrado amassi, durante il periodo di detenzione, prevedendo di dover fare numerosi anni di carcere, avevo pregato di non legarsi alla mia vita, al che lei aveva risposto: «Aspetterò trent’anni!». Bisognava quindi trovare un’occupazione, il modo di guadagnarsi un pezzo di pane; anche se a fare questa ricerca eravamo in molti.
Un giorno, dopo aver girovagato per la città in cerca di un qualsiasi lavoro, tomo alla mia abitazione. Al vedermi mia madre mi avverte che tra poco tornerà un tale che poco prima aveva lasciato la nostra casa, continua e mi dice che costui le ha detto di essere un compagno uscito da qualche giorno dal carcere di Roma dove è stato seviziato dalla polizia e desidera parlare con me.
Infatti poco dopo ecco presentarsi un tale che dice di chiamarsi Beni, che è un compagno, che è uscito dal carcere e che desidera espatriare clandestinamente o meglio desidera avere da me consigli sul come fare per avere un passaporto falso. Ha l’aria dimessa, patita (mia madre, commossa dal racconto che costui le aveva fatto circa il carcere e le sevizie patite, gli aveva già dato prima un piatto di minestra).
Alla domanda di chi lo aveva mandato da me, risponde: «Galeazzi degli Archi!». Ho subito il sospetto che sia un provocatore, ma senon lo è? Scherzando gli dico: «Vuoi un passaporto? Non sono mica il ministero degli esteri. Comunque vieni domani alle 13 in piazza del Comune, ma bisogna che ti faccia accompagnare da Galeazzi!».
Mi affretto ad avvertire i compagni Teodoro Pavoni e Ruggero Giannini perché il giorno dopo, all’ occorrenza, mi diano una mano.
Il giorno dopo al punto e all’ ora indicati ecco costui presentarsi da solo. Dice: «Galeazzi ha detto che non è opportuno farsi vedere insieme». Gli rispondo: «Sarà bene che tu te ne vada! Sei un miserabile provocatore; ti ha mandato l’Ovra?!».
Egli impallidisce, balbetta qualche cosa tra i denti, poi scappa. Qualche ora più tardi, mentre con Giannini mi trovo in Piazza Roma, ho la prova che effettivamente è un provocatore, perché insieme a due della milizia fascista stanno dirigendosi ver-so una rivendita di vino in vicolo Benincasa. Qualche tempo dopo vengo a sapere che è un nuovo impiegato del Municipio. Per la sua attività devono averlo premiato.
Condizioni sempre più difficili
Con la costituzione del nuovo comitato direttivo l’organizzazione ha ripreso la sua attività in condizioni sempre più difficili, per parecchi motivi, ma due in parti-colare che li riassumevano.
Il primo motivo era la riuscita di alcune iniziative del regime nel campo della produzione (battaglia del grano); la bonifica di alcune zone malariche molto diffuse in Italia (Pontinia, Sabaudia, ecc.); alcune trasvolate aeree (Del Prete, De Pinedo, Balbo) e soprattutto la demagogia di Mussolini che tentava di far credere che il fascismo andava verso il superamento del capitalismo. Questa situazione creava il secondo motivo: cioè la sfiducia nella possibilità di far crollare il regime.
Intanto siamo privi di ogni contatto col “centro” del partito, ciò significa che ci troviamo ad affrontare problemi più grossi delle nostre possibilità. In realtà viviamo in un mondo carico di sospetti, di diffidenza, dove perfino combattenti democratici si sono lasciati andare alla deriva, non hanno più fiducia che certi fattori possano avere la forza di modificare la situazione,anzi temono che l’azione di altri antifascisti possa determinare l’arresto in massa degli antifascisti noti per il loro passato anche se in modo particolare il trattamento è riservato ai comunisti e a qualche anarchico.
Di costoro molti, piuttosto che aderire alla lotta contro il fascismo, preferirono isolarsi dalla vita politica, assumere un atteggiamento di idoli offesi, riservandosi per il… momento buono. Ma ci sono anche certi tipi che non avendo il coraggio di aderire alla organizzazione clandestina e non volendo dimostrare di essere scivolati nell’ opportunismo, mettono in giro voci tendenti a discreditarlo, affermando che non aderiscono perché essa è diretta da “giovani inesperti”, da “faciloni” o addirittura da “spie”. Anche per questi ci volle Stalingrado a toglierli dal letargo e rivendicare la loro posizione di perseguitati dal fascismo.
Ma di fronte a questi aspetti negativi, vi era anche una terribile realtà, come quella della presenza di un milione e mezzo di disoccupati oltre che alle centinaia di migliaia di semi occupati, le paghe degli operai occupati ridotte ai minimi termini, i ritmi di lavoro accelerati, i “cottimi” decurtati e i padroni che profittando della situazione, evadono il versamento per le assicurazioni sociali.
Lo scontento tra la massa operaia è diffuso anche se non si esprime apertamente. Da ciò il convincimento che necessita continuare la nostra attività organizzativa e propagandistica allargandola a tutta la regione.
Nel luglio 1934 si incontrano a Civitanova Marche i compagni Fazio Mercanti, Augusto Dino Carelli e Leonardo Felice tutti di Ancona – Mario Pianesi, Vincenzo Gabascia e Tamburri- tutti di Macerata -l’avv. Andrea Iommi di Massa Fermana, Zeno Rocchi di Sarnano e Alcide Silenzi di Portocivitanova.
Temi dell’incontro: esame della situazione politicaed organizzativa, iniziative per contatti con il “centro”, stampa clandestina, problemi delle alleanze, varie.
Avrebbe dovuto essere presente anche un compagno rappresentante della Sicilia: Vito Gafà. Ma non è venuto.
Da questo incontro i compagni constatano che:
- a) per le prepotenze dei dirigenti sindacali fascisti che d’accordo con il regime e i padroni hanno deciso di ridurre i salari, lo scontento, sempre più, serpeggia tra la massa operaia;
- b) esistono forti preoccupazioni tra i lavoratori per i pericoli di una guerra tra l’Italia e 1’Abissinia, nella quale a pagare le spese sarebbe, come sempre, la gioventù operaia e contadina.,
Decidono di intensificare la loro attività e di studiare il modo di organizzare una tipografia clandestina per la stampa di materiale di propaganda.
Il 23 febbraio 1935 le squadre politiche della Questura di Macerata e di Anconaprocedono ad una retata di compagni. Qualche tempo prima, in Sicilia, era stato arrestato il compagno Vito Gafà e con lui anche numerosi studenti universitari, operai e contadini. L’Ovraaveva avuto sentore dell’incontro di Portocivitanova, sottoposto ad interrogatorio Leonardo Felice, ottenendo da questi alcune ammissioni, anche se di scarsa importanza.
Pertanto la polizia di Macerata, aveva arrestati e tradotti al carcere giudiziario di Ancona: Mario Pianesi, operaio; Vincenzo Gabascia, operaio; Italo Tamburri, operaio; Andrea Iommi, avvocato; Alcide Silenzi, artigiano; Zeno Rocchi, calzolaio. Mentre la questura di Ancona aveva arrestato: Fazio Mercanti, impiegato comunale; Augusto Dino Carelli, impiegato privato; Gino Grilli, impiegato statale; Leonardo Felice rappresentante.
Inoltre, poiché l’Ovra era alla ricerca dei responsabili del lancio di manifestini antifascisti al Cantiere Navale, nel 1932, la polizia aveva arrestato: Vincenzo Marchegiani, edile; Adrio Andreatini, manovale; Pio Montironi, operaio Timo; Remo Garbati, meccanico; Guido Mariotti, commesso; Mario Mariotti, meccanico; Guido Puca, fornaio; LuigiPuca fornaio; Ferrucio Pavani, calzolaio; Orfeo Massarenti, verniciatore.
Aveva messo in carcere anche: Raffaele Maderloni e Teodoro Pavoni, ambedue nell’incontro di Portocivitanova e ambedue in carcere a Roma nel ‘1932, pertanto al di sopra dei … sospetti …
Come vedremo, queste assenze non servirono a nulla.
Malgrado i continui interrogatori, la polizia non riesce ad ottenere prove che possano costituire elementi di accusa tali da giustificare la denuncia al T.S. sia per 1’incontro di Portocivitanova che per il lancio dei manifestini al Cantiere navale nel 1932. L’Ovra crede di essere davanti ad un tentativo velleitario, senza conseguenze, da qui la denuncia alla Commissione Provinciale per il Confino, per un provvedimento amministrativo che mandi al confino per un certo periodo di tempo alcuni degli arrestati.
La Commissione decise:
– Pianesi, Gabascia, Tamburri, per cinque anni all’isola di Ponza;
– Iommi, Silenzi, Rocchi, sottoposti per due anni all’ammonizione;
– Carelli, Grilli, Maderloni, per cinque anni all’isola di Ventottenne;
– Pavoni Teodoro, sottoposto per due anni alle norme dell’ammonizione
– Moccheggiani Vincenzo, due anni di residenza obbligata ad Eboli (SA).
Tutti gli altri rilasciati dopo un mese e mezzo di carcere senza conseguenze.
Dopo 67 giorni di detenzione a S. Palazia, all’albadel Venerdì 3 maggio 1935, con gli schiavettoni ai polsi e incatenato a Grilli e Carelli, scortato da tre carabinieri, vengo condotto in uno scompartimento di un convoglio ferroviario. Essendo la nostra una cosiddetta “traduzione straordinaria” abbiamo il privilegio, per modo di dire, dello scompartimento riservato per tutta la durata del viaggio.
Giunti alla stazione romana di Termini, ci fanno scendere per introdurci in una “camera di sicurezza” piena di sporcizia e senza toglierci né la catena che ci tiene uniti né gli schiavettoni. Protestiamo. Arriva un capitano dei carabinieri, riconosce giuste le nostre proteste, ma non fa nulla per eliminare i motivi che le hanno provocate.
Dopo poco tempo veniamo condotti al treno in partenza per Napoli.
A Formia altro cambiamento di treno, poi via fino a Gaeta. Qui giunti siamo portati al carcere mandamentale e rinchiusi in una camerata dove stanno dormendo una ventina di detenuti. È mezzanotte e finalmente possiamo coricarci stanchi e indolenziti per il lungo viaggio in così bestiali condizioni. Ma prima di metterci in branda offriamo “spinelli” a tutti i detenuti che si erano svegliati alla nostra entrata in cella.
Al mattino, svegli, schiavettoni ai polsi e catena, tutto ciò al posto della… colazione. Lasciato il “mandamentale” sempre accompagnati dagli angeli custodi, raggiungiamo il porto di Gaeta e imbarcati su di un piccolo piroscafo veniamo rinchiusi di nuovo in “camera di sicurezza”, senza che ci siano tolti i ferri che ci tengono avvinti i polsi. Protestiamo, ma non serve a nulla. Il natante parte e non ci rimane che guardare, malinconicamente, dall’oblò la costa che sempre più si allontana.
Il mare ci è favorevole e in poche ore arriviamo all’isola di Ponza: sbarchiamo e veniamo condotti al carcere mandamentale dove dovremo passare la notte. Al custode che registra il nostro passaggio in quel carcere ingenuamente chiediamo se all’isola di Ventotene ci sono confinati “politici” o”comuni”. Ingenuamente perché oggi non vedo la ragione di tale domanda. Comunque mentre il secondino scrive i nostri dati risponde: «Sì, ci stanno li comuni, li comunisti!». È evidente che non è in grado di vedere la differenza tra i confinati politici e i “comuni” cioè coloro che per tutt’altre ragioni, escluse quelle politiche, vengono avviati al “domicilio coatto”.
Il giorno dopo, ancora una volta i ferri ai polsi, la “camera di sicurezza” del piroscafo ha partenza da Ponza e dopo aver costeggiato l’isola di Zenone, il natante getta l’ancora qualche distanza dall’isola di Ventotene.
Il vaporetto si ferma in rada non avendo l’isola un molo d’ accostamento se non per barche e bragozzi. Sempre incatenati “al par dei malfattori” veniamo faticosamente e fortunosamente calati in una barca che sta ballando una scomposta tarantella e dopo un percorso di circa cento metri poggiamo i piedi sulla terraferma: è il 5 maggio 1935, domenica.
Vediamo sulla vicina mura sovrastante una piccola folla di confinati, troppo esigua per le nostre aspettative: infatti dopo poco verrà chiarito il mistero di così scarsa rappresentanza confinaria.
Sempre inchiavardati e incatenati saliamo le tre brevi rampe a tornanti e arriviamo alla palazzina della Direzione della colonia, dove i carabinieri si riprendono tutte le loro “ferramenta”, ansiosi di ripartire subito per il continente, ci affidano alla amorosa cura della polizia.
Nell’ufficio matricola della Direzione, dopo la normale routine di registrazioni varie, ci viene consegnato il “Libretto di permanenza” che sarà il nostro passaporto per tutto il periodo del confino e che dovremo portare sempre con noi per mostrarlo ad ogni richiesta degli “addetti ai lavori”. Nel libretto sono elencate meticolosamente tutte le norme di cui dobbiamo tener conto con scrupolosa osservanza poiché in caso di difetto, il pedaggio minimo che si paga sono tre mesi di carcere da scontarsi nel penitenziario napoletano di Poggioreale.
Il poliziotto-magazziniere ci consegna le coperte e ci indica il Castello dove ci è fatto obbligo di dimorare, sulla soglia del quale ci lascia “liberi”. Il Castello è una costruzione quadrata a tre piani, oltre il pianterreno, con inferriate alle finestre, fabbricato in tufo come la maggior parte delle costruzioni dell’isola. Lo circonda un fossato dove si affaccia il pianoterra adibito a prigione e servizi vari. Insomma questo Castello è proprio un casamento carcerario dovei confinati vi sono costretti dalle 19 alle 7 del mattino. Liberi di entrare o uscire per il resto dell’intera giornata.
All’isola di Ventotene
Usciamo dai locali della Direzione del confine e ci dirigiamo verso il centro del paese per raggiungere il “Castello” e prendere possesso del letto nella stanza che il commissario ci ha assegnato. Guardiamo con curiosità il luogo e coloro che incontriamo e ci accorgiamo che anche noi siamo oggetto di curiosità specialmente da parte di un gruppo di giovani che ci segue fin sulla piazza ove sorge il cosiddetto “castello” che ha tutta l’aria di una costruzione carceraria.
Mentre saliamo le scale per raggiungere il secondo piano della costruzione, uno dei giovani che ci hanno seguito, ci chiede chi siamo e da dove veniamo. A sentire il mio nome uno di loro si presenta: Marcantonio Lecca di Palermo. Poi aggiunge: «Conosco il tuo nome!». Li guardo meravigliato poi gli chiedo come mai mi conosce.
Egli mi racconta che fa parte del “gruppo” di Gafà. Poi si guarda attorno e indicando altri giovani dice: «Siamo tutti del “gruppo” di Gafà». Chiedo dov’ è mai il compagno Gafà. Mi risponde che da qualche giorno, insieme ad altri settanta confinati, è stato arrestato e si trova detenuto al carcere Poggioreale di Napoli. Gli chiedo: «E tu perché sei qui?». Non risponde subito, poi dice: «Andiamo sopra nella tua camerata, ti spiegherò la situazione esistente a Ventotene!».
Nel 1935 ogni confinato riceveva dallo Stato lire cinque al giorno. Queste cinque lire venivano consegnate da un addetto del Commissariato di polizia ad ogni confinato tutte le mattine, al momento dell’appello giornaliero, prima di poter uscire dalla costruzione dove si era stati costretti a passare la notte. L’alloggio era a carico dell’Amministrazione statale.
Per vivere il sussidio di cinque lire era appena sufficiente a patto che si organizzassero mense collettive allo scopo di ridurre pro-capite le spese generali di gestione. E così avevano fatto i confinati.
È ovvio che si creassero mense che riunivano confinati secondo le loro ideologie politiche, pertanto, nel tempo, erano sorte diverse mense: una di anarchici, una mista di repubblicani e “manciuriani” e diverse di comunisti, in quanto questi ultimi costituivano la maggioranza dei confinati. Inoltre, sempre per migliorare le condizioni di vita che erano costretti ad affrontare, i confinati avevano organizzato uno spaccio di generi alimentari, un pollaio, una barbieria, una falegnameria, un laboratorio per la riparazione delle scarpe ed infine una libreria circolante.
Ogni attività era stata autorizzata dalla direzione della colonia a singoli confinati che ne avevano fatto richiesta, anche perché, secondo la “carta di permanenza”, una delle dodici norme obbligava il confinato a “darsi stabile lavoro” e i permessi richiesti non potevano essere negati senza un motivo plausibile. Ma pur non avendo prove, la direzione della colonia sospettava che tutte queste attività fossero in mano ai comunisti, che in linea di massima si dimostravano sempre i più pronti ad organizzarsi e guardava di malocchio le mense dove, secondo il Commissario di pubblica sicurezza, prevalevano i comunisti che comunque raggiungevano sempre i quaranta commensali, mentre le altre mense avevano un numero limitato.
Qualche tempo prima del nostro arrivo a Ventotene, la direzione aveva applicato norme restrittive, portando a venti il numero massimo di commensali per ogni mensa, aveva fatto chiudere lo spaccio per la vendita di generi alimentari, aveva fatto mettere un agente di polizia in permanenza nella libreria circolante. E poiché queste norme restrittive erano state applicate in ogni colonia di confino, balzava agli occhi l’evidenza che non erano disposizioni locali ma emanate dal Ministero dell’Interno.
Contro queste disposizioni governative i confinati di Ponza e Ventotene si erano ribellati e avevano restituito alla polizia le “carte di permanenza”, senza le quali non avrebbero potuto uscire dalle loro abitazioni per andare a mangiare e altro senza contravvenire alle norme a cui era sottoposto ogni confinato e pertanto costretti a rimanere in casa e magari fare lo sciopero della fame. La restituzione della
“Carta” considerata come contravvenzione alle norme ebbe come conseguenza l’arresto di tutti quei confinati che avevano preso questa posizione. Pertanto arrestati alcune centinaia di confinati erano ospiti del carcere napoletano di Poggioreale.
Naturalmente non tutti i confinati avevano aderito alla protesta, perché prendere questa decisione significava peggiorare la propria condizione da confinati a carcerati. È evidente che costoro, vittime del sistema, non vedevano l’ora di tornare alloro paese e pertanto, non tutti, si adattavano ad attendere, quando non si prestavano al provocatorio saluto romano, o ad altre cose del genere. Per costoro era stato coniato l’appellativo di “manciuriano”. Con riferimento alla posizione della Manciuria (Man ciukuò): parte della Cina che si era prostrata agli invasori giapponesi. Partecipare alla protesta significava avere una maturità politica, voleva dire che anche se si correva il rischio di passare dalla condizione di confinato a quella di carcerato, o peggio, da quella di carcerato in camerone finire in cella di punizione a pane ed acqua, non si accettava il concetto che una volta nelle grinfie della dittatura, si potesse tranquillamente astenersi da ogni forma di lotta contro l’aggressore.
D’altra parte per finire al confino bastava che un cretino di fascista o di poliziotto avesse modo di udire una frase come quella detta daun settantenne di Milano, al quale sfuggì: «Oh, povera Italia!». Venne inviato al confino per cinque anni, come l’altro che involontariamente esclamò: «Piove! Governo ladro!». Denunciato gli dettero due anni di confino.
Oltre a questi tipi di confinati vi erano quelli che venuti a contatto con certi circoli antifascisti, non ancora maturi sia per la giovane età che per la preparazione ideologica capitati al confino, prima che decidessero di affrontare con maggior decisione la lotta politica, ebbero bisogno di un certo periodo di tempo e di maturazione.
Caso specifico quelli del Gruppo di Gafà: giunti all’isola di Ventotene un paio di mesi prima di me, nel marzo o aprile 1935, i compagni già preparati come Vito Gafà, l’operaio Enrico Ingallina, i contadini Vito Micielie Luciano Occhiuto, tutti siciliani, parteciparono alla protesta che andavano preparando i compagni mentre altri dello stesso gruppo, gli studenti universitari siciliani: Marcantonio Lecca, U go Sellerio, Antonino Graffeo, PrancoGrasso, ed altri non parteciparono in quanto il loro antifascismo era diverso da quello degli operai, dei contadini e degli altri già preparati politicamente.
Ho già detto che il gruppo di confinati che avvicinarono me, Carelli e Grilli, non appena entrammo nel “castello”, era costituito proprio dagli studenti siciliani del gruppo di Gafà. Quando dissi a Marcantonio Lecca: «Gafà è al carcere e tu perché sei qui?», dalla imbarazzata risposta compresi che in loro nasceva già il sentimento di non aver afferrato la linea giusta da seguire. Non ci vuole molto a indovinare che essendo giovani studenti universitari, a quell’epoca, nella quale tutt’al più i figli di famiglia di ceto medio potevano aspirare al raggiungimento di un diploma, andare all’università significava appartenere a famiglie molto benestanti.
Con Carelli e Grilli decisi di aiutarli e a recuperarsi. A testimoniare quanto allora facemmo per questi giovani compagni, sento il bisogno di fare uno stra1cio da una lettera che il 7 dicembre 1966, cioè trent’anni dopo esserci veduti per l’ultima volta a Ventotene, il compagno avv. Marcantonio Lecca, miha fatto pervenire:
Caro Maderloni,
una mattina all’uscita da un convegno regionale di amministratori, tenuto alla Federazione del ns. Partito a Milano… una faccia sconosciuta ma simpatica e con un aperto sorriso mi ha chiesto: «Tu sei Lecca?». «Sì, e tu chi sei?».
Che emozione quando mi ha detto: «Sono Maderloni!».
L’ho abbracciato come fosse stato mio figlio. In un attimo ti ho rivisto a Ventotene, avanti il Castello, a darmi qualche buon consiglio (ne avevo bisogno anche perché avevo solo 19 anni e dovevano passare ancora alcuni mesi per maturare in me l’adesione al Partito, al confino…)
tuo Marco Lecca
Questa era la situazione che trovammo all’isola di Ventotene Grilli, Carelli ed io quando vi arrivammo i15 maggio 1935.
Il giorno dopo il nostro arrivo a Ventotene venivamo avvicinati dal compagno Aldo Perretti di Reggio Emilia, il quale, dopo averci sottoposto ad un certo interrogatorio e resosi conto che le circostanze gli imponevano di non tener conto delle norme che si dovevano osservare con i confinati nuovi arrivati all’isola, ritenne opportuno darci ulteriori ragguagli circa la situazione. Il compagno Perretti venne spinto da due considerazioni. La prima era che egli aveva il presentimento che la polizia sospettando la sua funzione politica di coordinamento per il prosieguo della lotta, meditasse di trasferirlo ad un’altra isola quindi aveva bisogno urgente, nel caso veramente avvenisse, come poi avvenne, il suo trasferimento, altri compagni potessero portare avanti il suo lavoro. Perretti, inoltre, sapeva già che ero reduce dal Tribunale speciale e che avevo avuto rapporti con il compagno Gafà, quindi ero già membro del partito comunista.
Ci disse che le direttive lasciate dai compagni dirigenti l’organizzazione dei comunisti al confino erano le seguenti:
– continuare l’agitazione per riportare il numero dei partecipanti ad una mensa fino a 40;
– rivendicare la libertà di frequenza alla libreria senza l’odiosa presenza del poliziotto;
– organizzare la spedizione di lettere di protesta rivolte al Ministero dell’Interno, contro le nuove disposizioni;
– organizzare i compagni confinati man mano che arrivavano all’isola, facendo attenzione ai “manciuriani”;
– organizzare il “soccorso rosso” per i compagni detenuti a Poggioreale;
– continuare con i gruppi di studio (economia politica, storia del movimento operaio).
Oltre al Ferretti, i compagni dirigenti avevano fatto astenere dal partecipare all’agitazione per continuare a curare gli interessi dell’organizzazione i compagni Pilati Armando di Bologna e il compagno Augusto Prioglio di Sevigliano (Cuneo). Pilati curava un laboratorio di falegnameria, mentre Prioglio curava un orto con un pollaio che non potevano essere abbandonati. Il compagno Ferretti gestiva a titolo personale ma, per conto dell’organizzazione, una barbieria.
Di fronte a questa situazione con Carelli e Grilli decidemmo, tanto per cominciare, a non aderire a mense già organizzate. Ci arrangiammo a mangiare in camerone e qualche volta nell’unica osteria esistente a
Ventotene, da “Donna Fortuna” sita sull’unica piazzetta del paese.
Non passò tanto tempo che le previsioni del compagno Ferretti si avverarono.
Venne trasferito ad altra isola, con la conseguenza per me che venni scelto tra i compagni per prendere il suo posto di barbiere.
Il problema della sostituzione di Ferretti venne discusso tra i compagni e per il fatto che all’età di dieci anni e per soli 15 giorni avevo fatto il ragazzo di barbieria con il compito di spazzolare i clienti, dovetti adattarmi a raschiare il viso dei clienti. Mentre mi riuscì bene o male a fare la barba, in poco temposi videro numerosi confinati con la testa rapata, perché tentata la “sfumatura” finivo con il dover passare il sapone poi il rasoio. Fortuna che si era già quasi in estate: giugno.
Intanto arriva a Ventotene anche Alvaro Sighieri di Livorno che essendo un compagno di professione barbiere, gli cedo subito il posto con’ un gran sollievo mio e… degli altri.
Giungono ancora altri compagni: Cugini Loreto di Frosinone, Bazzino Francesco di Savona, Saliddu Giuseppe di Iglesias, Pirani Quinto di Ostra (AN) e tutti, insieme agli studenti già menzionati e altri operai sardi, si ingaggia una serrata lotta contro la direzione della colonia, boicottando le mense, così come sono volute dalla polizia, organizzando pasti da “Donna Fortuna” e provvedendo a cuocere nei cameroni a camerette, tempestando di lettere raccomandate con ricevuta di ritorno dirette al Ministero dell’Interno suscitando un continuo stato di tensione che infastidiva la direzione della colonia. In breve si creò una situazione talmente caotica che fece determinare la modifica delle disposizioni ministeriali, tanto che venimmo autorizzati a portare a 40 il numero dei partecipanti ad una mensa, a non vede-re più nella biblioteca la faccia del poliziotto.
Si riuscì anche a far pervenire denaro del “soccorso rosso” ai compagni detenuti a Napoli i quali, circa 70, torneranno a Ventotene quasi tutti dopo circa otto mesi di detenzione. Di questi ricordo: Antonio Oberti di Torino, Calogero Barcellona di Siracusa ma residente a Milano, Ciro “Picardi di Pon (NA), Cappelletti di Como, il calabrese Bongiorno, il ‘sardo Attilio Lecca, Maestri di Alessandria, Carlo Alberto Poggiali di Imola, Rutilio Reali di Castelfiorentino (Empoli), il quale ci confermò che anche lui, come Premoli, inviato dal partito ad Ancona con materiale di propaganda antifascista, non aveva potuto prendere contatto con l’organizzazione a causa della posizione negativa presa dal barbiere Luigi Mercanti.
Fra i compagni dirigenti ricordo gli emiliani Filippo Landi e Gennari.
Dopo la Liberazione, mentre ero a Roma, per lavoro sindacale mi sono incontrato con l’ing. Ugo Sellerio, segretario del compagno Palermo sottosegretario alla Postbellica, con il prof. Antonino Graffeo segretario del compagno Moranino, sottosegretario alla Difesa, e Franco Grasso alla redazione del giornale del partito a Palermo. Tutti studenti del gruppo Gafà in linea col partito.
Tornati i compagni dal carcere, fatta la nostra relazione, passammo le nostre responsabilità a chi di dovere e Carelli, Grilli ed io, con i compagni Storini e Giavazzi, potemmo dedicare maggior tempo allo studio, cosa che fino a quel momento avevamo potuto fare limitatamente, alle prese come eravamo con i problemi cui ho accennato e che qualche volta ci avevano messo in condizioni di credere che probabilmente la polizia, resasi conto delle nostre attività, avrebbe provveduto a trasferirci o, peggio, mandarci a raggiungere i compagni al carcere napoletano.
I miracoli dell’amore materno
Arrestato il 27 febbraio 1935, nel dicembre dello stesso anno ero assente da casa mia da ormai dieci mesi. Avevo visto fallire il tentativo di ottenere per mia moglie e il mio bambino l’autorizzazione a raggiungermi all’isola. In altri tempi l’autorizzazione era stata concessa, poi la partecipazione a proteste, aveva creato condizioni difficili per queste mogli che rimanevano all’isola mentre i mariti partivano per il carcere.
Nella prima decade, appunto, mi vidi consegnare, dal poliziotto addetto alla censura della corrispondenza dei confinati, una busta a me indirizzata, contenente una cartolina postale su cui una tremula mano aveva vergato le seguenti parole: «Caro figlio, in occasione del mio sessantesimo compleanno ti mando questa cartolina scritta con le mie mani. Ti bacio. Mamma».
Il fatto mi parve straordinario. Mi sentii fortemente commosso. Compresi che malgrado le tante preoccupazioni, in nove mesi, mia madre, c’era riuscita, a sessanta anni di età, a imparare a leggere e scrivere ed aveva pensato di darmi la lieta novella compilando con caratteri elementari, per me, la sua prima lettera.
Ero stato assente da casa negli anni 1926 e 1927 per il servizio militare e tutto l’anno 1932, perché detenuto nel carcere romano e durante questi periodi le lettere che avevo scambiato con mia madre, per conto suo, erano state scritte e lette da una terza persona essendo mia madre analfabeta. Purtroppo alla fine del 1800, tale condizione era diffusissima specialmente nei piccoli paesi e mia madre era nata a Loreto Marche da povera famiglia di lavoratori.
L’arrivo della lettera di mia madre mi procurò un enorme piacere e mi fece ricordare che dopo il mio ritorno dal carcere nel 1932, in un momento di abbandono, come con una madre ci si può permettere, le avevo fatto notare come il doversi servire di intermediari durante le assenze da casa, e in certe circostanze, significava avere, tra noi due, un diaframma, che ci impediva di sentire il calore umano che una lettera emana quando essa viene scritta e letta tra due persone che si amano.
Naturalmente nel fare questo rilievo, non vi era né poteva esserci alcun rimprovero, caso mai, un altro atto di accusa contro la società responsabile di questo stato di cose. Allora non pensai affatto agli effetti che avrebbero potuto avere le mia parole, ma mia madre comprese benissimo che in certe circostanze, può darsi, che si abbia una certa riluttanza scrivere a cuore aperto quando si sa che solo attraverso una terza persona quelle parole scritte sarebbero arrivate all’orecchio e quindi al cuore della madre. Certamente allorché ella decise di mettersi all’ opera, non facile data l’età, pensava solo al figlio e non certo che imparando a leggere e scrivere anche per lei sarebbe stato come scoprire un mondo nuovo.
Al mio ritorno ad Ancona nel gennaio 1937, non pensai minimamente alla commozione che mi aveva assalito nel dicembre 1935; le condizioni generali sfavorevolissime erano poco adatte ai sentimentalismi; nonostante ciò mi accorsi che mia madre non aveva imparato a leggere e scrivere soltanto per me.
Pur essendo lei e mia moglie alle prese con la battaglia per procacciarsi un modesto pezzo di pane quotidiano (tutte e due avevano imparato il confezionamento di coperte imbottite e lavoravano per un negozio ed eventualmente per privati), mia madre si era impadronita del libro La Madre di Massimo Gorkij e non appena possibile leggeva e rileggeva le vicende della Blasovae del figlio. Ripassava pagine di questo libro nel quale di certo trovava fatti che le ricordavano alcuni aspetti della sua stessa vita. Avere imparato a leggere, le aveva allargato l’orizzonte e oltre a
La Madre seguiva la cronaca del giornale cittadino, leggeva le insegne dei negozi, che prima per lei non avevano senso e soprattutto le permetteva di capire, ora, meglio quello che ci accadeva intorno. Il passaggio nella nostra abitazione di operai, arti-giani, studenti, ecc., sentire certi discorsi, l’uso di parole mai intese, problemi gros-si, avevano creato in lei una certa sicurezza, che poco prima di morire – nel novembre 1942 -le consentì di vaticinare: “vincerete”.
Come già detto, passai i primi otto mesi di confinoutilizzando il tempo, alternativamente, tra i problemi organizzativi e rivendicativi accennati e studiando, della qualcosa avevo grandemente bisogno. Mi consideravo fortunato a trovarmi vicino a due compagni come Grilli e Carelli, con i quali andavo molto d’accordo, il che del resto avveniva anche con Storini e Giavazzi. Nella camerata a cinque posti che occupavamo al castello, dedicavamo il nostro tempo allo studio individuale, secondo la personale necessità, e allo studio collettivo.
Ho già detto che studiavamo economia politica sul volume del Lapidus e Ostrovitianov, ora aggiungo che ci inoltrammo anche sul terreno filosofico avendo come testo, scritto in francese, che veniva regolarmente tradotto dai compagni, il libro MaterialismeHistorique di N. Bukarin. Inoltre studiavamo la storia del movimento operaio su un testo scritto a mano dai compagni. Materiale questo tenuto nascosto a prezzo di enormi sacrifici.
Man mano che mi inoltravo nello studio delle spontanee, ferree leggi economiche che regolano la società, mi accorgevo che sino ad allora ero stato un sentimentale, che avevo ragionato più con il cuore che con la mente, ma che avevo imboccato la strada giusta, anche se penosa, ma entusiasmante. Si studiava con compagni di guardia per non essere sorpresi dalla polizia che ogni tanto rovistava tra le nostre cose.
Si intende che oltre allo studio l’attenzione nostra e quella dei compagni era rivolta agli avvenimenti in Abissinia, in Germania e soprattutto in Spagna dove a fine luglio 1936 iniziò la guerra civile.
Naturalmente speravamo in una sconfitta delle forze di Franco e quindi l’i percussioni favorevoli per il riacquisto della nostra libertà in Italia.
Ero ospite di Ventotene da circa undici mesi quando, alla direzione, della coloni-a, venne l’invito a concedermi cinque giorni di licenza per recarmi nella mia città, avendo mio figlio Roberto, nato nel settembre 1934,gravemente ammalato. Partii da Ventotene accompagnato da un paio di poliziotti della Questura di Napoli e con-segnato a quella di Ancona.
Con un certificato medico atte stante che mio figlio non aveva ancora sperato il momento critico, ottenni una proroga dialtri cinque giorni, poi dovetti tornare all’isola. Fu in quella occasione che mi riuscì di portare con me una copia di “Le merle” settimanale bilingue (italo-francese) con l’appello del partito comunista d’Italia: «Salviamo l’Italia dalla catastrofe!».
Durante l’anno 1936 riesce ai miei di ottenere, per causa di malattia di mia moglie e mia madre, altre due brevi licenze sfortunatamente durante l’ultima mi trovo presente quando un agente di custodia del carcere di Ancona picchia il compagno Adelmo Pianelli. Non posso fare a meno di intervenire, diciamo un po’ bruscamente, per togliere il compagno dalle mani del secondino. Lo scontro si conclude con una denuncia alla Pretura di Ancona che per direttissima mi condanna a otto mesi di reclusione e poiché considera il reato comune e non politico e poiché sono incensurato, mi concede la “condizionale”.
Torno a Ventotene accompagnato da un maresciallo di P.S. che nello scompartimento ferroviario vuol fare lo zelante e dà inizio ad una conversazione animata sugli avvenimenti spagnoli, naturalmente quello che dico in merito non gli va a genio, specialmente per la presenza di altri quattro viaggiatoriche sono allievi ufficiali che si recano alla scuola militare di Caserta, che finiscono col capire il rapporto che esisteva trame e il poliziotto. Minaccia di fare una denuncia per propaganda antifascista ma poi credo che sia finita così; ci ha pensato meglio.
Per inciso dirò che anche i compagni Carelli e Grilli ottennero un paio di licenze entrambi: il primo per malattia della moglie e dei figli; il secondo per ragioni personali indifferibili. Le licenze venivano concesse anche agli studenti universitari per recarsi all’Università di Bari per gli esami.
Il fatto che venissero concesse ai familiari, per i propri congiunti confinati, brevi licenze, non deve far supporre che il regime fosse tenero con i propri avversari. Il provvedimento di polizia per l’invio a domicilio coatto di un elemento ritenuto politicamente avverso al regime, era preso da una commissione capeggiata dal Prefetto, non per reati commessi, perché in tal caso sarebbe stata competenza del Tribunale Speciale, il provvedimento era determinato da sospetti di attività politica antifascista o per capacità a dare tale attività. In sostanza l’avvio al domicilio coatto costituiva una prepotenza del regime, molto evidente.
Per le tre licenze da me fruite nei due anni di permanenza a Ventotene (anni 1935/37) nel dicembre 1944 si volle ravvisare un qualcosa di poco chiaro ed è perciò che rinvio alle testimonianze riportate nel libro Gli antifascisti al confino di C. Ghini e A. Dal Pont.
Verso la fine dell’anno 1936 per due volte dovetti essere ricoverato all’ospedale “Incurabili” di Napoli per dolori artritici e allo stomaco. Per queste condizioni fisiche, lo studio, gli avvenimenti internazionali, l’atmosfera del confino, i compagni, la speranza che accompagna sempre il combattente, mi indussero a fare quello che del resto era nelle direttive della organizzazione, cioè presentare al Ministero una domanda per la commutazione della restante pena in ammonizione a causa delle cattive condizioni economiche della mia famiglia (madre anziana, moglie ammalata, e un figlio di due anni).
La mia domanda, sottoposta all’approvazione dei compagni dirigenti tramite il compagno Rutilio Reali di Castelfiorentino (Empoli), elemento di contatto tra la base e la direzione del collettivo di partito, venne accolta dopo il “nulla osta” da parte della Questura di e pertanto nel gennaio 1937, tornai a casa con tre anni di ammonizione da scontare.
Per finirla con l’isola di Ventotene, aggiungerò che, visto l’esito favorevole della mia domanda, a presentarla tentarono anche i compagni Gino Grilli e Augusto Dino Carelli, che infatti, alle stesse mie condizioni, vennero rimandati a casa nei primi mesi del 1937.
Il compagno Grilli entrerà ancora nei miei ricordi, perché risiederà in Ancona, mentre il compagno Carelli ha dovuto trasferirsi a Numana in provincia di Ancona dove risiede la sua famiglia composta dalla moglie, insegnante di scuola elementare, due piccoli figli, e due anziane parenti. Carelli, dopo un periodo di dura disoccupazione, ottiene un’occupazione in una fabbrica di fisarmoniche, dove riuscirà a svolgere attività organizzativa per il partito fino al punto che otterrà dallo stesso titolare della fabbrica un certo finanziamento per la nostra organizzazione.
Nell’inverno 1944, durante l’occupazione nazista, venne inviato a reggere la federazione del nostro partito nella provincia di Macerata, rimanendo a questo posto di responsabilità per un anno ancora dopo la Liberazione. In questa sua attività, il compagno Carelli è stato efficacemente coadiuvato dalla moglie: la compagna Anna Mondaini.
L’anno 1937 fu tremendo per una serie di ragioni.
Nel maggio avevo dovuto ricoverarmi all’ospedale civile di Ancona dove mi avevano diagnosticato: ulcera deuodenale con proposta di intervento chirurgico.
I primi sei mesi dell’anno li avevo passati sotto il peso delle norme che regolavano la vita degli “ammoniti”, che limitavano la possibilità di muoversi se non entro certe ore della giornata, non bisognava farsi trovare dalla polizia fuori di casa prima dell’alba e dopo “l’Ave Maria”. Non si poteva frequentare locali pubblici, non si dovevano avere rapporti con elementi sospetti, non si poteva uscire dal territorio del proprio comune, ecc. Cercai disperatamente una qualsiasi occupazione, ma inutilmente e quindi mi adattai con un rivenditore di mobili usati in attesa di meglio.
Irretito dai tre anni di “ammonizione” che limitavano e condizionavano la mia libertà, dopo aver fatto la mia “prova d’arte” come fucinatore meccanico, dovetti rinunciare all’assunzione presso la ditta Guerri di
Jesi perché la Questura non aderì alla mia richiesta di trasferimento in questa cittadina a 30 km. da Ancona.
Nel 1937 la guerra civile divampa in Spagna. L’intervento del governo fascista a favore di Franco è sempre più evidente. Mentre la stampa del regime si trastulla sugli incontri dei capi delle Grandi Potenze in un cosiddetto “Comitato del non intervento nelle cose spagnole”, il popolo italiano sa invece che si stanno preparando battaglioni di soldati volontari e… no.
Il fascismo fa affidamento sulla grande miseria in cui ha affogato la classe operaia. La fallimentare situazione economica è denunciata dal continuo aumento dei casi di autolesionismo, ciò risulta dai processi che per questo reato si vanno celebrando in Ancona, Roma ed altre città della penisola. Il fenomeno è così grave che il Governo è obbligato ad apportare una riforma alle norme che regolano la liquidazione economica degli infortuni sul lavoro, mentre si provvede ad inserire tra le fasciature degli arti colpiti dei vetrini, all’insaputa dell’infortunato, per scoprire se costui è un autolesionista e si mandano in giro provocatori per carpirne l’eventuale segreto, e una dichiarazione in buona fede che dovrebbe far perdere il diritto al sussidio dell’Istituto assicuratore e la conseguente denuncia alla magistratura.
Ancora una volta a S. Palazia
Invece per chi vuole andare volontario in Spagna, per chi desidera farsi “legionario” per la guerra di Franco (che viene presentata come una romantica “passeggiata” per la terra iberica), premi all’ingaggio, premi a ferma, guadagni nel saccheggio, possibilità di occupazione nella Spagna o un posto di lavoro assicurato al ritorno in Italia. L’entusiasmo tra i “militi” non è molto. Il “console” Galamini raduna un battaglione di “camicie nere” della 108a legione, arringa e poi invita chi vuol partire a fare un passo avanti. Dice la cronaca che due furono gli eroi, uno di questi però sa che non può essere fatto abile perché ha una voluminosa ernia addominale.
Il console” non ha maggiore fortuna con altri battaglioni malgrado minacce e lusinghe. Non rimane che la partenza forzata e l’ingaggio ai disoccupati. Il risultato non sarà incoraggiante, allora si ricorrerà alla truffa del cambio di destinazione, cioè s’imbarcheranno i lavoratori per uno dei porti dell’impero etiopico da poco conquistato, invece saranno sbarcati in pori i spagnoli in mano ai “franchisti” e costretti a combattere contro la democrazia spagnola,
Intanto nel marzo 1937, in gran consiglio del fascismo decide la militarizzazione di tutti i cittadini in età dai 18 ai 55 anni. Verso la fine di marzo circolano voci relative ad una grossa sconfitta inflitta dalle “brigate internazionali” alla divisione di “camicie nere” sul fronte di Guadalajara.
Nell’agosto 1937 un gruppo di compagni prende l’iniziativa di stampare alla macchia un certo numero di volantini che poi diffondono in città. La polizia, come al solito, dà la caccia agli antifascisti conosciuti e riempie il carcere giudiziario e cerca tra gli arrestati i colpevoli. Ma due giorni dopo, una nuova ondata di manife-stini vengono diffusi sulla città e ciò manda in bestia l’OVRA e il questore, dato che numerosi esemplari di questi manifestini vengono gettati persino dentro i locali della questura.
Dopo qualche giorno passato in cella, insieme ad altri vengo rilasciato e torno a casa. La polizia arresta poi rilascia i compagni Rodolfo Di Chiara e Volturno Pugnaloni; tenta di fermare il compagno Alfredo Spadellini, che invece aiutato da antifascisti di Ancona, Milano, Como, espatria in Francia, poi in Spagna, combatte, rimane ferito, più tardi verrà consegnato alla polizia italiana, il T.S. lo condannerà, poi lo confinerà a Ventotene da dove uscirà soltanto il 20 agosto 1943.
Una testimonianza scritta del compagno Alfredo Spadellini, che può essere letta a pagina 341 e seguenti del libro I compagni – La storia del Partito Comunista nelle “storie” dei suoi militanti (Editori Riuniti), arricchisce di altri particolari l’episodio del lancio di volantini antifascisti nell’ottobre 1937.
Ho conosciuto il compagno Spadellini nell’aprile ’37, durante un incontro con un gruppo di giovani anarchici. A propormi l’incontro era stato l’anarchico Pugnaloni, che desiderava vedermi alle prese con suoi compagni che, secondo lui, erano in grado, in uno scontro ideologico, di avere la meglio.
All’appuntamento, lungo la strada che conduce alla frazione di Pietralacroce vennero in quattro: Volturno Pugnaloni, Ernesto Suardi, Vero Candelaresi (che avevo già conosciuto nel 1929) e Alfredo Spadelliniche precisò subito di essere comunista, Concludo dicendo che dopo una serie di incontri con questi operai, tutti e tre aderirono alle nostre idee.
Spadellini scrive: «Ci preparammo a stampigliare falce e martello sui manifesti fascisti per la “marcia su Roma”, ma la sera del 27ottobbre scoprimmo che c’era tanta polizia,.., rimandammo l’azione per il 7 novembre… e decidemmo che quella sera, chi poteva, non dormisse a casa. Io non ci dormii. Quel mattino la polizia fece irruzione nel magazzino di via Podesti dove tenevo attrezzi per il mio lavoro di verniciatore e tanto frugò che in una crepa del muro trovò una di quelle falce e martello, non trovò altro ma bastava. E da quel momento si misero in caccia per prendermi».
«Ci si misero d’impegno alcuni fascisti ed un vigile urbano… allettato dalle diecimila lire di taglia offerte dalle autorità; i compagni del mio gruppo… erano preoccupati… preoccupatissimo ero poi io perché mai avevo avuto a che fare con la polizia… se fossi caduto in quelle grinfie sarei riuscito a resistere?».
Il compagno Spadellini continua narrando le vicende della fuga e ricorda come giunto a Corno, per superare la diffidenza di chi doveva aiutarlo ad espatriare clandestinamente, gli venne chiesto se era di Ancona e se in tal caso conosceva Raffaele Maderloni. Chi lo interrogava era il compagno LuigiCappelletti detto “Eugenio” che mi aveva conosciuto a Ventotene. Questa ultima parte dimostra in che considerazione erano tenuti i compagni Grilli, Carelli e Maderloni a Ventotene.
Per chiudere rilevo che nessuno dei partecipanti all’azione venne fermato dalla polizia e che molto probabilmente neppure Spadellini sarebbe stato incriminato se egli non avesse commesso l’imprudenza di nascondere nel suo laboratorio lo stampo di gomma e nessuno lo avrebbe cercato malgrado le diecimila lire di taglia.
L’esito vittorioso della battaglia di Guadalajara aveva acceso di entusiasmo l’animo di numerosi antifascisti che si attendevano dalla sconfitta del fascismo in Spagna, la possibilità di riprendere la lotta contro il regime in Italia. Poi le notizie sempre più negative che seguirono lasciarono poche speranze sulla sorte della repubblica spagnola, soprattutto per il reale comportamento dei paesi fascisti e quelli sedicenti democratici.
All’interno il regime cerca di ridurre la tensione economica aumentando i salari dal l0O al 12% e dell’8% lo stipendio degli statalie migliorando gli assegni familiari. Sul piano internazionale si nota sempre più unarecrudescenza nei rapporti tra i gruppi capitalisti, che fa ritenere non molto lontana la possibilità di un urto tra loro o la loro unione contro l’Unione Sovietica.
Dal ritorno dal confino, i rapporti con i compagni sono stati forzatamente limitati a qualche conversazione direi amichevole e di sondaggio, sperando che l’organizzazione (rimasta intatta malgrado l’arresto dei dirigenti nel 1935) si sia ridata una dirigenza. Sfortunatamente nessun compagno ha potuto o saputo prendere l’iniziativa per riallacciare i contatti tra le diverse cellule.
In questa situazione io e Grilli riteniamo di abbandonare la nostra posizione di riserbo, consigliataci dai compagni {di Ventotene, in considerazione che non siamo più sottoposti alla “ammonizione” che è stata amnistiata il 15 marzo 1937 perla nascita del principe Vittorio Emanuele di Savoia, e decidiamo di riprendere, sia pure con cautela, la nostra attività politica. Si costituisce così un comitato direttivo composto da Gino Grilli, Vittorio Marinelli e da me. Siamo agli inizi del 1938.
Di nuovo in attività
Dalla marcia su Roma sono trascorsi ormai 16 anni, in questo periodo il regime ha cercato di eliminare, con la violenza tutto ciò che poteva indicare agli uomini, e in particolare ai giovani, la via della libertà, della dignità e ha cercato di imbonire i crani degli italiani con tutti i mezzi per ridurli a macchine, ma non ha tenuto conto di quanto si può imparare dalla realtà di ogni giorno e quello che può l’amore per la libertà e la giustizia. In particolare i giovani comunisti hanno superato diversi stadi nel loro graduale sviluppo, hanno fiducia in se stessi e credono nelle teorie che hanno studiato e che li hanno convinti sulla inevitabilità della decadenza del capitalismo.
In questo periodo si inizia un paziente, tenace lavoro di infiltrazione tra giovani operai, studenti, artigiani. Si farà sentire la nostra solidarietà agli ebrei che in quel momento sono sottoposti ad angherie da parte del fascismo che sta scimmiottando il nazismo razzista tedesco. Bisogna intensificare la penetrazione sorda nei diversi organismi sociali per minarne le basi che d’altra parte si sono infradiciate dalla delusione, dalla stanchezza, dalla miseria, dalle guerre che il fascismo ha condotto e soprattutto di quella verso la quale sembra ora essere diretta.
Ovunque deve essere possibile trovare alleati, ovunque si deve tarlare il traballante regime, anche se finora sembra vincente, farlo cadere prima che esso conduca l’Italia alla catastrofe di una guerra che le sarà fatale ma che potrebbe trascinare con sé nella voragine tutto il popolo italiano. Si vanno riprendendo i contatti con le cellule sui posti di lavoro e di strada, l’organizzazione si allarga dalla città alla provincia c alla regione marchigiana, mentre si è sempre animati dalla speranza di collegarci con il partito sia per verificare la giustezza del nostro orientamento sia perché avremmo potuto ottenere materiale di propaganda più idoneo.
I gruppi di studio
I compagni del direttivo decidono di affrontare il problema del lavoro ideologico e della diffusione delle idee con la stampa e con i gruppi di studio per compagni giovani e anziani, allo scopo di dare una chiara visione degli avvenimenti e una reale interpretazione dei fatti che stanno accadendo. Si decide di utilizzare il materiale, portato da Ventotene da me. Cioè il Precis d’économiepolitique, di cui ho già detto, che viene tradotto dal francese e ciclostilato in 100 copie (escludendo la parte che interessa le leggi economiche nell ‘URSS). Si passa alla preparazione di ampi stralci del volume Il materialismo storico di Nicola Bukarin e di una Storia del movimento operaio, riassunti in uno studio fatto collettivamente a Ventotene e da me portati in Ancona.
L’organizzazione si arricchisce di altro materiale utile allo studio e alla propaganda. Sul mercato librario troviamo alcune copie de Il materialismo storico di A. Labriola; La Carta dei diritti che contiene oltreche le diverse costituzioni inglese, francese, americana, sovietica, anche il Manifesto dei comunisti di Marx ed Engels. Ci serviamo pure de La storia della grande industria in Italia di Morandi ed il Carlo Marx del prof. Olgiati che servirà per il contraddittorio.
Naturalmente diffondiamo romanzi come La condizione umana diA. Malraux, Furore ec /JattaRlia di J. Steinbeck e il libro Sine Ira, uno studio sulla realtà sovietica scritto da una russa che sposata ad un diplomatico di un paese capitalista, torna dopo dieci anni nella terra dalla quale i genitori l’avevano portata via durante la rivoluzione d’ottobre e che dice il suo parere sul sistema economico e sociale che i comunisti stanno organizzando nell’ Unione Sovietica. Diventa un libro entusiasmante che passa per centinaia di giovani comunisti anconetani galvanizzandoli. Altro libro usato La storia de1 comunismo di Perticone.
L’organizzazione disponeva anche di alcune copie de Il tallone di ferro di J. London, de La Madre c de Laa; Spia di M. Gorkij e degli altri libri già ‘ indicati, oltre che i libri La Guerra segreta per il petrolio e quella per il cotone.
È ovvio che oltre alla stampa indicata l’organizzazione si avvaleva delle opere cinematografiche che potevano servire alla bisogna e grande effetto ebbe appunto nel 1938/39 la proiezione al Cinema teatro Goldoni di Ancona del film Tempi moderni di Chaplin.
Così pensavamo
Lo studio di questo materiale e degli avvenimenti avvenuti negli ultimi decenni e, in particolare, la storia del movimento operaio, ci hanno convinto che in quella situazione, bisogna cercare di capire la realtà sociale attraverso gli insegnamenti che derivano dalle fondamentali contraddizioni proprie di una società basata sulla proprietà dei mezzi di produzione.
Si è convinti che conseguentemente allo sviluppo delle forze produttive, il capitalismo vive a patto che possa sempre più allargare la sua sfera d’influenza, che lo scontro tra gruppi capitalisti per una nuova divisione di queste, per il possesso di mercati, ecc. E che alla luce di queste interpretazioni appare come inevitabile e vicina una seconda guerra mondiale. Quello che sta accadendo in Europa e in Asiane sono i primi segni premonitori.
In Europa, la Germania nazista chiede a gran voce la restituzione delle colonie perdute a seguito della prima guerra mondiale, dopo aver nel 1935 abbandonato la Società delle Nazioni, ripristinando il servizio militare obbligatorio nel 1936 e nel 1938 occupato l’Austria, e le sue truppe entrano in Cecoslovacchia e occuparono la regione dei Sudeti.
In Asia l’impero del Sol Levante fa da padrona in Manciuria e in Cina. Già nel 1937 è stato siglato tra Berlino-Roma-Tokio un patto anticomunista. I dirigenti di questi tre Stati si sbracciano a fare discorsi che hanno tutta l’aria di voler rassicurare i dirigenti degli altri Paesi capitalisti come se il nemico numero uno fosse soltanto l’URSS, mentre in realtà stanno togliendo o minacciando di togliere fette di potere ai cosiddetti gruppi democratici quali però certamente sperano che i tre territoriale ai cosiddetti gruppi democratici i quali però certamente sperano che i tre Paesi fascisti tentino di risolvere i loro contingenti problemi con la guerra contro l’ Unione Sovietica. Di fatto esiste il pericolo che i diversi Paesi imperialisti riescano a creare un blocco di forze da scagliare contro l’Unione Sovietica, questo prima di azzuffarsi tra loro.
Avevamo allora una grande fiducia nella forza dell’armata Rossa e sentivamo che i nostri interessi di lavoratori coincidevano strettamente con quelli dei lavora-tori del Primo Stato Socialista e pertanto, in casodi aggressione imperialista all’Unione Sovietica, dovevamo essere in grado di agire secondo i nostri interessi proletari. Naturalmente vedevamo come anche il problema della guerra era for-temente collegato all’inevitabile crollo del fascismo e con esso il crollo anche del capitalismo italiano responsabile del fascismo. Con questa visuale, con questi in-tenti l’organizzazione cercava di dare ai compagni, ai simpatizzanti e alla propaganda un’impostazione più generale dei problemi; mettendo in luce la natura di classe del fascismo, le sue malefatte, incitando i lavoratori alla resistenza, all’unità.
La stampa clandestina
L’organizzazione clandestina può mantenere legami con i propri aderenti, orientarli, quindi allargare la propria influenza soltanto se, sia pure saltuariamente, può far pervenire alla base materiale scritto, stampato. La stampa dell’organizzazione impone fiducia, chiarisce le idee, i dubbi e permette alle idee di oltrepassare i limiti che a viva voce non potrebbero neanche essere raggiunti. La stampa è sempre un veicolo di propaganda e di pungolo ad operare.
Attraverso il tempo, interrotti i rapporti col “centro”, per la perdita del contatto l’organizzazione dovette soddisfare l’esigenza sia pure con mezzi più rudimentali. Fogli manoscritti, in stampatello, ciclostilati, stampati, circolarono sempre durante il periodo della dittatura fascista, così come spesso apparivano frasi o simboli antifascisti dipinti sui muri della città e “cenci rossi” lasciati a penzoloni qua e là. Tutto serviva a ridicolizzare i gerarchi, il regime, perfino gustosissime barzellette.
La stampa aveva l’obiettivo di mantenere acceso lo spirito antifascista, orientare i compagni su determinate parole d’ordine o avvenimenti di maggior rilievo come consigliare di non andare a lavorare in Germania per conto del nazismo o la lotta contro l’opportunismo, o dimostrare menzognera la propaganda fascista che presentava la guerra come una lotta tra nazioni ricche e nazioni proletarie, guerra del sangue contro l’oro, ecc. La circolazione della stampa aveva però anche i suoi lati negativi, cioè oltre che mettere sull’avviso l’avversario della presenza in città di un’organizzazione antifascista, poteva metterlo sulla traccia dell’organizzazione e colpire i compagni.
Se nel periodo di legalità democratica la loquacità può non costituire un gran difetto, nel periodo della dittatura è senz’altro pericolosa. Quando una fitta rete di orecchi è stata messa in ascolto più che saper parlare necessita saper tacere, la cospirazione obbliga a saper frenare il proprio ardore, controllare i propri gesti, mantenere un segreto, non confidare al alcuno le proprie speranze se non autorizzato dall’organizzazione perché ogni passo falso poteva condurre ad arresti, persecuzioni, condanne.
La stampa veniva diffusa tramite l’apparato organizzativo. Ogni gruppo aveva una sua zona d’influenza, era composto di membri del partito ognuno dei quali doveva, nel limite del possibile, “polarizzare” attorno a sé uncerto numero di simpatizzanti. Non più lanci clamorosi di manifestini dunque, ma responsabile diramazione. Dal “buco” centrale il materiale passava ai “buchi” di smistamento che generalmente erano botteghe di artigiani (barbieri, calzolai, ecc,) da dove veniva prelevata dai responsabili di zona, elementi sempre scelti tra i migliori compagni.
Ogni responsabile doveva circondarsi e servirsi di “compartimenti stagni”, cioè di compagni capaci di tener duro se presi dalla polizia. Ogni incidente doveva essere comunicato ai responsabili nel più breve tempo possibile per mettere in grado l’organizzazione di provvedere a spezzare un eventuale “arresto a catena”, eventualità da evitare ad ogni costo.
L’organizzazione clandestina
Nel 1939 l’organizzazione si dirama particolarmente tra la classe operaia. Il nucleo organizzato più numeroso, più forte, naturalmente, è quello organizzatosi entro il Cantiere Navale di Ancona dove lavorano oltre 1.500 operai.
La cellula, che nel tempo raggiungerà oltre 150 iscritti, è diretta da cinque membri: Remo Ricci, Leonida Remaggi, Emilio Medici, Idilio Marazzotti, Dino Squartini.
Viene poi la cellula dei ferrotranvieri con un unico comitato così composto: Eugenio Monti, capo stazione FF.SS; Mario Piermattei, impiegato Azienda Tranviaria; Gino Ausili, controllore Azienda tranviaria.
La cellula raggiunge tra tranvieri e ferrovieri circa 20 iscritti.
Cellula portuali – elementi di contatto: l0 aderenti, i cui responsabili sono: Atlantico Galeazzi, Giuseppe Lucconi, Amedeo Bevilacqua.
Cellula bancari: 7 aderenti, i cui responsabili sono: Ruggero Giannini, Adone Pierfederici, Mario Marsigliani, Nicola Cerusico.
Gruppo rione Pinocchio: Leonello Lesti, Mario Roccheggiani.
Gruppo rione S. Pietro: Romolo Baldassarri.
Gruppo Passo Varano: Ercole Carletti.
Gruppo Montirozzo: Fernando Mancinelli.
Gruppo Centro: Libero Regni.
Gruppo Guasco: Cesare Canafoglia.
Gruppo Borghetto: Rolando Cinti.
Gruppo Molo Sud: Mario Medici.
Gruppo Ospedale Civile: Cesare Filippetti, Cesare Beccaria, prof. Franco Patrignani.
Gruppo Scuole: avv. Prof. Ermenegildo Catalini, prof. Angelo Sergoni.
Gruppo Tavernelle: Antonio Talevi.
Gruppo Palombella: Alberto Galeazzi.
Gruppo Fabbrica Angelini: A. Frattini.
Gruppo Corso Tripoli: Rodolfo Di Chiara.
Gruppo Calzaturifici: Bisognini, Zoli.
Era nostra convinzione che la classe operaia si differenziasse in tutto dalle altre classi o ceti sociali che componevano allora la società. Pertanto curavamo in particolare gli operai.
Può anche darsi, dicevamo, che nel corso delle vicende politiche, in un dato periodo, gruppi della piccola borghesia, rurale e urbana, facciano un’azione che coincida con quella svolta dalla parte più cosciente della classe operaia, ma mentre l’azione dei primi si esprime con instabilità ed in termini idealistici, sentimentali, l’azione della classe operaia è continua, persistente e si esprime in termini la cui valutazione viene fornita dalla stessa reazione dell’avversario di classe che colpisce tanto brutalmente l’operaio che si ribella quanto meno duramente gli altri gruppi politici avversari. Mentre per i giovani della piccola borghesia e degli intellettuali era un continuo ripensamento e il riproporsi di scrupoli sulla loro posizione nei riguardi del fascismo, a seconda degli alti e bassi della politica del regime, per i giovani della classe operaia non esisteva altra alternativa che andare fino in fondo nella lotta per la loro totale emancipazione.
Malgrado questo nostro modo di pensare, piuttosto settario, numerosi erano gli artigiani che aderivano alla nostra organizzazione, fenomeno che ci spiegavamo con la caratteristica della nostra città. Ancona, lo dice la storia dei movimenti politici di cui è stata protagonista, è stata una città che si prestava ad essere campo sperimentale per l’ideologia anarchica, ciò naturalmente per le caratteristiche della sua economia artigiana (individualistica) e piccolo-borghese.
Per un certo periodo, man mano che la sua fisionomia cambiava con il modificarsi dei mezzi di produzione, la tradizionale politica continuava a svolgere il suo ruolo, cioè si continuava ad aderire alla concezione anarchica malgrado che le condizioni sociali andassero mutando anche se non radicalmente. Si era anarchici da padre in figlio. Cioè l’operaio di una fabbrica, figlio di un artigiano anarchico influenzato dalla politica ideologica del padre continuava sulle orme paterne.
Poi ad un certo momento la svolta. Ecco, fra tanti, un certo numero di giovani anarchici che passano al Partito comunista durante la Resistenza politica: Mario Medici, operaio; Sirio Piermattei, operaio; Ernesto Suardi, navigante; Volturno Pugnaloni, operaio; Bruno Fattori, operaio; Cafiero Cola, operaio; Gherardo Corinaldesi; Silvio Franchini, commerciante; Bruno Stecconi, portuale; Antonio Vignoni; Riziero Di Chiara; Vero Candelaresi, operaio; Armando Bontempi, edile;Spartaco Cecili, operaio.
La gioventù comunista
Nel 1939, considerato il numero dei giovani che si sono avvicinati all’ organizzazione il comitato direttivo decide la creazione della Federazione giovanile comunista la cui direzione viene affidata al diplomato Alessandro Maggini.
A questo compagno, nato da una famiglia operaia di tradizioni rivoluzionarie, si accompagnano: Aldo Pelliccia, studente liceale; Luigi Acresso, studente liceale; Renato Bramucci, operaio del Cantiere Navale; Adelmo Matteucci, operaio del Cantiere Navale.
In breve tempo saranno centinaia i giovani che aderiranno a questa organizzazione e la serietà e lo spirito che animavano questi giovani è illustrato da uno stralcio di una memoria scritta nel 1949 dal compagno Renato Bramucci, venuta recentemente in mia mano.
Questa memoria è uno sprazzo di vitalità che l’estensore ha scritto solo per lui e che ho pensato di inserire in queste mie memorie, come documentazione, perché priva di ogni artificio o di intimo compiacimento ed è una testimonianza del genuino entusiasmo che animava i giovani comunisti molto tempo prima della battaglia di Stalingrado, che dimostra come questi giovani avessero trovato nella lotta di classe contro il capitalismo, e quindi contro il fascismo, il giusto obiettivo che dava un senso reale alla loro vita di lavoratori. Lo stralcio della memoria del compagno Bramucci indica che il fascismo non esercitava nessuna influenza sulla gioventù operaia e indica, inoltre, anche la serietà con cuil’intera organizzazione (adulti e giovani) per numerosi anni è stata diretta. ..
Da una memoria del giovane compagno Renato Bramucci:
«… a 10 anni cominciai a lavorare. Ricordo che ancora frequentavo la va V° elementare. In un calzaturificio ebbi il primo contatto col lavoro…
Così passarono gli anni. Scoppiò la guerra d’Abissinia… intanto la mia vita continuava, lavoro, ballo, ecc.
Poi cambiai mestiere: il meccanico di motociclette… il lavoro mi entusiasmava moltissimo… imparavo presto e bene… malgrado mi arrivasse ogni tanto uno scappellotto. Quel lavoro per quanto mi piacesse, durava 10 o 12 ore al giorno… Iniziava dentro di me un senso di ribellione che non riuscivo a ben definire.
Avevo 14 anni.
…dopo il lavoro mi incontravo con alcuni amici e ci raccontavamo ciò che ci interessava; cose da ragazzi.
I soldati ritornavano dalla guerra d’ Abissinia e raccontavano… altri partivano per un’altra guerra quella di Spagna. Eravamo scontenti, parlavamo… non sapevamo cosa fare… tra i miei amici studenti le preoccupazioni e le insoddisfazioni erano le stesse.
Niente ci entusiasmava.
… cominciai le visite alla palestra di pugilato… questa nuova attività mi permise di non avere noie alla sede del “fascio” perle assenza dalla “premilitare”…fu nell’ anno 1939 che per la prima volta incontrai in una passeggiata in campagna, alcuni uomini che discutevano di cose per me nuove.
Conoscevo uno di loro, mi avvicinai, cose belle dicevano, soprattutto una frase mi colpì: la lotta per un migliore domani.
Continuavo lo sport, gli incontri si succedevano, vittorie, pareggi, mi battevo con passione.
I contatti con quella gente, strana gente, che per parlare doveva nascondersi e prendere infinite precauzioni, continuavano.
Gli esami per l’assunzione alle ferrovie erano riusciti e dovevo prendere servizio… ottenni anche l’assunzione al Cantiere Navale. Dovevo scegliere. Mi consultai con mio padre, un ferroviere… entrai al Cantiere in qualità di tornitore.
Questa mia precisa decisione era dovuta al gran fascino che esercitavano su me i racconti dei miei nuovi amici e alcuni libri che cominciavo a leggere sulla lotta di classe nelle fabbriche. ..ma non potevo sfuggire al fascino della fabbrica, all’urlo della “sirena”, alle migliaia di operai che si muovevano a quel comando. Non so, mi dava un senso di forza… a sentirsi parte di essa.
Il lavoro mi teneva impegnato 12 ore della giornata. Non per questo rinunciavo ad avere contatti con quelli che erano diventati miei compagni.
Compagni di lotta.
Da allora mi dedicai all’organizzazione comunista con più tenacia. Ci organizzammo in cellule… la cerchia continuamente si allargava nel mio reparto… da due, poi dieci, venti, trenta, tutti giovani. Eravamo una forza organizzata……
Abbandonai il pugilato.
Divenni responsabile dei giovani organizzati nel Cantiere.
Nel 1940 il fascismo entra in guerra. Sono giornate terribili. I giovani rispondono in pieno. Due dei nostri vengono arrestati. Ma il morale è altissimo.
Altri venivano a noi… l’arresto fece l’effetto contrario.
Nelle ore libere insieme con altri due compagni feci parte del gruppo tipografi per la stampa clandestina.
Stampavamo anche lezioni di economia politica per organizzare corsi per giovani, corsi ai quali partecipavo io pure.
…tra una lezione e l’altra si svolgeva a turno il lavoro pratico e più pericoloso, cioè la distribuzione dei manifestini nella città enello stabilimento.,
Un giorno fui informato che dovevo partecipare ad una riunione di responsabili di reparto: appuntamento al Duomo. Fui puntuale come sempre.
Era una delle cose che ci avevano insegnato: non arrivare mai un minuto prima perché pericoloso per noi, non arrivare mai un minuto dopo perché pericoloso per gli altri.
Quella sera avemmo il primo contatto con il capo dell’organizzazione comunista delle Marche. Come poter dire la nostra gioia?! Ci sentivamo importanti, forse lo eravamo veramente.
Personalmente lo ritenevo una cosa molto grande e di immensa responsabilità.
In altre parole, ritenendoci idonei per quell’incontro, voleva dire che eravamo degli uomini o per lo meno ragazzi ritenuticapaci di mantenere il segreto qualunque fosse stata la nostra sorte.
…avevo finalmente trovato uno scopo di vita, quello della lotta, la lotta degli umili, della gente della mia classe…
…ormai eravamo in piena guerra. Organizzammo una serie di azioni per far diminuire le ore di lavoro e per far aumentare i grammi di pane che ci venivano con la tessera annonaria (grammi 250 al giorno).
Interessammo della questione i sindacati che fecero orecchie da mercante, il che fece aumentare il malcontento che si concretò con far apparire dovunque i simboli del comunismo e frasi contro il fascismo.
Un giorno i fascisti organizzarono una provocazione. Doveva parlare il “duce” e dovevano portare gli operai al centro della città e ordinarono di fare due cortei: per i tesserati p.n.f. e ‘altro per i non iscritti, pensando, forse, che il secondo non si sarebbe formato. Invece i gerarchi si erano sbagliati perché incominciato dai giovani dell’organizzazione clandestina, sotto gli occhi stupiti degli operai anziani e dei fascisti, il secondo corteo, quello dei non fascisti, diventò più lungo e numeroso del primo, anche perché al secondo parteciparono operai che in tasca avevano la tessera fascista…
In occasione di un tentativo di indurre i giovani dello stabilimento ad arruolarsi volontari nella “Mil-mart” organizziamo la resistenza contro le pressioni esercitate da ufficiali della m.v.s.n.
Centinaia di giovani, facendo ala ai lati della strada, per 2/300 metri, salutarono con il “pugno chiuso” la salma di un giovane compagno deceduto. Lo stupore della folla, in mezzo alla quale vi sono pure fascisti e carabinieri è grande, ma non si hanno reazioni (forse è l’effetto delle sconfitte sul fronte bellico?!)
La lotta continuava in fabbrica. La mia posizione non era molto buona, fin quando giunse un avviso di denuncia al tribunale militare di Firenze per essere stato assente dal lavoro per tre giorni, senza permesso.
Mi diedi alla latitanza. Ormai avevo molto tempo da utilizzare e lo dedicai all’organizzazione e alla stampa clandestina.
Il 25 luglio 1943è vicino. Incomincia la resistenza armata.
La “tuta” e lo “smoking” in soffitta
Uscito dal carcere giudiziario nel settembre 1937, le condizioni economiche della mia famiglia mi obbligano a lasciare l’appartamento di via S. Speridioni n. 1 ed andare ad abitare di nuovo nel rione “Guasco”, in vicolo dei Tribunali 14/A. Cioè un magazzino, un pianoterra sprovvisto perfino della cappa del camino e con i servizi scadentissimi, primordiali. Una oscura scaletta conduce al piano superiore dove sono due vani pomposamente chiamati camere. Qui dormiamo mia moglie, mio figlio Roberto, di quattro anni, in una “camera”; mia madre nell’altra. Al pianoterra, come già detto, mia madre e mia moglie si ingegnano a confezionare coperte imbottite per un negozio ed io mi arrangio con il rigattiere pur cercando altro lavoro, per dar loro un aiuto.
Nel giugno 1938 il fratello di mia moglie, Enrico, cameriere presso il caffè Diana di Ancona, mi presenta il gestore di un caffè di Senigallia, che ha bisogno di un cameriere per la stagione estiva. È un lavoro che posso assolvere. Devo confessare quali sono i miei precedenti politici, ma egli, Ettore Giampaolo, ex ferroviere licenziato dal fascismo nel 1923, mi risponde che i miei precedenti non gli creano alcuna preoccupazione, purché io mi metta a posto con i sindacati della categoria.
Non mi fu difficile invero ottenere il “nulla osta”dei sindacati e pertanto nei mesi di luglio e agosto 1938 lavorai a Senigallia, un paese a nord di Ancona (24 km.) dove portai anche mia moglie e mio figlio perché potessero anche loro, una buona volta, godere di un po’ di sole e di aria pura del mare.
Durante quel periodo non persi tempo. Mi faccio fare la barba e i capelli da un barbiere vicino alla mia abitazione. Il barbiere Ottavio Palestrini, una parola oggi e una domani, finisce col rivelarmi che è un antifascista, anzi è un comunista.
In breve, prima che tomi ad Ancona per la fine della stagione estiva una cellula comunista si costituisce con i compagni: Ottavio Palestrini, Silvio Pasquini, Alberto Zavatti (che diventerà sindaco di Senigallia), Michele Manicci, Olivi.
Tornato ad Ancona con una sommetta che avevamo risparmiato nei due mesi trascorsi a Senigallia, eravamo al riparo della fame per ancora un mese. Fu in quel tempo che il marito di una mia cugina, gestore di un bar e di una pasticceria, mi propose di fare da cameriere in occasione di servizi privati come matrimoni, cresime, ecc. che a quell’ epoca si usava fare in casa e non come oggi in ristorante.
Per un servizio del genere, allora, il cameriere veniva ricompensato con £. 25 che consentivano di vivere altri due giorni. Ma feci in tempo a fare tale lavoro solo una volta perché sparsasi la notizia fra i lavoratori del settore, questi protestarono affermando che non ero del mestiere, non appartenevo alla loro “corporazione”.
Lo stesso trattamento mi avevano riservato alcuni operai jesini, allorquando mi videro lavorare attorno alla forgia ed al maglio alla fabbrica di Guerri di Jesi, perché ravvisarono in me, un “concorrente”, un “forestiero”, che non conoscevano chi fossi, ma comunque uno che toglieva o avrebbe potuto togliere loro un posto di lavoro e cioè un pezzaccio di pane duro. Morale: anche lo “smoking” da cameriere passò in soffitta accanto alla tuta da operaio, e tornai dal rigattiere. Senza malanimo, con comprensione, riferisco che all’alba della Liberazione trovai, giustamente, questi lavoratori tra le file antifasciste, anzi, membri del P.C.I.
Le persecuzioni continuano
Tirai avanti alla meglio, sempre con l’aiuto di mia madre e di mia moglie anche durante l’anno 1939. Per lo stesso periodo tornai a fare il cameriere a Senigallia con lo stesso risultato del 1938 e, naturalmente, curai ancora meglio la cellula comunista che nel frattempo si era sviluppata.
Sul finire di quell’anno ero da poco tornato ad Ancona, quando Mussolini pronuncia un discorso invitando chi di dovere a “ripulire gli angolini” . Quella stessa sera sono a tavola con un gruppo di compagni pescatori e pescivendoli, che avevano organizzato una cenetta in una osteria denominata “La tenda Rossa”, situata a circa 150 metri da piazza U. Bassi di Ancona, cioè in una località né periferica né centrale, non cantavamo ne stavamo zitti, non davamo fastidio a nessuno…
Improvvisamente l’osteria viene accerchiata da un nugolo di poliziotti scesi da un autocarro, che penetrati nella sala intimano a tutti noi: “Fuori i documenti” Tutti esibiscono i propri, io solo ne sono sprovvisto ma il “capo” intima: “tutti in questura!”Conclusione: dopo alcune ore eravamo una decina che stavamo digerendo gli spaghetti al sugo di pesce, in celle isolate al carcere giudiziario (era la nona volta che nel corso della mia vita mi vedevo privo della libertà personale).
Qualche giorno di cella, ancora una volta: “fuori con tutta la robba!”, vengo condotto in prefettura, insieme a Goffredo Gobbi e condotti dinanzi alla Commissione provinciale per il confino composta dal Prefetto, Questore, Colonnello C.C., console m.v.s.n. e Procuratore del Re; segretario un Commissario di P.S.
Inizia il Prefetto con alcune formalità poi dice: “Da quanto risulta voi non lavorate e siete sempre in giro facendo propaganda antifascista, almeno questi sono i sospetti!».
Rispondo: «Sì, è vero, sono disoccupato, ma non perché non abbia voglia di lavorare. Qualcuno si oppone o frappone ostacoli perché io non vada al lavoro. In quanto alla propaganda antifascista – Signor Prefetto – supponga che si incontrino due persone affette da mal di denti, è evidente che costoro parleranno del male che li affligge. Non ci vuol molto a capire che se si incontrano due morti di fame costoro non parleranno che delle loro necessità, del loro problema, delle cause, che provocano la loro misera condizione e naturalmente il modo come risolvere le loro necessità! Se questo significa fare propaganda antifascista, ebbene signor Prefetto, quanto Lei dice, risponde a verità!».
Interviene il Questore che puntando il dito accusatore dice: «Lo sentite, Eccellenza, che razza di tipo è costui’!!».,
Capisco di aver preso un atteggiamento sbagliato, avrei dovuto, come si dice, fare il “nesci”; fare quello che realmente sono: lo stupido, perché solo in caso di necessità dobbiamo scoprirei di fronte all’avversario.
La commedia non durò molto. Il giorno dopo devo firmare il verbale e sentire la sentenza.
Altri due anni di ammonizione a datare 6 dicembre 1939, scadenza 6 dicembre 1941.
Agli inizi del 1940, a causa della situazione internazionale (malgrado la dichiarata “non belligeranza” del governo fascista) l’industria italiana era tutta impegnata per la produzione bellica, molti uomini “sotto le armi” dal 1935, in particolare “gli specialisti”. Le industrie del Nord si contendevano le maestranze e annunci economici sulla stampa promettevano salari superiori a quelli stabiliti dalle corporazioni del regime e molti operai attratti da migliori prospettive partivano per la Lombardia e il Piemonte abbandonando le fabbriche della città. Naturalmente, come ogni altro fenomeno del genere, anche questo serviva ad approfondire le nostre cognizioni circa le ferree leggi dell’economia che era l’argomento che più appassionava i nostri giovani organizzati.
La penuria di lavoratori mi favorisce ed infatti vengo assunto all’I.C.I.C., uno stabilimento che produce olio di ricino per gli aeroplani da guerra. Sacchi sulle spalle da 100 kg. non li avevo mai portati anche perché fisicamente non ero mai stato un “ercole” e il tipo di alimentazione degli ultimi dieci anni non mi aveva certa-mente favorito. Per la verità devo dire che quando gli altri lavoratori appresero chi ero si fecero in quattro per dimostrarmi la loro solidarietà e facilitarmi … l’allenamento.
La fabbrica di scarpe per donna
Nel 1941 l’organizzazione era in continuo aumento.
Lo sviluppo di essa si spiegava con l’evolversi della situazione politico-militare. L’Europa per la politica nazifascista era stata investita dalla guerra totale. È vero che nel 1940 tutta l’Europa era caduta tra le grinfie dei nazisti, ma non era ancora finito l’anno che, brutte notizie circolavano circa l’andamento della aggressione fascista alla Grecia.
I contatti politici organizzati con l”, a provincia e la regione marchigiana si intensificavano e la “Voce del Lavoro” ;periodico della nostra organizzazione, aumentava la sua tiratura.
Fino a quel momento le spese erano state fronteggiate con piccole quote versate dagli organizzatori, ma quello che si raccoglieva cominciava ad essere insufficiente.
Su proposta fatta dal compagno Vittorio Marinelli si decise per la creazione di un organismo economico sotto forma di una piccola fabbrica di scarpe per donna. La direzione tecnica venne affidata allo stesso compagno Marinelli di professione “modellista” con il concorso del compagno Gino Grilli, anche egli del mestiere, al quale venne affidata anche la responsabilità amministrativa.
La piccola fabbrica venne allestita in un locale invia Cialdini n. 94, ed occupò una dozzina di compagni operai e operaie. La produzione, tramite il compagno Gherardo Corinaldesi, anche egli membro del comitato direttivo come Marinelli e Grilli, veniva venduta a negozi della regione, gestiti generalmente da compagni e comunque simpatizzanti. Tale lavoro permetteva a Corinaldesi di assolvere con una certa copertura anche la sua attività di contatto con la regione, dove facevamo pervenire copie della “Voce del Lavoro”.
Nel dicembre 1941, terminati i due anni di ammonizione i compagni responsabili proposero, ed io accettai, di lasciare il lavoro per dedicarmi totalmente all’attività politica con la sovvenzione mensile necessaria per vivere.
I principi del leninismo
Nello stesso anno pervenne al Comitato uno stampato che un compagno aveva rinvenuto in treno. Caratteri minutissimi, carta finissima, l’opuscolo rivelava la sua origine cospirativa. Si trattava di alcune lezioni tenute da Stalin all’Università di Sverdlov su “I principi del leninismo”.
In primo luogo l’opuscolo stampato in lingua italiana significava, per noi, la presenza di un’organizzazione centrale del Partito. Inoltre, una esposizione teorica del leninismo fatta da Stalin – l’uomo che con Lenin, per noi, personificava l’Unione Sovietica, la patria socialista, la rivoluzione mondiale, il Partito, tutte le nostre aspirazioni.
Stalin era l’uomo vivente che non potevamo tradurre in italiano perché per quanto accaduto in Italia dopo il 1922 in generale e dopo il Congresso di Lione e le leggi eccezionali del 1926, non avevamo più avuto modo di sapere chi incarnava fisicamente il nostro partito. Avevamo sentito i nomi di Antonio Gramsci, Mauro Scoccimarro, Umberto Terracini, in carcere e al confino, ma di questi compagni non conoscevamo il valore politico, pertanto non avevamo nome di compagno italiano da utilizzare concretamente per farne quel mito del quale sembrava non si potesse fare a meno. Ciò a dimostrazione di quanto fosse la nostra impreparazione politica o quanto meno indicava l’arretrato stadio della nostra educazione, o meglio, il grado della nostra ignoranza.
Essere in possesso di una esposizione teorica su i principi del leninismo fatta da Stalin, in quel periodo, ci sembrò di possedere un tesoro che bisognava mettere subito a disposizione dei compagni perché ne traessero coraggio, sicurezza, fede in se stessi, nella classe operaia e nel suo Partito: il Partito Comunista. Ci sembrò di esse-re sulla giusta via e che questa, sull’onda delle contraddizioni esistenti nella società capitalista, che man mano andavano sempre più acuendosi, doveva portarci per forza alla rivoluzione.
Ancona Specchio dell’organizzazione comunista clandestina negli anni 1942 – 1943 (al 27 / 7)
- SEGRET. ORG. MADERLONI R.
- AMMINISTRAZIONE GRILLI G.
3. STAMPA CORINALDESI G.
- CULTURA CATALINI E.
- FABBRICA SCARPE MARINELLI V.
- ORG. NE GIOVANILE MAGGINI A.
- RESP .1° ZONA MEDICI.M .
- SMIST. STAMPA MOSCONI M.
- CEL. PASSO VARANO CARLETTI E.
- CEL. TAVARNELLE TALEVI A.
- CEL BANCARI GIANNINI R.
- CEL. BORGHETTO GALEAZZI A.
- CEL. POSATORA MOCHEGIANI
- CEL. FERROVIERI MONTI EUG.
- CEL TRANVIERI PIERMATTEI M.
- CEL.UNIVERITÀ’ BALDONI R.
- CEL PINOCCHIO MESTI L.
- CEL ANGELICI FRATINI A.
- SMIS. STAMPA MARINELLI P.
- CEL. VIGILE DEL FUOCO TURCHETTI. E
- RESP. 2 ZONA FIORDELMONDO A.
- CEL. PORTUALI GALEAZZI ATL.
- CEL. ARSENALE RICCI REMO
- BUCO TIPOGRAFIA CLANDESTINA
- GRUPPO MISTO REGNI LIBERO
- GRUPPO MISTO SORGONI ANG.
- CEL. GUASCO CANAFOGLIA C.
- CEL. CAPODIMONTE CANDELARESI
- CEL S. PIETRO BALDASSARI R.
- CEL. OSPEDALE FILIPPETTI
- OSIMO QUINTO LUNA
- LORETO MONTANARI
- JESI BERNACCHIA
- C. FERRETTI PIER PAOLI C.
- SENIGALLIA ZAVATTI
- P. S. GIORGIO COLEFFI
- FERMO VANNI COLA
- ASCOLI PACIFICI
- MACERATA SARTI ROLANDO
- PORTO CIVITANOVA SILENZI ALCIDE
- FABRIANO SERAFINIA.
- PESARO AMDORI QUINTO
- SELLINI PEZZOLESI
- SIROLO VANNUCCI LIBERO
- CAMERANO
- MONTE URANO MARZIALI
- MONTEGRANARO DICHIARA C.
- RIMINI CORRIAS
- BOLOGNA MANCINELLI
- TARANTO GIANNINI E.
- MILANO CORINALDESI
- PERUGINA DAVANZALI
- ROMA MONFERINI
- RAVENNA FORNARO
- IMOLA POGGIALI C.A.
Una testimonianza (trascritta come da originale)
Al Comitato del Partito Comunista Italiano
della Città di ANCONA
Cari compagni,
sento il dovere, prima di rivolgermi a codesto Comitato con questa mia domanda di presentarmi. Mi chiamo Babic Ivan (Giovanni) nato il 9.9.1918 a Kepic, ora domiciliato in Labin (Albona) Istria, via Djun: Salaj I(Jugoslavia).
Mi rivolgo a codesto Comitato con la domanda a ciò che da esso mi sia rila-sciato un certificato col quale si conferma che sono stato membro del P.C.I. dal mese di luglio 1941 sino al4 ottobre 1943, quando volontariamente entrai a far parte della Armata popolare partigiana jugoslava che durante il periodo che fui membro del P.C.I. collaborai per la causa comune operaia, per il benessere del popolo italiano, allo scopo di restaurare un nuovo ordinamento sociale in Italia.
Rammenterò una parte della mia attività politica svolta in quel periodo in Italia.
Verso la fine dell’anno 1938, sono stato chiamato soli o le anni nella Regia Marina Italiana… Dopo breve tempo di permanenza a Tobruk (Libia) per via dell’antipolitico mantenimento a riguardo il regime di quel tempo fui rimpatriato e trasferito in “Lista nera” a Taranto… qui trovai più marinai i quali, come me, dall’aspetto politico, non erano fedeli al regime governativo del tempo.
Incontrai un marinaio di cognome Tamagnoni… nativo di Savona, il quale
scontò la pena di l0 anni di prigione per via che nel 1931, quando l’Italia prese parte bellica contro il risorgimento nazionale in Cina, rifiutò combattere contro il popolo cinese. Qui stava scontando il periodo di leva. Ci siamo subito compresi circa i nostri punti di vista politici.
…di giorno in giorno aumentava il numero di marinai i quali avevano le nostre stesse idee e tra questi era la maggior parte dell’Italia settentrionale.
…verso la metà dell’anno 1941 abbiamo incominciato a fare ricerche per col-legarci con il P.C.I. per la città di Ancona.
Questo ci è andato di mano, mi ricordo bene che quando la Germania dichiarò guerra all’URSS, tramite il nostro compagno marinaio di nome Giunnini Ezio, nativo di Ancona, ci abbiamo collegato con il Comitato del P.C.I. per la città di Ancona.
…fratello di Giannini Ezio a quei tempi, se non sbaglio, era membro oppure segretario del P.C.I. per la città di Ancona,
… Tutte le direttive e istruzioni per il lavoro ricevevamo da codesto Comitato, regolarmente pagavamo i contributi mensili del partito che noi in quel periodo chiamavamo soccorso rosso.
La nostra “celia” di giorno in giorno venne più for
te dal punto di vista organizzativo e costantemente aumentava di numero, così che verso il principio contava 30-40 membri. Dato che il lavoro illegale del partito era pericoloso per via della grande numerosità dei membri, e in più si rischiava il pericolo che nella grande “celia” si infiltrassero agenti politici, abbiamo ricevuto direttive e istruzioni da Ancona di riorganizzare la “celia”.
In quella occasione abbiamo formato più “celia” e ognuna contava tre membri. In più abbiamo formato Comitato del Partito, il quale aveva il compito di dirigere le nostre “celie” del Deposito e le “celie” che si trovavano sparse nella base marittima di Taranto.
Quanto mi ricordo nel Comitato erano: Giannini Ezio di Ancona, Calcagno nativo di Savona e sergente Cirulli pure di Savona.
…lavorava in segreteria dettaglio del Deposito Dimini Luigi nativo di Valmazinghi (Pola), quei tempo lo chiamavano “porta stagna” (caduto nell’ Armata popolare jugoslava) perché solo tramite lui potevamo rivolgerci per qualche spiegazione al Comitato.
I compiti della nostra attività politica di quel tempo erano: ingrandire le file del partito e formare nuove “celie”; agitare e propagandare fra i marinai evitare di imbarcare su navi da guerra, informare i marinai realmente come si svolgono le operazioni belliche sui veri fronti, specialmente sul fronte russo, ecc.
Per informare marinai di quanto detto, da Ancona ricevevamo direttive e in più il giornale “l’Unità” (La voce del Lavoro, foglio ciclostilato dei comunisti anconetani) il quale dopo che ci siamo resi conto del suo contenuto, lo spedivamo in Calabria, Sicilia e altrove, secondo le istruzioni ricevute.
Verso la fine del 1942, dato che le direttive ricevute da Ancona, i nostri compagni che erano compressi e si supponeva che saranno carcerati per attività politica, li spedivamo adAncona. Mi ricordo bene come dovevamo falsificare i documenti di questi compagni. Questo ci era possibile perché segretario del comandante in 2A era Giannini Ezio e il sergente Cirullistava in segreteria dettaglio. Io e Carlo avevamo il compito di procurare (in bianco) la licenza illimitata e i scontrini resa ferroviaria perché eravamo di “comandata fissa” nel magazzino stampati.
I compagni che abbiamo avviati ad Ancona si dovevano presentare in via Flavia II Ancona (via Flaminia 74 abitazione del compagno Giannini Ruggero).
Come il Comitato della Città di Ancona impiegò questi compagni nei compiti del partito io non lo so.
…nel mese di aprile 1943 abbiamo ricevuto da Ancona riguardo la caduta del fascismo… ci è stato detto che verrà l’insurrezione popolare in tutta Italia. A riguardo di ciò che avverrà dovevamo fare subito un piano d’azione e mandarlo per l’approvazione ad Ancona… il piano mandato ad Ancona è stato approvato con l’istruzione a base del piano nessuna a propria mano incominci l’azione perché a
Taranto verrà un membro del Comitato Centrale del P.C.I. il quale dirigerà tutte le azioni nella base navale di Taranto e di ciò saremo in tempo avvertiti.
… dato che tra Taranto e Ancona si è creato il fronte bellico e non abbiamo riusciti a collegarci… noi istriani, col consenso del nostro Comitato… abbiamo formato brigata popolare partigiana preso parte alla lotta in Jugoslavia e il 31.8.1946 mi sono congedato con il grado di ufficiale di artiglieria.
…in attesa… invio i miei saluti a tutti i compagni di Ancona e di tutta l’Italia.
Lubin 12.11.1966
Babiclvan
Tra i marinai organizzati clandestinamente in una cellula nell’ambiente militare di Taranto, vi erano oltre agli anconetani Lorenzetti Ottorino e Cinti Vezio anche Giovanni Giorgella, vigile urbano del Comune di Ancona.
I due fronti o le due forme di dominio borghese
Giunti a questo punto reputo necessario fare alcune considerazioni d’indole generale per spiegare il mio modo di pensare di allora.
Quando mi decisi ad aderire alla gioventù comunista, il I fascismo non potevo vederlo che sotto l’aspetto di un branco di violenti, che sotto la protezione delle “forze dell’ordine” distruggeva gli organismi di difesa dei lavoratori, per gli interessi della classe capitalista. Poi mi convinsi che il fascismo era lo strumento politico della parte più reazionaria del capitalismo e che a questo strumento soggiacque, più o meno volontariamente, sia le altre parti del padronato, come pure parte dei ceti medi. Sottomissione o collaborazione dovuta non già per la difesa di interessi particolari ma per quelli di carattere generale, cioè la difesa di una società avente per base la proprietà privata.
Il fascismo prima metterà il bavaglio alla classe operaia e ai suoi alleati, poi nel suo logico sviluppo, lo metterà anche alle altre categorie intermedie, e conseguenza delle sue interne contraddizioni, aggredirà anche alcuni settori della classe capitalista sia pure sotto la maschera del razzismo antisemita.
Da ciò l’instabilità politica delle classi intermedie che gradualmente cesseranno la loro collaborazione al regime, senza cessare, in linea di massima, di avere quella ancestrale paura della classe operaia e della instaurazione di un’economia pianificata, socialista, pertanto non faranno quasi nulla contro il fascismo, almeno fino a quando non riterranno opportuno intervenire per impedire che il crollo del regime significhi pure il crollo della loro società.
La burla delle “sanzioni economiche” stabilite dalla Società delle Nazioni non ci inganna perché pensiamo che non saranno gli Stati capitalistici che hanno tenuto a battesimo il fascismo a dare a questo “il colpo di grazia”, così come non ci inganna la demagogia del regime quando promette, con la conquista di “un posto al sole”, mari e monti per il popolo italiano. Gli slogan “raccorceremo le distanze”, “realizzeremo una più alta giustizia sociale”, lasciano il tempo che trovano.
D’altra parte non eravamo disposti a farci ingannare dalla demagogia dei governi socialdemocratici inglese, francese e statunitense.
Perlomeno pensavamo di non farci ingannare. Consideravamo nemico degli interessi della classe operaia sia il capitalismo che si serviva dello strumento politico nazifascista, come quello che si nascondeva sotto la maschera socialdemocratica. Non ci era sfuggita la natura imperiali sta della guerra in atto dal 1939, anche se i fascisti andavano a presentarcela come una guerra di Stati proletari (Italia-Germania-Giappone) contro gli Stati ricchi e colonialisti (Inghilterra-Francia).
Da rilevare che gli Stati del primo gruppo avevano governi privi di ogni forma democratica mentre gli Stati del secondo avevano governi eletti democraticamente ma che avevano lasciato assassinare la repubblica spagnola con la finzione del “non intervento”, avevano permesso l’occupazione dell’Etiopia, dell’ Albania, dei “Sudeti” cecoslovacchi, dell’Austria e avevano aiutato, palesemente o no, i fascismi a divenire grandi e potenti e in sostanza la vittoria dell’uno e dell’altro gruppo non avrebbe significato per la classe operaia, per tutti i lavoratori, di qualsiasi Paese, concreti miglioramenti delle loro condizioni economiche, sociali e politiche. Noi eravamo contro la guerra, quel tipo di guerra.
Ciò nonostante ci sentimmo fortemente emozionati alla notizia che la Francia era stata messa in ginocchio dalle armate naziste e ci sentimmo offesi dall’atto maramaldo compiuto dal governo fascista che volle piantare un pugnale nelle spalle della “sorella latina” ormai morente.
Allorché la Germania nazista aggredì l’Unione Sovietica non esitammo a considerare il nemico nazifascista come il primo da combattere, .intanto perché era di fronte alla nostra trincea, poi perché era esso che aveva osato attaccare il primo Stato socialista, attacco che ritenevamo portato contro l’intero mondo del lavoro.
L’aggressione contro l’URSS non ci sorprese, ci eravamo abituati da sempre ad attenderei un attacco del genere, ma in particolare dopo l’incontro di Monaco tra Daladier, Chamberlain, Mussolini, Ritler, avvenuto nel 1938. Comprendemmo la giustezza della posizione sovietica nel patto Stalin-Ribbentrop e dovemmo sostenere attacchi da parte dei trozkisti che come solito erano contro la politica di Stalin.
Il resto è storia: l’attacco e l’occupazione della Cecoslovacchia, della Polonia, della Francia e degli altri paesi d’Europa, sino alla penetrazione in terra sovietica.
Fino a quel momento avevamo desiderato una sconfitta militare che avesse messo in crisi i regimi di Hitler e Mussolini e avesse creato all’interno delle nostre nazioni, condizioni attea fare i prendere iniziative per l’eliminazione della dittatura e l’avvio verso una società veramente democratica. Seguivamo gli avvenimenti c per quanto preoccupati per la piega presa da essi, rimanevamo calmi in attesa degli e-venti convinti che una volta messo in moto il cataclisma del conflitto qualche cosa sarebbe successa per uscire fuori dalla melma fascista. Il cattivo andamento delle operazioni militari tedesche in Africa, la lunga stasi delle operazioni sulla Manica, la “burletta” della fuga dalla Germania di Hess (indicato come il numero uno dopo Ritler) ci fa pensare che siamo di fronte ad un tentativo per arrivare ad un compro-messo con la Gran Bretagna.
La cronaca dice: novembre 1940 – vengono “affondate o colpite a Taranto le corazzate “Littorio”, “Duilio” e “Cavour”. Novembre 1940: ripiegamento generale in Albania. Gennaio 1941: continua la disfatta in Libia. Maggio 1941: resa totale dell’impero italiano. Non si hanno notizie sul piano d’invasione dell’Inghilterra. 20 maggio 1941: Hess fugge in Inghilterra. 22 giugno 1
941: aggressione tedesca all’ U RSS.
Pensammo che l’aggressione all’Unione Sovietica non costituisse un atto di forza ma una dimostrazione data da Ritler per convincere l’avversario inglese che le pro-poste fatte da Ress, per un compromesso avevano un fondamento concreto.
Ma intanto la nostra organizzazione si trovava di fronte ad una tragica realtà:
l’Armata Rossa registrava enormi sconfitte.
Avevamo letto e ci avevamo creduto che «L’armata rossa avrebbe rintuzzato chiunque avesse tentato di mettere il suo grugno di porco nell’orto sovietico», Così aveva detto Kalinin Presidente dell’Unione Sovietica in un suo discorso, Era tanto l’amore che i lavoratori portavano al Paese dove si stava costruendo il socialismo che al pensiero che potesse diventare preda del nazismo, si sentivano morire. I compagni si chiedevano come mai ciò potesse accadere!
Se allora avessimo potuto rovesciare l’amarezza che era nei nostri cuori, l’avremmo fatto volentieri, avremmo voluto avere vicino compagni in grado di darci una spiegazione plausibile per rispondere agli angosciati interrogativi dei compagni di base.
Ed era inutile affermare che una delle ragioni poteva essere il fatto che le armate tedesche e i loro alleati avevano a disposizione tutto l’arsenale bellico dei paesi europei che aveva conquistato e che pertanto l’Armata Rossa si era trovata d’avanti un potenziale bellico molto più forte, più potente, di quello che si sarebbe potuto pensare un anno prima.
Hitler prima di attaccare l’Unione Sovietica, aveva occupato, quasi senza colpo ferire, tutta l’Europa, e maligni come siamo nei riguardi dei nostri avversari, pensiamo che probabilmente un accordo su terreno neutro ci possa anche essere stato tra i belligeranti, ambedue egualmente nemici del socialismo e dell’Unione Sovietica.
Ma compagno in grado di darci un aiuto in tal senso nelle Marche nel 1941 non c’erano o perlomeno non erano da noi conosciuti. Pertanto dovemmo arrangiarci.
Comunque il colpo, in rapporto all’immagine che ci eravamo fatti dell’Unione Sovietica, era grave.
Non c’è da vergognarsi se diciamo che la presenza nel mondo di uno Stato socialista è sempre stata, per noi operai antifascisti, immersi sino al collo nella dittatura, una speranza, un incitamento, e non potevamo vedere spegnersi questa luce, senza sentirci smarriti, senza sentire il bisogno di correre ai ripari perché tornasse a risplendere. Bisognava avere degli argomenti atti a far credere che la battaglia si sarebbe comunque conclusa con la sconfitta del nazifascismo.
Ecco qui di seguito quello che dicemmo ai lavoratori. Espongo qui senza reticenza la teoria che permise ai compagni di riprendere fiducia nell’evolversi degli avvenimenti. Con i nostri mezzi organizzativi ricordah1mo ai compagni quanto studiato precedentemente, cioè le tre condizioni necessarie per avere possibilità di successo:
1) crisi politica della classe dirigente;
2) crisi economica che investe il Paese;
3) soggettività del proletariato.
Le tre condizioni fondamentali dell’economia capitalista:
- a) lotta tra il capitalismo e i popoli coloniali;
- b) lotta tra il capitalismo e il proletariato;
- c) lotta tra il capitalismo e capitalismo.
Contraddizioni che caratterizzano la moderna società capitalistica e che costituiscono le materie fondamentali della storia di questi ultimi decenni.
Dalla ripresa dell’attività organizzativa nel 1938,lo studio dell’economia si alternava con la storia, che costituiva uno degli argomenti più interessanti, durante le nostre passeggiate in campagna con i gruppi di giovani. In particolare i motivi delle ultime guerre e le sue conseguenze.
Pertanto non fu difficile ricordare ai compagni: la Comune di Parigi, conseguente alla guerra imperialista tra Germania e Francia per il possesso delle miniere di car-bone e di minerali di ferro, e il crollo del dittatore Luigi Napoleone Bonaparte.
Lo scontro per ragioni imperialiste tra la Russia zarista e il Giappone nel 1904/5 che si conclude con la sconfitta della Russia e il tentativo di rivoluzione.
È sempre per il possesso e per la rapina di materie prime, mercati e maggiore influenza nelle colonie, che nel 1914 scoppia la guerra tra due gruppi di Stati che si concluderà quattro anni dopo, con la sconfitta di uno di essi e con un serie di rivolgimenti sociali in numerosi Paesi e che darà luogo alla nascita dell’Unione Sovietica.
Ripeto che qui io scrivo quello che allora dicemmo e ricordammo per mantenerealto il morale dei compagni affinché continuassero ad avere fiducia nell’ avvenire, senza pretendere che le cose stessero effettivamente così. Continuammo dicendo: «Il mondo oggi è diviso in tre parti. Una parte è dominata dal capitalismo anglosassone, il secondo gruppo è composto da Germania, Italia e Giappone, prive di colonie o quasi. Il terzo è costituito dalle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il gruppo Inghilterra-Francia e alleati minori, fin dalla conclusione della prima guerra mondiale, manovrò in modo tale da isolare l’URSS creandole intorno uno sbarramento di Paesi anticomunisti e pur d’impedire l’avvento al potere in Germania di forze realmente democratiche, lasciò libero campo alle forze reazionarie e quindi al nazismo che fattosi grande, per le stesse leggi economiche che regolano il capitalismo inglese, oggi gli si contrappone».
«Quindi siamo di fronte a due capitalismi concorrenti spinti dalle stesse leggi dell’economia che si scontrano per ridividere le zone di influenza e il dominio del mondo. Questi due gruppi hanno più volte tentato di organizzare un fronte unico contro l’URSS, per riportarvi lo zarismo e lo sfruttamento; ma non vi sono riusciti grazie alla vigilanza della classe opera in internazionale. Non potendo realizzare i loro criminali piani, i due gruppi si sono dovuti scontrare tra loro e sembra che il gruppo Germania-Italia-Giappone abbia la meglio, perché i tedeschi hanno giù occupato quasi tutta l’Europa e stanno assediando l’Inghilterra per occuparla ed indurla ad arrendersi. Ma questo obiettivo non sembra facile; tanto più che e’è una incognita rappresentata dagli Stati Uniti d’America, poi, fati me incalcolabile, c’è l’Unione Sovietica, quindi troppi ostacoli per sperare in una vittoria definitiva, tanto più che le forze fasciste stanno pigliando botte in Grecia,in Albania dopo essersi ritirate da numerosi punti dell’Africa orientale dove si arrendono il 19 maggio 1941 ».
«In questa situazione si ha notizia che il numero due del nazismo, Hess, è fuggito in Inghilterra perché si è improvvisamente ammattito…ma poiché un mese più tardi e cioè il 22 giugno 1941, si scatena l’aggressione nazista all’ URSS, riteniamo che Hess sia stato latore di una proposta di compromesso fatta da Hitler all’Inghilterra, perché questa accetti una sosta nella belligeranza, una sorta di compromesso perché egli, Hitler, possa impegnarsi in un confronto con l’URSS ».
Ma poiché Albione nicchia, l’attacco all’URSS, vuol essere una dimostrazione seriamente impegnativa circa la reale volontà della Germania nazista di combattere il comune nemico: il comunismo. Non dimenticando quanto detto precedentemente sulla lotta dei tre gruppi, ma in particolare lo scontro, ma anche l’ipotesi di incontro tra i due gruppi capitalisti, ci sembrò possibile un piano germogliato dalla mente della gerarchia nazista.
Pressa poco questo:
“Cessiamo di minacciare inutilmente la Gran Bretagna, proponiamo le un armistizio, attacchiamo l’Unione Sovietica sicuri che in primo tempo non avremo fastidi dai nostri amici-nemici. Se riusciamo ad occupare rapidamente l’Unione Sovietica, come abbiamo fatto con la Francia, l’0landa, il Belgio, la Danimarca, la Norvegia, la Romania e nell’ aprile 1941 la Jugoslavia e la Grecia, d’accordo con il Giappone (patto tripartito del 27 settembre 1940) che già preme vittoriosamente sulla Cina e sull’India, stringeremo in una morsa l’Inghilterra isolandola dal suo impero coloniale, da cui trae, come fa da secoli, enormi ricchezze e profitti, creando, senza soluzione di continuità, l’enorme blocco dell’Eurasia, costringendo quindi gli inglesi alla resa a discrezione o, perlomeno, a patti concordati, eliminando dalla nostra controversia il nemico più pericoloso costituito dall’Unione Sovietica».
«Se invece non riusciamo a sfondare il fronte comunista, poiché saremo impegnati veramente come diga anticomunista speriamo in un “non intervento” degli U.S.A. (che nei primi mesi del 1941, erano ancora a discutere sulla pace e sulla guerra – infatti Pearl Harbour fu attaccata dai giapponesi il 7 dicembre 1941) e in un armistizio con l’Inghilterra, con ottime condizioni essendo noi nazisti padroni di quasi tutta l’Europa».
Torniamo quindi all’aggressione all’URSS. L’Armata Rossa indietreggia, e ciò provoca una forte impressione tra i lavoratori che incalzano con domande, alle quali bisogna dare una risposta.
Ai compagni poniamo un quesito: tenendo conto di quanto sin qui abbiamo detto, che cosa accadrebbe se le armate rosse, rintuzzando l’offensiva nazista, contrattaccando, inseguissero i nazisti in fuga ed entrassero vittoriosamente in Cecoslovacchia, in Romania ecc. puntando al cuor dell’Europa, cioè Berlino, accolti trionfalmente dalle popolazioni come liberatori?
Risposta: è evidente che di fronte al pericolo di vedere l’Europa invasa dalle armate rosse, con quel che ne consegue, immediatamente tutto il mondo capitalista supererebbe, sia pure provvisoriamente, i suoi contrasti e farebbe fronte unico contro il comunismo sovietico; cioè riuscirebbe al capitalismo quello che non gli è riuscito di fare dalla nascita del primo Stato Socialista e in tal caso non sarebbe facile all’Unione Sovietica, uscire indenne da una tale difficile situazione.
Altra domanda: ma allora se non può avanzare, per non provocare il blocco di tutti i suoi nemici, perché non si arresta su di una linea di difesa?
Risposta: supponete che i compagni sovietici avessero preso questa decisione. È ovvio che si assisterebbe per molto tempo ad un massacro di tedeschi e loro alleati e di sovietici in offensive” e controffensive, in uno stillicidio continuo, sino al totale indebolimento di entrambe le parti ad esclusivo vantaggio del terzo gruppo, che si guarderebbe bene dall’ aprire un secondo fronte per alleggerire la pressione dei nazisti sui sovietici e viceversa, anzi, molto probabilmente, sia pure tramite neutrali, o c1andestinamente, rifornirebbe, di volta in volta, gli uni e gli altri, per aiutarli a scannarsi a vicenda, salvo poi al momento giusto presentarsi sulla scena ed imporre a destra e manca le sue condizioni che sarebbero certamente letali per i sovietici e in un certo modo favorevoli al capitalismo tedesco come già avvenuto dopo la sconfitta del 1918 (e oggi possiamo dire anche come dopo quella del 1945).
Tornando al nostro assillante problema, se avanti l’Armata Rossa non può andare, se non può arrestarsi su di una linea di difesa, anche se elastica è evidente che bisogna indietreggiare; ma fino a quando?!
Risposta: premesso che come è stato detto, la guerra sta al capitalismo come la maternità sta alla madre; la guerra, questa guerra, l’hanno iniziata i capitalisti, noi comunisti una volta scoppiata, malgrado la nostra lotta per la pace, dobbiamo cercare di trasformare, la guerra imperialista in guerra rivoluzionaria.
Se i due gruppi concorrenti non hanno ancora concluso la guerra che hanno comunque volontariamente iniziato o contribuito ad iniziare, non è detto che a pagarne le spese debba essere il popolo sovietico, pertanto se per ragioni geografiche le armate capitaliste contrastanti hanno perduto il contato provvedano a riprenderlo, facciano quello che vogliono, ma noi sovietici terremo duro sulla linea che diciamo noi: Leningrado-Mosca-Stalingrado-Voronez.
Se i tedeschi attraverso l’Elbrus arrivano in India, cuore dell’impero inglese, pensino gli inglesi a difendere il loro impero. Comunque l’URSS mette in campo milioni di partigiani per rendere meno facile la vita all’invasore anzi per rendergliela più difficile possibile, ma nella lotta contro il nazifascismo ognuno deve mettere del suo, sia ben chiaro.
A questo punto ricordo che i giapponesi alleati della Germania e dell’Italia, premevano sulla Cina e indiani filo giapponesi come Ciandra Bose, minavano l’integrità dell’impero inglese in India.
Se gli sviluppi della guerra saranno favorevoli ai tedeschi, il pericolo di un immenso blocco euroasiatico si farebbe più concreto e, la sua realizzazione escluderebbe dai propri mercati, dalle materie prime qualunque influenza del capitalismo statunitense già minacciato dalla concorrenza germanica anche sui mercati del Sudamerica.
A distanza di tempo, di anni, mi capita tra le mani il volume Rapporto al Duce, a cura di G.B. Guerri – tascabile Bompiani – giugno 1978.
Contiene tra l’altro il testo stenografico inedito dei colloqui tra i federali e Mussolini nel 1942.
Nel capitolo “Nudi alla meta”, a pag. 350, si legge un discorso che il Duce fece il 3 gennaio 1943 in occasione dell’insediamento del Direttorio nazionale di nuova costituzione.
Tra l’altro rispondendo alla sua domanda: «Come avvenne che la battaglia di El Alamein non fu conclusiva?», Mussolini risponde: «Perché mancò l’altro braccio della tenaglia!». E prosegue: «Bisognava che dal Caucaso fossero sboccate le truppe germaniche… Bisognava arrivare a Batum; mancata questa manovra di ampio respiro strategico, è chiaro, che la battaglia doveva finire come è finita». A pag.351 aggiunge: «Per me è stato sempre più importante occupare l’Egitto che occupare l’Inghilterra. Quando si è occupato l’Ighilterra non si è risolto il problema, ma quando si fosse occupata quella cerniera dei tre continenti che è l’Egitto, scendendo verso il mare Indiano e prendendo contatto con i giapponesi noi avremmo spezzato la spina dorsale all’ imperialismo britannico».
La lettura di questi passi richiama quanto da me scritto che mi fa apportare una variazione ed un’aggiunta, la variazione sta nel monte che menziono, cioè non Elbrus ma Elburz e l’aggiunta è la seguente:
Certamente l’obiettivo dello stato maggiore tedesco era di mantenere la linea Leningrado-Mosca-Stalingrado-Voronez, raggiungere e superare l’Elburz, la zona petrolifera della Georgia, superare con ogni mezzo politico-militare la Turchia, prendere tra due fuochi gli inglesi in Egitto e dare alla guerra in Africa un nuovo corso. La resistenza dei sovietici sulla suddetta linea e il relativo contrasto della marcia tedesca verso l’Egitto, potrebbe indicare che il soviet non poteva fare che quello che ha fatto per obbligare gli USA all’intervento bisognava che i due nemici concorrenti si trovassero di nuovo a contatto.
Come avevamo ipotizzato ai compagni. Il che significa che non eravamo tanto lontani dalla verità, grazie alle teorie dei testi comunisti.
Escluso dal grande mercato euroasiatico, il gigante americano cadrebbe in crisi mortale, dato il suo enorme apparato produttivo e quindi dovrà entrare in lizza a sua volta per salvare i suoi vitali interessi.
Concludendo sostenemmo che prima o poi gli USA avrebbero gettato il loro peso sulla bilancia e avrebbero (sia pure non con la Velocità, come i nostri cuori avrebbero voluto) aperto un secondo fronte che avrebbe certamente dato nuovo corso alle operazioni belliche, comunque i compagni tenessero in alto i cuori e si preparassero a dare il loro contributo quando il fascismo avrebbe morso la polvere.
Quando sotto l’influsso delle tremende notizie che ci venivano dall’apparato informativo del regime (stampa, EIAR, ecc.), circa lo sviluppo delle operazioni aggressive all’URSS, per sostenere il morale dei lavoratori antifascisti organizzati o no, decidemmo di riordinare le nostre idee, cos)ì come le ho qui esposte, non nego che eravamo perplessi ed esitanti, ma fummo obbligati ad andare avanti con quella interpretazione che sentivamo piuttosto ottimista, ma che non mancava di certe considerazioni che pensammo fossero logiche. Rimane il fatto che di fronte alle nostre previsioni, i compagni rialzarono il morale convinti che il tempo e la giusta politica dell’URSS ci avrebbe dato ragione.
A trent’anni di distanza, oggi è possibile leggere che il celebre storico militare inglese Basil Henry Hart, nel suo volume “Storia di una sconfitta” a pago 522, scrive: «La ragione più autentica dei rinvii, delle esitazioni, e infine della rinuncia definitiva di Hitler ad invadere la Gran Bretagna, non fu militare, ma politica; sostanzialmente conservatore Hitler non volle affatto il crollo del sistema imperialistico mondiale ma la sua riorganizzazione in funzione degli interessi tedeschi, nonostante le apparenze nutriva ammirazione, la considerava necessaria e apportatrice di civiltà; la paragonava alla Chiesa cattolica dicendo che entrambi erano essenziali per la stabilità del mondo, insomma voleva farsi della Gran Bretagna, una alleata “ Naturalmente contro il comunismo.
Si tenta una adesione ……volontaria
Verso la fine dell’anno 1941, alcune centinaia di uomini che a suo tempo hanno svolto il loro servizio di leva nella marina militare sono convocati al circolo rionale fascista “28 ottobre” sito in Corso Carlo Alberto di Ancona. Veniamo a sapere che da parte del partito fascista si intende promuovere una campagna tendente a far credere che gli italiani sono d’accordo col regime fino al punto che gli stessi premono per arruolarsi “volontari” nella milizia militare marittima (Milmart).
La nostra organizzazione decide di ostacolare l’operazione fascista invitando i convocati a non aderire all’ iniziativa. Un gruppo di compagni scelti tra coloro che sono stati invitati al circolo fascista, dovranno presentarsi tra i primi dando l’esempio con il loro rifiuto a firmare la domanda d’ingaggio. Si tratta di trovare scuse plausibili, di diverso tono, ma tutte tendenti a non farsi ingabbiare, scuse a consigliare a coloro in attesa di essere ricevuti in ufficio.
Tra i primi a presentarsi c’è il compagno Ruggero Giannini, poi è la volta del compagno Atlantico Pugnaloni, poi quella del compagno Vivani Francesco. Tutte e tre oppongono un netto rifiuto, sia pure per motivi diversi. L’atteggiamento dei compagni manda in bestia i gerarchi fascisti che tra urla e minacce fanno entrare in scena un maresciallo dei carabinieri che conduce i tre compagni in caserma.
Mentre altri compagni tra la folla dei “richiamati”incitano i presenti a non farsi impressionare dai fascisti, l’organizzazione invia il compagno prof. Ermenegildo Catalini dal Colonnello Ravenna, comandante della legione CC., perché intervenga presso il prepotente un maresciallo a far liberare i “fermati” abusivamente. Poco dopo infatti i tre compagni vengono rilasciati. In quella occasione prendemmo con-tatti con altri giovani antifascisti della provincia.
La guerra totale e le piccole cose
L’8 dicembre 1941 il Giappone attacca proditoriamente l’isola USA di Pearl Harbour ed ottiene una serie di successi riuscendo ad occupare militarmente nume-rose posizioni americane nel Pacifico. Gli USA contrattaccando e ormai la guerra ha assunto una dimensione generale.
Sul piano organizzativo non vi sono fatti incresciosi da segnalare all’infuori dell’arresto al Cantiere Navale di due giovani operai membri dell’organizzazione giovanile.
Essi sono Marino Grimani e Alfredo Lodovichetti che con l’accusa di sabotaggio deferiti al Tribunale militare e tradotti al carcere di Bologna. L’organizzazione provvede alla loro difesa dando l’incarico all’avvocato Carmine Mancinelli di Imola (Bologna). I due giovani verranno condannati a 14 mesi di carcere.
Nel gennaio 1943, una dipendente dell’Ente ItalianoAudizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) viene sorpresa con una copia del periodico della nostra associazione “La voce del lavoro”. Il Direttore del suo ufficio la denuncia all’OVRA che sottopone la ragazza ad uno stringente interrogatorio. La Sorghi, tale è il suo cognome, dichiara di aver ricevuto il foglio incriminato dal compagno Rolando Pellegrini, autista dell’E.I.A.R. il quale messo sotto “torchiatura” fa il nome del suo compagno di gruppo, Libero Regni, che viene a sua volta arrestato e rinchiuso al carcere giudiziario e sottoposto a “grande sorveglianza”.
È evidente che siamo di fronte ad un arresto a “catena” che deve essere assolutamente “spezzata”.
Il Regni si difende asserendo che rinvenuto il foglio ciclostilato in Corso Mazzini, per terra, lo consegnò al Pellegrini senza leggerlo, pensando che si trattasse di un foglio pubblicitario. Il compagno Libero Regni ha un carattere tenace, è legato all’organizzazione comunista fin dal 1925, fanno parte del suo gruppo il fratello Emi lio, Felici Golia, Gambedotti; egli certo terrà duro, ma bisogna dargli una possibilità di salvezza nel caso non potesse resistere alle pesanti “premure” dell ‘OVRA.
Per fermare gli arresti a catena non c’è che da fare il vuoto intorno all’ ultimo arrestato.
Abbiamo due compagni tra il personale di custodia del carcere, così come li abbiamo tra i detenuti. Tra questi ultimi vi è il compagno Riziero Di Chiara (detenuto per aver minacciato il Procuratore del Re) ed è tramite lui, già conosciuto dal Regni, che si fa giungere a questi le decisioni dell’organizzazione: Regni deve mantenere la dichiarazione fatta, nel caso di intervento poliziesco “pesante”, affermare di aver avuto quel “manifestino” da Raffaele Maderloni.
Eravamo arrivati a questa decisione dopo aver avuto un colloquio con i compagni Giannini e Cappelletti e costatato che non erano in grado di entrare nella illegalità.
Quindi toccò a me iniziare la vita clandestina,cioè sparire dalla circolazione. Il compagno Regni, Il compagno Regni, mantenendo la posizione presa, un mese dopo partiva per il “confino” ed io tornai…. A casa nella semiclandestinità, abbandonando il “covo”, cioè a casa di Adolfo Armeni.
Nella decisione presa non c’era nulla di straordinario. Bisognava tenere conto che questo episodio avveniva nel gennaio 1943, in un’epoca in cui le sorti della guerra in atto volgevano in senso sfavorevolissimo al nazifascismo e si poteva facilmente profetizzare la sua sconfitta. Per fare il “vuoto” intorno a Regni non vi era altro da fare ma soprattutto facevo affidamento sul coraggio del compagno e, da non trascurare, l’aspetto psicologico, nel sentire la presenza dell’organizzazione comunista, anche nella sua posizione di “detenuto a grande sorveglianza” nel carcere di S. Palazia.
Alla ricerca di… una… mente dirigente
Dopo l’episodio dell’arresto del compagno Libero Regni, i compagni responsabili dell’organizzazione decidono di inviarmi a Roma dove con l’aiuto del compagno Ermenegildo Catalini, introdotto in certi ambienti antifascisti della capitale, avrei dovuto cercare un “contatto” con il “centro” del partito di cui ormai sentivamo la presenza e la necessità di incontrare.
In quel febbraio 1943, a Roma, ebbi degli “incontri” prima con il prof. Monferini, insegnante in un liceo romano, poi con l’avvocato Fiore, abitante in via Cavour al n. 2 ed infine un incontro notturno con un paio di studenti universitari romani, dai quali ricevo del materiale ciclostilato,
Ma sono tutti gruppi, così almeno mi sembra, sorti spontaneamente in Italia, diciamo un po’ come noi, e niente più.
Durante i tre giorni di permanenza a Roma, tramite Catalini, fui ospite di un dirigente nazionale del Movimento Federalista Europeo, che abitava in via Firenze. In questo appartamento, presente anche il compagno Catalini, si svolsero alcune conversazioni con alcuni dirigenti nazionali di questo Movimento” tra questi dirigenti trovo un certo Altiero Spinelli, che dovrebbe essere stato all’isola di Ponza, i cui discorsi sono impregnati di anticomunismo.
Malgrado ciò, le conversazioni portano ad un accordo per l’organizzazione. nella provincia di Ancona, di una radio trasmittente, che sarà fornita dal Movimento, e dovrà servire per lanciare appelli contro la guerra fascista. Ma il disegno non potrà essere realizzato per gli arresti avvenuti il 30 maggio 1943, di cui scriverò più avanti, arresti che coinvolsero anche il compagno Catalini, che teneva il contatto tra la nostra organizzazione e la direzione del Movimento Federalista Europeo.
La stampa clandestina e il “centro”
Durante il mese di gennaio 1943, da alcune cellule di base, pervennero ai compagni dirigenti alcune segnalazioni circa proposte di adesione al P.C.I., avanzate da par-te di elementi che si dichiaravano rappresentanti del partito e a dimostrazione di quanto affermavamo, mostravano una copia, in formato ridotto del giornale comunista “l’Unità” e un ciclostilato intitolato “Il quaderno del Lavoratore”. Gli elementi che erano stati avvicinati, tutti compagni, già membri del P.C.I. dalla sua fondazione, e da molti anni membri della nostra organizzazione, giustamente si meravigliavano di questi approcci e chiedevano spiegazioni.
Intanto la notizia ci riempie di gioia. Era ora che l’organizzazione centrale si facesse viva. L’ ultima apparizione di un rappresentante di essa era avvenuta nel 1932, da allora il contatto non era stato più possibile a causa, come già detto, della negativa posizione presa dal compagno Luigi Mercanti, come da testimonianza al carcere romano di “Regina Coeli” di Premoli e confermata a Ventotene dal compagno Rutilio Reali di Castelfiorentino (Empoli). Probabilmente il centro aveva desistito dall’inviare ad Ancona altri funzionari o “corrieri”. La verità potrebbe anche essere un’altra, cioè che ci sia stata una sosta circa i tentativi di allacciare dall’esterno i rapporti con l’interno dell’Italia.
La presenza in Ancona di esemplari de “l’Unità” clandestina significava che qualche cosa di nuovo circa i rapporti con un “centro” poteva verificarsi e, a priori, era da escludere una provocazione della polizia, in quanto da indagini esperite dai compagni dirigenti risulta che a dirigere gli approcci era un compagno, cioè Mario A. Zingaretti, di professione sarto con laboratorio in via Mamiani di Ancona.
In breve ecco una biografia del compagno: nato ad Arcevia (Ancona), il5 settembre 1980, nel 1909 aderì) al P.S.I. Nel 1920 divenne segretario della Camera, del Lavoro di Ancona. Nel 1921 partecipa al Congresso di Livorno aderendo al P.C.I. Nell’ottobre 1922 viene ferocemente bastonato dai fascisti. Nel 1923 viene arrestato con altri e accusato di complotto comunista, ma viene assolto. Nel 1924 si trasferisce a Roma e nel 1926 avviato per cinque anni all’isola di Lipari. Nel 1931, nuovamente arrestato viene avviato ancora per cinque anni al confino dell’Isola di Ponza. Durante questo periodo di permanenza a Ponza ottiene il permesso di essere raggiunto dalla moglie e dal figlio Lenin (ribattezzato poi col nome di Leone). Conforme a quanto disposto dalla “Carta di permanenza”, cioè l’elenco delle norme a cui deve attenersi il confinato, ottiene di potersi dare a “stabile lavoro” di sarto. Il suo mestiere, nel quale è abilissimo. Avendo con sé la famiglia ottiene pure di affittare un appartamento privato e quindi non fare vita collettiva con gli altri confinati.
È molto importante il fatto che egli non partecipa a nessuna delle agitazioni e proteste organizzate dai confinati in generale e dai comunisti in particolare, contro le prepotenze della milizia fascista, contro i metodi della direzione della colonia, contro la pretesa dei poliziotti che i confinati al ricevimento della “mazzetta” (cioè le 5 lire di sussidio giornaliero) salutino alla fascista. Egli giustifica questa sua posizione con l’affermare che non condivide la “linea del partito” e si dichiara “trotzkista”.
Quando con i compagni Grilli e Carelli passai “in transito” per il carcere di Ponza, il 5 maggio 1935, centinaia di compagni erano stati trasferiti dall’ isola al carcere napoletano “Poggioreale'”, tutti denunciati alla magistratura per contravvenzione alla “Carta di permanenza” per i motivi che illustro in altra parte di queste memorie. Ma non tutti i confinati erano stati arrestati e portati ammanettati à Napoli, qualcuno era rimasto perché non aveva voluto partecipare alla difesa degli interessi personali e collettivi, come per altri compagni destinati a curare gli interessi dei confinati, e tra questi, fra i rimasti c’era anche il compagno Zingaretti, un altro marchigiano e altri cosiddetti “manciuriani”. Lontana da me l’idea di formulare un giudizio politico sul comportamento dei compagni, perché reputo giusto che ciascuno nella lotta si regoli secondo la propria forza. Per agire così Zingaretti deve aver avuto le sue buone ragioni.
Sono stato obbligato a scrivere quanto precede perché serve a chiarire quanto scriverò appresso. Nel 1938 ero stato più volte a visitare il compagno Zingaretti nel suo laboratorio di sarto, così, per chiacchierare, e in più occasioni parlando di politica, rivelava il suo modo di pensare circa la situazione nell’URSS, su Stalin e non nascondeva le sue simpatie per Trotskij. Per la verità non riuscivo a capirlo, per i lavoratori italiani Stalin, l’ho già detto, era un mito, di cui non potevamo fare a meno.
Ma Zingaretti non desisteva e mi consigliò la lettura di un libro del teorico del trotzkismo, Rosenberg, mi sembra, la cui lettura non poteva modificare il mio modo di pensare per un insieme di ragioni; esagerando dirò che nessuno mai ha distrutto il dio di cui non può fare a meno per poter sperare sull’avvenire della propria vita.
Durante questi colloqui, che generalmente riferivo ai compagni del Comitato direttivo (così come raccontavo tutto ciò che poteva accadermi, di qualsiasi natura fosse), più volte avevo accennato a Zingaretti, alla necessità, in rapporto all’evoluzione generale della politica, ai problemi della guerra, alla miseria della classe operaia e degli artigiani, di riorganizzarsi per affrontare, al momento giusto, la situazione. Malgrado la sua opinione sulla politica di Stalin, ecc. avevamo di Zingaretti un alto concetto e quindi cercavamo la sua collaborazione anche se, bisogna dirlo, non aveva, durante il periodo passato al confino, provveduto a dare una “rinfrescata” alla sua cultura generale e non dava “un’occhiata”in particolare all’economia politica elemento necessario per un sindacalista. Era un vecchio compagno ed eravamo disposti a capirlo.
I compagni responsabili si riunirono ed esaminata la situazione decisero di mandarmi a chiedere spiegazioni dal compagno Zingaretti. Eravamo in possesso di elementi tali che non gli consentirono di negare (poteva anche farlo, non potevo obbligarlo, ma non lo fece), pertanto mi disse che aveva ricevuto la visita di un compagno che a nome del centro gli aveva proposto di provvedere alla ricostituzione del partito comunista italiano. Zingaretti aveva accettato il mandato e alcune copie del materiale che aveva messo in giro. Meravigliato gli chiesi come mai prima non aveva mai voluto impegnarsi, adesso questa decisione. Poi gli chiesi se aveva accennato al compagno del centro che già vi era un’organizzazione. Rispose di sì, e gli aveva aggiunto che eravamo dei giovani.
Qui mi corre l’obbligo di una chiarificazione in merito ai giovani dichiarando la nostra età, quella dei dirigenti: Gino Grilli, anni 37; Dino Augusto Carelli, anni 39; Vittorio Marinelli, anni 35; Adelmo Pianelli, anni 32; Ruggero Giannini, anni 35; Gherardo Corinaldesi, anni 36; Raffaele Maderloni, anni 37; Ermenegildo Catalini, anni 47.
È così evidente che non eravamo ragazzi e quasi tutti, cioè Grilli, Carelli, Pianelli, Giannini ed io avevamo già pagato con il carcere, il confino, l’ammonizione l’attaccamento alla classe operaia e al partito.
Gli feci rilevare che già tutti i vecchi compagni erano organizzati e lo provava il fatto che non appena aveva tentato di avvicinarli si era trovato a cose già fatte e che la sua iniziativa creava soltanto confusione nelle idee dei compagni. Rispose che non intendeva desistere dall’incarico ricevuto. Sulla questione Zingaretti dovrà tornare più tardi.
Sempre nel gennaio 1943, di fronte allo sviluppo della situazione politica e militare e quindi alle maggiori esigenze organizzative e propagandistiche, il comitato diretti vo prese in esame l’opportunità di dar vita ad una pubblicazione con caratteri tipografici e in questa decisione c’entra pure la posizione negativa del compagno Zingaretti che si ostina a fare da solo. Per il reperimento del materiale tipografico, tramite il compagno Ermenegildo Catalini, viene incaricato il compagno Spartaco Ballarini il quale in poco tempo da una ditta di Bologna, riesce a farsi consegnare un certo quantitativo di materiale occorrente.
Anche questo è il segno dei tempi. Tutti questi fenomeni positivi sono determinati da quanto di glorioso sta facendo l’Armata Rossa all’est.
La nuova testata “IL MAGLIO” era stata già approntata dal compagno Oreste Dubbini, un valente operaio del ramo, e tutto lasciava credere, che in possesso di una vecchia pedalina, al più presto il vecchio ciclostile che da molto tempo stampava (se così si può dire) “La Voce del Lavoro”, sarebbe stato messo a riposo e sostituito dalla nuova pubblicazione. Invece, a causa degli arresti del 30 maggio 1943, di cui scriverò tra poco; anche il compagno Ballarini a riposarsi al carcere giudiziario di Ancona.
Ma il 25 luglio è vicino e i successivi avvenimenti permetteranno all’organizzazione di utilizzare i caratteri tipografici per testate più significative come “L’Aurora”, poi “Bandiera rossa” e “Il Combattente” per il periodo della lotta partigiana.
Pane e pace
Siamo nel marzo 1943, lo scontento è sempre più profondo tra la popolazione in generale e tra la classe operaia in particolare, per un complesso di cause tra cui il durare della guerra e le privazioni. Le sconfitte sul mare, nell’aria, in Grecia, in Albania, in Africa e nell’Unione Sovietica, venivano attribuite alla impopolarità della guerra, alla cattiva alimentazione dei combattenti, al pessimo armamento di cui i soldati erano dotati, al tradimento annidato nella stessa classe dirigente fascista e nei Comandi dello Stato Maggiore. La perdita dei loro cari, morti, dispersi, prigionieri su tutti i fronti bellici, la cattiva amministrazione della cosa pubblica, il pullulare degli speculatori, il pericolo dell’invasione straniera (comunque sempre da pa-ventare per le sue conseguenze) con l’apertura del secondo fronte da parte degli inglesi e americani, le notizie circa le prepotenze fatte subire dai tedeschi agli italiani al fronte, fa crescere ogni giorno la tensione tra i lavoratori.
In questa situazione giunge la notizia circa scioperi di operai avvenuti in alcuni stabilimenti del nord.
Da considerare che la guerra obbligava ad un regime di tesseramento di tutti i generi, da quelli a largo consumo popolare, alle merci più disparate. Per i lavoratori il tesseramento non è una cosa soltanto del periodo di guerra, per la classe operaia la limitazione dei consumi vige da secoli, poiché la limitazione è sempre imposta dalla stretta capacità di acquisto del salario. Nel periodo di guerra, caso mai, la situazione è peggiore, perché la generale restrizione dei consumi fa aumentare la disoccupazione, mentre i richiami alle armi degli uomini validi vengono ricompensati con miseri sussidi. E con il ristagno generale degli affari, che comporta minor circolazione della moneta, la miseria aumenta e allora accade che per comperarsi il pane i più poveri, i disoccupati, i figli e le donne dei richiamati sono costretti spesso a vendere ai ricchi i “buoni” per l’acquisto dello zucchero, della carne, dell’olio o i “punti” per l’acquisto dei filati, stoffe, ecc. È ovvio che il tesseramento e con esso la fame rimane una prova di patriottismo riservata alla classe operaia. Gli “altri”, i gerarchi, quelli della” greppia”, invece nella generale sofferenza gavazzano in attesa della… vittoria.
Questi argomenti sono sempre trattati nel nostro foglio “La voce del lavoro”. In quei giorni si sparse la voce che alle “Rupi di Gallina”, luogo riservato per gettare in mare i rifiuti della città, era stato rinvenuto un discreto quantitativo di generi alimentari avariati che, dicevano le voci, erano merci andate a male negli ammassi del regime.
La voce generò enorme malcontento anche perché queste voci erano corse anche in altre occasioni. Questa volta fu la classica goccia che fece traboccare il vaso.
Da oltre 20 anni il fascismo dominava con il terrore, ora però la situazione era cambiata. L’andamento della guerra, malgrado il valore dei nostri soldati, lasciava supporre la sconfitta e la caduta del fascismo all’indirizzo del quale ormai le critiche venivano formulate senza reticenza anche da iscritti al partito al potere e che già incominciavano a declinare ogni responsabilità derivante dalla guerra. In questa situazione come si sarebbero comportate le autorità fasciste di fronte ad una dimostrazione di piazza? Questo argomento venne affrontato dai compagni responsabili e si concluse di condurre l’azione senza obiettivi prefissati. Sarebbe andata avanti in rapporto alla reazione che si sarebbe incontrata.
Il giorno 11 aprile 1943, provenienti dai rioni popolari di Capodimonte, Guasco, Porto, S. Pietro, Borghetto, Piano S. Lazzaro, giungono in Piazza Umberto I° (oggi Piazza della Repubblica) numerose popolane accompagnate da numerosi bambini condotti a mano o tenuti sulle braccia. Sono quasi tutte congiunte di compagni organizzati, il loro numero si aggira complessivamente sulle centocinquanta persone.
Tutta l’organizzazione è mobilitata, i giovani comunisti devono trovarsi lungo i marciapiedi del corso V. Emanuele (oggi Garibaldi),il compito degli uomini è quello di incoraggiare con la loro presenza le manifestanti sin alla partenza da piazza Umberto che lungo il corso V. Emanuele fino dove sarebbe stato possibile far giungere il corteo.
Bisogna crederci se diciamo che eravamo molto perplessi. Pesavano su di noi 20 anni di dittatura, non eravamo abituati a manifestazioni del genere, sentivamo anche il delle nostre responsabilità, poiché si trattava anche di non far emergere l’aspetto propriamente politico, cioè comunista della manifestazione che doveva svolgersi al grido “Pace e pane”.
Dopo qualche istante e qualche esitazione, le più animose formano una testa di corteo, ecco i loro nomi: Teresa Bisognini, Adriana Ciasca (mia cognata), Nella Formica (mia sorella), Marina Mercanti; Codelia Mercanti, Guglielma Nicolelti, Maria Ambrosini, Maria Scaradozzi, Nella Pignocchi, Fedora Malacari.
Il ghiaccio è rotto, tra il generale sbalordimento il corteo si snoda compatto lungo il corso. Incoraggiamenti partono dai marciapiedi dove molti solo allora si rendono conto del perché di questo appuntamento alle ore 16 di quella giornata. Ora si rendono conto di ciò che devono fare. Si crea un’atmosfera carica di elettricità. Gli ignari si chiedono l’un con l’altro che cosa sta succedendo, nel corteo gridano: “Pace – pane!”.
Il corteo intanto raggiunge piazza Roma e qui viene affrontato da alcuni agenti di pubblica sicurezza in borghese, che privi di ordini non sanno che posizione prendere, non sanno se il corteo è stato ordinato dal partito fascista, se è autorizzato dalle autorità, o se invece è un atto spontaneo. Gli agenti chiedono spiegazioni ma le donne urlano che sono stanche di fare la fame e rivogliono i loro uomini che so-no sotto le armi.
Incoraggiate dalla presenza di numerosi compagni che le attorniano come se fossero dei curiosi, le donne riprendono il cammino verso Piazza Cavour emettendo sempre il grido “Pane-pace”.
Forse esse stesse sono un po’ meravigliate che ancora non sia successo nulla di male.
Si dirigono verso il palazzo dove ha sede la federazione fascista che però non possono raggiungere perché questa volta è il “federale” in persona accompagnato da un folto gruppo di gerarchi che va loro incontro. Il “federale” invita le manifestanti a tornare alle loro case assicurando che si sarebbe provveduto per i generi alimentari e che avrebbe fatto fare una inchiesta per i viveri avariati gettati alle “Rupi di Gallina” e in quanto alla guerra, bisognava avere pazienza.
Il fatto che non si fosse fatta intervenire la polizia o la milizia per far sciogliere la manifestazione e che non si procedeva contro coloro che dimostravano, con le paro-le maggior responsabilità, sembrò darci la misura della preoccupazione delle autorità di non provocare ancor più la collera popolare.
La manifestazione andava raffreddandosi e probabilmente si sarebbe sciolta senza l’intemperanza di un fascista, sembra un certo avvocato Berti, il quale certamente a corto di argomenti, affronta una dimostrante con la pratica del fascista e prende a schiaffi una donna, Fedora Malacari, in stato interessante (il giorno dopo darà alla luce un figlio).
L’atto vile provoca immediata reazione e donne assaltano il fascista colpendolo con pugni e graffi fino a quando non viene messo in salvo da alcuni camerati. Il fatto del Berti è sfavorevolmente commentato anche dalle persone che nel frattempo si sono ammassate intorno al gruppo e ciò alimenta la collera delle manifestanti che decidono di continuare la dimostrazione dal Prefetto, e pertanto si dirigono verso Piazza Plebiscito dove è situato il Palazzo del Governo.
Ma la piazza è presieduta dalle forze di polizia che bloccano le vie d’accesso alla piazza stessa, il che provoca, in via della Beccheria, uno scontro tra le donne e la polizia che vengono alle mani per tentare di strappare le “fermate” da quelle dei poliziotti: ed è ancora verso la Questura che si rivolge la dimostrazione delle donne allo scopo di far rilasciare le compagne arrestate tra le quali si trova mia sorella Nella.
In quell’ora sono numerosi i soldati che escono in libera uscita dalla Caserma Villarey e scendendo in via Marsala vengono a trovarsi in mezzo alle dimostranti e anche loro pronunciano frasi incoraggianti all’indirizzo delle nostre donne. Poco dopo, forse ritenendo che esaudendo le richieste delle dimostranti, che vogliono li-bere le loro compagne, le “fermate” vengono rilasciate e accolte da grida di gioia vengono accompagnate a casa.
La manifestazione viene considerata positiva e aveva anche dato un segno del pessimismo che si respirava in certi ambienti.
Ancora una volta alla “macchia”
La notte del 30 maggio 1943, la polizia procede all’arresto di una cinquantina di cittadini e li associa al carcere giudiziario. Naturalmente sono stati anche a casa mia per prendermi, ma dati i tempi e l’attività che svolgevo, da qualche tempo vivevo semi-clandestino; cioè pensavo che se avessero voluto arrestarmi lo avrebbero fatto, come sempre, di notte, e pertanto io dormivo il casa di mia suocera Maria Parmiani Ciasca, una coraggiosa ed intelligente romagnola, che aveva l’appartamento nel cuore del vecchio popolare rione Porto, con due uscite, che davano in un meandro di vicoletti ( una specie di kasba algerina) dove la polizia non tanto facilmente avrebbe potuto raggiungermi.
In piena notte, cinque o sei poliziotti, fattasi aprire la porta di casa mia, rovistano ovunque, domandano dove ero, interrogano mia moglie, mio figlio Roberto di solo otto anni, poi una parte se ne andò e una parte rimase ad attendermi. Poco dopo l’alba, mia moglie, con la scusa di andare a prendere un po’ di lattenel vicino bar, mi raggiunge e mi mette sull’avviso. C’è da attendersi una visita anche a casa dei miei suoceri, dove appunto mi trovo, in vicolo del Padrone al n. 8.
Alcuni compagni vengono messi di guardia alle entrate dei vicoli del rione e infatti ad una certa ora del mattino il compagno Mario Turchetti, un operaio del Cantiere Navale, mi avverte che gli agenti sono entrati nel rione dalla parte del vicolo dell’Arsenale e stanno avvicinandosi all’abitazione dove sono nascosto.
Esco da una delle porte, mi trovo in via Saffi, la città è silenziosa, per le strade nessuno, forse perché è domenica, forse per quello che sta accadendo, raggiungo piazza Pannunzio; salgo al primo piano di un palazzo dove abita il compagno Oreste Dubbini, alla moglie che apre la porta e che mi comunica che il marito è assente per lavoro non dico nulla e tomo in strada. In quel punto è possibile inserirsi in un dedalo di vigoletti, che pochi anconetani conoscono, uno di questi si chiama appunto: vicolo della Storta, e da qui raggiungo l’abitazione della famiglia Bedini, dove sono sicuro di trovare assistenza, anche se temporanea.
Attraverso uno dei giovani Bedini, mi metto in contatto con i compagni per essere informato sulla situazione. Ecco la relazione: qualche tempo prima, in rapporto a quanto andava accadendo nel mondo e in particolare sul fronte bellico dell’ est, qualcuno si era svegliato dal ventennale letargo e si erano stabiliti contatti tra alcuni elementi di diversa tendenza politica ma tutti antifascisti, cos) rappresentati: Avv. Oddo Marinelli, Movimento Giustizia e Libertà; sig. Plinio Canonici, Partito Popolare Cattolico; sig. Tertuliano Mengarelli, Partito Socialista Italiano; sig. Armando Andreoni, Partito Comunista Italiano (gruppo Zingaretti).
Queste quattro correnti politiche si erano incontrate ed avevano creato un movimento denominato “Concentrazione Antifascista”.
Malgrado che la nostra organizzazione avesse una diffusione capillare, di quanto si andava formando, non era giunta alcuna notizia, forse perché, nella sostanza, l’attività si limitava ad alcuni incontri al vertice e alla cura delle loro nascenti organizzazioni, senza alcuna manifestazione che non ci sarebbe sfuggita.
Nessuno ne ha più parlato, ma sembra che come prima manifestazione politica da organizzare fosse quella di una passeggiata per il centrale corso Vittorio Emanuele che avrebbe dovuto aver luogo il mattino di domenica 30 maggio 1943. I dimostranti “sui generis” avrebbero dovuto passeggiare lungo i marciapiedi del corso camminando non incolonnati, in corteo, ma in ordine sparso e osservando il più rigoroso silenzio. Non è da escludere che ci fosse un certo rapporto ideale con la manifestazione delle donne e dei bambini dell’11 aprile 1943, che aveva destato un grande scalpore (e forse anche un po’ di preoccupazione in certi ambienti moderati) nella provincia e nella regione.
Se quella “passeggiata” era stata veramente ideata (ma non è da escludere) o no, non ho mai pensato di accertarlo, se avessi avuto il tempo, se non fossi stato perseguitato da quanto stava accadendo con un ritmo impressionante, avrei cercato di saperlo, e lo avrei fatto soltanto per una naturale curiosità. Mi sembrava un modo, nuovo per dimostrare, per quanto bisognava considerare buona ogni forma di lotta, purché ci si muovesse contro il fascismo.
Comunque questa dimostrazione non ebbe possibilità di essere effettuata perché durante la notte del 30 maggio, la polizia effettuò una serie di “fermi” di diversi cittadini di Ancona, Falconara e altre località.
Guarda caso avevano arrestato i quattro esponenti delle quattro, diciamo così, correnti politiche, già indicati e inoltre i seguenti: Bruno, Fattori, comunista; Aldo Fiorini, socialista; Piero Pergoli, repubblicano; Attilio Giansanti; Plinio Canonici, popolare; Paolo Spacca; Guido Re; Renato Gigli, repubblicano; Idilio Pignocchi, socialista democratico; Mario Zingaretti, comunista; Goffredo Baldelli, repubblicano; Wilfredo Duca, repubblicano; Luigi Rossini, popolare; Vittorio Zanetti; Silvio Franchini, comunista; Elvezio Grati (Zingaretti), comunista; Gino Ludovichetti (Zingaretti), comunista; Sirio Piermattei (Zingaretti), comunista; Ernesto Baldoni; Attilio Di Martini; Ruggero Giannini, comunista; Ezio Giannini, comunista; Mario Marsigliani, comunista; Atlantico Pugnaloni; Libero Vannucci, comunista; Volturno Pugnaloni, comunista; Colombo Saracini, comunista; Adrio Andreatini, comunista; Oreste Amico, comunista; Spartaco Ballarini, comunista; Ersilio Bravi, comunista; Ermenegildo Catalini, comunista; Luigi Acrosso, comunista; Claudio Di Chiara, comunista; Gino Ferretti, comunista; Alfonso Cesaroni, comunista.
Verso le otto del mattino, il compagno Oreste Amico, con il quale avevo un appuntamento per andare a fare un bagno, non vedendomi arrivare in piazza del Comune ebbe l’idea di salire le scale di vicolo dei Tribunali per recarsi a casa mia. Non fece in tempo a bussare alla porta che quattro robuste braccia lo immobilizzarono e poco do-po anche lui è associato a S. Palazia.
Intanto per me si trattava di uscire dalla città al più presto possibile e raggiungere la località stabilita precedentemente. Bisognava trovare un mezzo di trasporto. I pochi taxi che allora cominciavano a fare concorrenza ai “fiache” (così si chiamavano allora le “carrozzelle” ippotrainate), non erano utilizzabili perché data la situazione bellica, e il tesseramento del carburante, per fruire del taxi bisognava ottenere il permesso delle autorità.
Quindi mandato il vecchio Bedini in giro di perlustrazione per cercare il “ fiaccherista” più idoneo allo scopo, poco dopo torna per dirmi che in piazza S. Maria era pronto un “fiache” col soffietto abbassato. Sgattaiolai fuori del vicolo, m’infilai nella carrozzella e il Bedini, che volle accompagnarmi, disse al vetturino: «Va piano come se accompagnassi un funerale, e portaci alle Tavernelle!» (dove appunto è situato il cimitero della città di Ancona).
Attraversammo la città senza incidenti, si vedevano poche persone in giro. Giunti, salutai il Bedini, entrai nel cimitero, attraversandolo visitai la tomba di mia madre morta qualche mese prima, poi decisamente saltai la mura di recinzione e attraverso la campagna mi recai nella ormai vicina frazione di Passo Varano, ospite del compagno Ercole Carletti.
In quell’epoca stazionava, in questa località, un posto di guardia di carabinieri al piano terra di un fabbricato, ai margini della frazione. Al primo piano una vecchietta conoscente del Carletti, mi affittò una cameretta. Ufficialmente ero uno studente che doveva prepararsi agli esami di riparazione e che aveva bisogno di silenzio e di pace.
I pasti li facevo in una piccola osteria gestita dallo stesso compagno Carletti e da sua moglie la compagna Romagna Carletti, era situata al centro della borgata e frequentata da numerosi compagni. Ad ogni buon prò, durante il giorno mi addentravo nella campagna circostante con dei libri sotto il braccio.
Dalle notizie circa gli interrogatori, rilevo che l’atteggiamento della polizia e in particolare del capo dell’OVRA, dott. De Vincentis, che si occupa dell’inchiesta, non è duro; sì, compiono il loro servizio, ma non con quella insistenza che ha caratterizzato altre inchieste contro detenuti politici quando il fascismo andava a gonfie vele. Naturalmente tutti stanno adeguandosi alla fase di declino del regime e non è da escludere che qualcuno già pensi a creare degli addentellati per il dopo-fascismo.
Gli arresti erano stati effettuati da pochi giorni quando insieme alla notizia di un massiccio bombardamento su La Spezia, che provoca grandi e gravi danni alla nostra marina militare, giunge anche quella della resa delle isole di Pantelleria e Favignana, che certamente costituisce una “mazzata” sulla cervice dei gerarchi e dei loro servi.
Il 12 giugno 1943, gli anglo-americani occupano l’isola di Pantelleria facendo dodicimila prigionieri senza colpo ferire. Queste ed altre notizie dai fronti bellici ove combattevano gli italiani non potevano non rattristarci pensando alle condizioni miserrime in cui venivano a trovarsi milioni di italiani che questa guerra non avevano voluto, e soprattutto alle decine di migliaia di giovani operai e contadini che lasciavano la loro giovinezza nei campi di battaglia senza aver vissuto la loro vita. Ma appunto perché questo macello cessasse avevamo bisogno di continuare nella nostra azione con la speranza di evitare la calata in Italia degli eserciti anglo-americani.
Quindi più che all’inchiesta ed agli interrogatori che si andavano svolgendo in carcere, la nostra attenzione era rivolta a quanto accadeva in Sicilia, dove ormai gli Alleati portavano la guerra, anche perché ormai la sorte degli arrestati, dei latitanti, degli inquisitori, dipendeva dallo sviluppo delle operazioni belliche.
Su certi aspetti negativi di quanto accadeva nell’interrogatorio del compagno Catalini, dirò che la polizia insisteva nel cercare di sapere dove ero nascosto, di farmi sapere che non avevano nulla di importante da contestarmi e che sarebbe stato opportuno che mi presentassi volontariamente e sembrava che la polizia dicendo queste cose a certi detenuti, questo invito potesse raggiungermi. Essa cercava un certo Giuliodori, un certo Pellegrini e un uomo dai denti d’acciaio e forse sospettava che queste tre persone si identificassero con la mia stessa persona.
Ho scritto che la nostra attenzione era rivolta soprattutto agli aspetti bellici e ciò trova la sua ovvia motivazione, ma ciò non toglie che l’organizzazione dimenticasse i compagni carcerati che certo non avevano bisogno del nostro aiuto morale in quanto era altissimo, malgrado cioè piacevole senz’altro quando si è in mano del nemico, magari messi in una cella a “grande sorveglianza”, vedersi recapitare, tramite un agente di custodia o lo “scopino”, una copia del giornale clandestino, ricevere notizie dirette dai compagni dirigenti, consigli sugli orientamenti dell’inchiesta, … Tramite nostri aderenti l’organizzazione faceva arrivare ai compagni detenuti quello che loro occorreva per continuare la lotta e fra le cose che riusciva di far introdurre in carcere vi era anche l’ormai gloriosa “La Voce del Lavoro”.
E la lotta continua anche per me. Infatti sono da otto giorni nascosto nella vicina frazione di Passo di Varano. Tutto procede bene. Da qui manteniamo i rapporti con i compagni detenuti e con l’organizzazione, quando giunge il compagno Corinaldesi e mi dice che qualcuno deve avermi visto, perché un milite fascista tornando alla sua abitazione dice alla moglie: «Dal treno in transito per il Passo di Varano ho veduto il fratello di Nella!».
La moglie del milite esce a sua volta dall’ abitazione e si reca nella casa di mia sorella Nella e le dice: «Quel porco di mio marito deve aver visto tuo fratello Raffaele al Passo di Varano: tu sai come la pensa! Vedi tu il da farsi!». Mia sorella Nella avverte il compagno Candelaresi responsabile della cellula del rione di “Capodimonte” e, in breve, anch’io vengo avvertito.
Corinaldesi mi avverte che un nuovo “buco” è pronto in città, pertanto all’imbrunire, attraversando luoghi isolati, accompagnato da staffette che mi precedono, con una voluminosa pagnotta di pane sotto il braccio, discendo per le “Tavernelle”, le “Grazie”, i “Grasciari”, risalgo per la “Portaccia”, piazza del Forte e mi infilo nell’appartamento del compagno Adolfo Armeni, dove mi sono già nascosto in altre circostanze. Il giorno dopo, all’alba, un nugolo di poliziotti e carabinieri investono la piccola frazione di Passo di Varano, perquisiscono numerose abitazioni, interrogano gli abitanti compreso naturalmente il compagno Ercole Cadetti, la moglie, rovistano per ogni dove, ma ormai io sono lontano da loro.
Il compagno Armeni vive solo ed è un compagno pieno di fede e di coraggio. Nell’appartamento di sua proprietà dove svolge la sua attività di ritoccatore di fotografie, non viene mai nessuno. Da una stanza interna è possibile raggiungere rapidamente, tagliando la corda se necessario, le Rupi comunali. Abbiamo utilizzato spesso il uso appartamento in particolare per dattilografare il clichè da ciclostilare. Ricevo notizie dall’esterno tramite i compagni Armeni e Corinaldesi che a quanto pare è ancora sconosciuto alla polizia. Utilizzo il mio tempo per “La Voce del Lavoro”, l’organizzazione e l’andamento dell’inchiesta della polizia.
I compagni responsabili mi trattengono nell’ abitazione di Armeni per qualche giorno, poi insospettiti da certi movimenti avvenuti in via Cialdini da un fascista notoriamente spia, un certo Arzeni, decidono di farmi ricoverare in una abitazione sita in vicolo del Campetto, poco lontano da via Cialdini, in casa del compagno Remo Capodagli, la cui moglie trovasi in campagna e pertanto ha la casa libera. Ed è qui che finalmente mi fanno incontrare mia moglie.
Siamo agli ultimi giorni del giugno 1943 quando i compagni mi vengono a prelevare per condurmi al Borghetto di Ancona, una località distante quattro chilometri dalla città, abitata prevalentemente da antifascisti e mi conducono a casa del compagno Rolando Cinti. Questa località chiamata anche “il Borgaccio”, ha una sua fama, intanto peri suoi abitanti notoriamente non fascisti, poi per un episodio accaduto nel 1920 nel quadro della famosa rivolta dell’XI° Reggimento Bersaglieri che non intendevano partire per occupare imperialisticamente l’Albania. Si racconta che un treno pieno di “guardie regie” partito da Roma per sedare l’insurrezione, giunto all’altezza del Borghetto viene salutato da una serie di fucilate da parte degli insorti. Al che una delle guardie regie dice: «Ci hanno detto che in Ancona c’era uno scioperello! All’anima dello sciopero! Chist’è o fronte!».
Questo aneddoto lo raccontava spesso il compagno Teodoro Pavoni che nel 1943, mentre mi accadevano i fatti che sto raccontando era ricoverato nel reparto “TBC” dell’ospedale civile di Ancona con ancora pochi mesi di vita. Ho scritto quanto precede per rendere un doveroso omaggio al compagno onesto e generoso che nel 1932 al questore di Ancona seppe rivendicare la sua fede di comunista con orgoglio di combattente per la classe operaia. Compagno che può essere preso ad esempio per dimostrare qual era lo spirito dei comunisti in un periodo come quello del 1932, nel quale l’unica luce era quella interiore della nostra fede.
Una novità per i giovani: il comizio
Considerando:
- l’episodio positivo che è stato l’azione per fare il vuoto intorno al compagno Regni;
- le voci che circolavano con insistenza circa la chiamata alle armi dei giovani nati nel 1924, ancora diciannovenni, mentre erano già sotto le armi i nati nel 1923;
- l’eco degli scioperi effettuati dalle maestranze della FIAT Mirafiori di Torino il 5 marzo 1943;
- la manifestazione per il pane e la pace, effettuata da donne e bambini il l0 aprile 1943 in Ancona;
- la tensione già in atto, rinfocolata maggiormente dopo la resa delle isole di Pantelleria e Favignana;
- i bombardamenti a cui gli alleati sottoponevano la Sicilia e le voci circa un loro probabile sbarco;
- gli arresti in massa effettuati dalla polizia il 30 maggio; i dirigenti dell’organizzazione decisero di rompere gli indugi promuovendo, per la prima volta dopo venti anni, una manifestazione alla quale la maggioranza dei compagni, quasi tutti giovani, non ha mai partecipato.
I cinquanta capigruppo della numerosa cellula del Cantiere Navale vennero invitati a trovarsi nelle prime ore pomeridiane della domenica Il luglio 1943 in località Palombina Alta a 8 km. da Ancona, raggiungibile con il servizio tranviario Ancona-
Falconara. La ragione ufficiale era un’amichevole passeggiata campestre, in quel tempo molto in voga, con relativa merenda sul prato. Soltanto due compagni dirigenti della cellula sapevano quello che molto probabilmente sarebbe avvenuto.
Fatta colazione i compagni in gruppo stavano avviandosi per il ritorno in città procedendo in un avvallamento quando dall’ alto del dirupo feci la mia apparizione. Ero conosciuto perché anch’io avevo lavorato per tre anni al Cantiere Navale, perché per oltre quattro anni avevo fatto il fattorino tranviario, quindi a contatto con la massa popolare; ero conosciuto anche per i miei precedenti politici e tutti i compagni sapevano che ero latitante perché ricercato dalla polizia fascista.
Il gruppo di compagni si arrestò perplesso, meravigliato e tutti mi si fecero attorno.
Mi presentai come se l’incontro fosse dovuto esclusivamente al caso e quindi nessuno poteva essere accusato di averlo preparato, di complicità. Poiché tutti mi chiedevano notizie, non parve strano credo, che nel raccontare ai lavoratori quanto mi accadeva e il perché della mia vita clandestina, collegassi queste mie vicende alla situazione politica, economica, bellica, senza fare cenno all’ organizzazione clandestina, formulando auguri per la pace e la fine della dittatura fascista e l’avvento di una società più giusta, più umana, quindi tutto si concluse come una specie di “comizio”, così come mi riuscì di fare, senza pretese, e poiché qualcuno alla fine incominciò a cantare “L’inno del lavoro” che avevamo imparato in carcere nel 1932 e diffuso in Ancona, e che tutti sapevano, finimmo col cantarlo tutti in coro tra il più grande entusiasmo:
«Non siamo noi quei bruti che dicono i signor,
noi siamo proletari, siamo lavorator.
Viva la libertà, fate largo che passa il lavor>>
E salutando tutti mi sono allontanato.
Nelle stesse ore di questo fraterno ed entusiastico incontro, sul piano bellico avveniva qualche cosa che avrebbe determinato per l’Italia un avvenire che non sarebbe stato quello che i compagni si erano augurati: la stessa notte dalle navi in rada, scendevano in Sicilia gli uomini della V e VIII armata anglo-americana, che sostanzialmente avrebbe significato si il crollo definitivo del fascismo, ma anche la continuità dell’oppressione capitalista.
Ma anche su questo dovrò tornare.
Ancora una testimonianza
Nel mese di settembre 1970 ho ricevuto dalla Jugoslavia una lettera. Stralcio da essa, così, come è scritto, la seguente parte:
Caro Raffaele,
…o una grande bisogno da te e altri compagni del
Comitato Partito Comunista di Ancona.
Come io adesso devo andare alla Pensione ci ocore un documento una “testimonianza” da te e quale nostro Comitato deve “verificare” con il timbro del partito che io sono in tempo dal 1.1.1942 fino al 30.10.1943 quando mi trovavo in carceri di Ancona, collaborato con te e altri compagni, quali sono stati dentro per reati politici: Dr. Catalini, Bravi, Saracini Colombo, Alfonso Cesaroni e altri.
Che io in quel tempo lavoravo in cucina e i biglietti che venivano da fori io li distribuivo ai compagni arrestati e così nel interogatorio eravamo in acordo.
Una volta mi ano preso e ero 14 giorni sul leto di forza e preso un muchio di bastonate dale guardie.
Tu ti ricordi che quelo e tutto giusto e ti prego come un vechio compagno che mi mandi questa testimonianza scrito in 3 copia…
Tanti saluti.
ZungulSvonko (alias Vladimiro)
(glunac) Varazdin – NarodnoKazaliste (Juguslavia)
Incontro con i contadini
L’organizzazione contava ormai oltre 1.700 aderenti appartenenti alle diverse categorie di lavoratori: operai, artigiani, piccolo-borghesi, studenti ed intellettuali, mentre i rapporti con i lavoratori della terra erano quasi inesistenti. È vero che consideravamo naturali alleati degli operai anzitutto i braccianti, i contadini poveri, poi
i salariati delle imprese agricole, ma non avremmo disdegnato avere rapporti con i mezzadri la cui economia costituiva la base prevalente nella nostra provincia.
Sbagliando, pensavamo che il problema dei contadini fosse essenzialmente di competenza di altre regioni. Ci volle del tempo per far capire che il problema era anche il nostro, ma che si presentava a noi in modo diverso e certamente più difficile. Pensavamo alla zona del triangolo industriale della Lombardia e del Piemonte con la presenza di una forte classe operaia, così come il nostro pensiero andava alla pianura Padana e al Tavoliere delle Puglie, ambedue regioni con la presenza di forti masse bracciantili, quindi lavoratori fortemente interessati alla collettivizzazione della terra con l’aggiunta per l’Emilia di una forte tradizione cooperativistica.
Eravamo convinti che le altre regioni fossero più avanti di noi sul piano dell’organizzazione clandestina, date le condizioni delle
Marche, regione poco industrializzata quindi con una debole classe operaia e con l’agricoltura basata sulla mezzadria, cioè con una massa di contadini, poco propensi a battersi per una società basata, in linea di massima, sulla collettivizzazione dei mezzi di produzione. Durante il periodo del carcere e del confino mi ero incontrato con un gran numero di compagni emiliani e pugliesi, che erano sempre animati da un forte spirito combattivo, da ciò la convinzione che anche nelle altre regioni il partito andava organizzandosi per essere pronto al momento opportuno.
Perché avremmo dovuto comportarci in modo diverso dagli altri?
Eravamo sempre alla ricerca del contatto con l’organizzazione centra le del partito bisognosi come eravamo di orientamento.
Nel 1939 visitai a Conselice (Ravenna) un bracciante con il quale avevo diviso la cella 670 del carcere romano, che dopo il ritorno a casa per l’amnistia del 1932, era costretto a fare il bambinaio a casa, mentre la moglie lavorava nei campi. Ma del partito nessuna notizia.
Nel 1942, terminata l’ammonizione tornai per due volte a Imola (Emilia). La prima volta accompagnato con Clara, alias Guglielma Nicoletti per visitare certi suoi parenti che supponeva essere legati al partito. Erano compagni, ma senza collegamento con l’organizzazione. La seconda volta feci il viaggio con mia moglie ed eravamo attesi dal compagno Carlo Alberto Poggiati, che avevo conosciuto a Ventotene nel 1935/37. Uscimmo dalla nostra abitazione verso le ore due, giunti in via XXVIII ottobre (oggi Gramsci), come d’accordo con i compagni trovai tra gli stipiti di una porta di un negozio un pacco contenente un certo numero di copie de “La Voce del Lavoro”. Pacco che mia moglie provvide a nascondere sotto le sue vesti.
Per raggiungere la stazione ferroviaria dovemmo percorrere a piedi quasi due chilometri ed io ero fortemente preoccupato perché sarebbe bastato incontrare una ronda di poliziotti o di militi fascisti che insospettiti, data l’ora tarda, perquisendoci, avrebbero potuto trovare il materiale compromettente addosso a mia moglie, con le conseguenze facilmente intuibili. Ma si vede che c’è un dio anche per i comunisti perché raggiungemmo la stazione, il treno ed Imola senza inconvenienti.
La sera stessa con il compagno Poggiali, raggiunsi una casa colonica in bicicletta.
Nella stalla trovai riuniti una ventina di contadini.
Nacque una discussione, furono poste delle domande, ascoltai i loro desideri, le loro speranze, parlammo della situazione politica, economica e soprattutto bellica e conclusi invitando a continuare la lotta, a prepararsi per le battaglie a venire, affermando che oramai il fascismo aveva i giorni contati. Poi inforcammo le biciclette e forniti di alcuni chili di patate e fagioli offerti dai compagni contadini, tornammo a Imola e da qui ad Ancona ma ancora una volta senza aver incontrato il partito.
“L’americano”
Penso che i destinatari di queste righe si saranno già resi conto che queste sono le semplici memorie di un semplice uomo e che esse possono interessare e andare fino in fondo, se ogni tanto presentano un quadruccio locale, paesano, umano su fatti realmente accaduti ad esseri semplici, magari obbligati a svolgere un ruolo di un certo tipo, senza volerlo, cioè che non volendo si trovano coinvolti in casi più grandi di loro, tutto ciò senza presunzione, e che narrano bonariamente anche i piccoli episodi, che certamente sarebbero trascurati da chi scrive fatti importantissimi.
A me interessa mettere in evidenza la semplicità del procedere di compagni di fronte a casi della vita quotidiana che dimostrano come non tutti gli italiani avevano paura dello squadrismo fascista.
In Ancona, un pomeriggio, piazza del Comune. Siamo un gruppo di compagni, da un anno mi sono congedato dalla regia marina, siamo aggruppati, parliamo di tutto.
Ad un tratto sbuca da via del Comune un giovane, che cammina rollando come un vecchio “lupo di mare”, molti gridano: «Ecco l’americà!». Pacche sulle spalle, richiesta reciproca di notizie, poi improvvisa la domanda: «Conoscé un certo Maderloni?!». io lo guardo e penso: questo sarebbe colui del quale tutti gli amici parlano con entusiasmo come di un compagno che picchia forte! Uno del gruppo dice: «Maderloni?! Eccolo qui!», L’americà allarga le braccia e dice: «Ti porto i saluti della “lista “. io ho preso il tuo posto!». Egli viene da Taranto dove fa il servizio militare nella marina regia. Per i suoi precedenti lo hanno messo nella “lista nera” di cui ho già scritto.
Gli dico: «Lo sai che avevo promesso ai compagni che al nostro primo incontro ti avrei preso a pugni! E se lo avessi fatto che cosa sarebbe successo?!». «Ti avrei abbracciato – e soggiunge – sono stato ricoverato all’Ospedale militare di Taranto, sulla mura ho letto: Maderloni – Gafà – Failla – W la libertà. Laggiù parlano di te con entusiasmo. Sono felice di stringere la tua mano». Questa è stata una presentazione.
Due anni dopo, nel pomeriggio di un giorno di settembre 1931. Sto conversando con “l’ americà” nella nostra piazza del Comune. Ad un tratto vedo sbucare mia madre dal vicolo dei Tribunali dove abitiamo, e tutta affannata mi dice: «Ti cercano un gruppo di fascisti, sono stati a cercarti a casa!». Temendo una perquisizione ha nascosto tra le sue mammelle la mia 6,35. Cerco di rassicurarla e la invito a tornare a casa.
Qualche attimo dopo dalle diverse strade che portano sulla piazza escono alcuni gruppi di “giovani fascisti”. Saranno in tutti una ventina. Indossano la “camicia nera” e il fazzoletto giallo e rosso che sono i colori del Comune di Ancona. I diversi gruppi si dirigono dove io sono e allora invito il compagno ad andarsene allo scopo di non farlo compromettere. Ma egli fa un gesto di diniego e dice: «Non ti lascio solo!».
Dopo alcuni istanti eravamo circondati e uno di loro che riconosco come un cameriere presso il Casino Dorico, un club della borghesia anconetana, mi chiede se sono Maderloni e dopo averlo inteso mi invita ad andare con loro perchè il “Comandante dei giovani fascisti”, Remo Veroli, desidera parlarmi. Rispondo che io non conoscevo il loro comandante e che con lui non avevo nulla da spartire. Ma costui insiste ed io decido di affrontare il rischio.
Ci incamminiamo lungo la via del Comune, per recarci in Piazza Cavour dove ha la sede la federazione fascista. I fascisti fanno cerchio attorno a noi. Mentre stiamo percorrendo il tratto davanti alla Prefettura, ancora una volta invito ”l’americà” a lasciarmi solo. Conoscevo il suo carattere generoso e poco propenso ai compromessi.
Aveva fatto più volte a pugni con i fascisti e si era fatto fama di “picchiatore”, ad un tratto mi propone di picchiare i più vicini e poi fuggire. Intanto notavo che il nostro passaggio attorniati i dai fascisti non passava inosservato. Assicuro il compagno che saprò cavarmi di impaccio. Avevo capito che si trattava di una questione personale.
Raggiungemmo la sede fascista, salimmo al secondo piano ed entrammo in una stanza piena di giovani fascisti e in un angolo dietro ad uno scrittoio troneggiava il “comandante” Remo Veroli, uno squadrista. Era famoso intanto perché pur essendo figlio di un operaio era fascista e per aver ammazzato un uomo nel 1922, credendo di essere aggredito da antifascisti.
Qualcuno disse: «Questo è Maderloni!».
Veroli guardandomi con aria provocatoria mi apostrofò: – Ti puzza la salute?!
Rispondo: – Secondo!
Il Veroli:
– Dagli uno schiaffo!
Ribatto:
– Gli schiaffi non li voglio!
Ma non avevo ancora terminato la frase che mi sentii percuotere il viso, da uno che mi stava di fianco.
Reagii immediatamente gridando: «Ma che cosa vuoi?!».
Veroli: «Devi finirla di cantare “Bandiera rossa”!».
Alzai la voce con atteggiamento sicuro: «Bandiera rossa?! Vuoi sapere qual è la verità?! – e indicando nel gruppo – Vedi, quello si chiama Artemio Paletti, è il figlio del capo dei sorveglianti del Cantiere Navale, l’altro si chiama “Rondello”, l’altro ancora si chiama Mattia, sei mesi fa, erano in quattro, li ho fatti fuggire tutti da solo, sono quattro vagabondi che la notte nel rione Porto danno fastidio ai lavoratori. Oggi per vendicarsi inventano che io canto “Bandiera rossa”!».
Il Veroli si convinse che io avevo ragione, disse: «Va bene, ma lo schiaffo l’hai avuto perché hai risposto male!». Risposi che avevo risposto come dovevo. Per una ragione giusta la salute può anche puzzarmi. E intanto promisi ai quattro che ci saremmo visti fuori.
Stavo uscendo quando portarono dentro “l’americà”.Mi fermai e mi misi al suo fianco. Qualcuno disse: «Questo era insieme a Maderloni!».
Veroli interroga:
– Chi sei?
– Giuliodori Umberto, detto l’americà!
– Cosa sei venuto a fare qui?
– Sono venuto ad accompagnare il mio amico Maderloni!
– E se lui avesse preso le botte?
Guardandolo negli occhi dice:
– Le “dividemi”!
Con questa calma risposta il colloquio cessa. Usciamo.
In piazza Cavour diversi compagni sono ad attendere. Mi si fanno d’attorno.
Giannini Ruggero dice: «Com’ è andata?» Dico: «Un porco mi ha dato un colpo in faccia!». Ruggero mi abbraccia e mi stampa un fraterno bacio sulla parte offesa e mi dice: «Un giorno forse faremo i conti!».
Il 25 luglio 1943
Allenato ti dormire sempre con un occhio solo e con lo spirito sempre all’ erta per non farmi sorprendere dal nemico, passai la notte del 24 luglio tranquillamente ritenendomi al sicuro, lontano da Ancona, in un modesto appartamento di una sperduta borgata della provincia. Mi trovavo al Pianello di
Castelbellino. Avevo dovuto lasciare nottetempo la casa del compagno Cinti al Borghetto di Ancona, per portarmi in bicicletta al Pianello perché il 25, domenica, avrei dovuto incontrarmi con i compagni dirigenti della città di Jesi per una questione molto importante. Avrei dovuto vedermi con loro sul ponte in vicinanza di questa frazione, sulla strada per Cingoli.
Quella notte mia moglie dormì al mio fianco. Il giorno prima era stata a visitare mio figlio Roberto ospite di una colonia montana e precisamene nel paese di Moteroberto, pertanto non le fu difficile raggiungere Pianello dove mia sorella Maria aveva affittato un appartamento per far respirare i figlie soprattutto per prepararsi a sfollare la città di Ancona in caso dì bombardamenti anglo-americani.
Mi stavo preparando per andare all’appuntamento coni compagni di Jesi, quando mi venne l’idea di ascoltare la radio. La notizia della caduta del fascismo mi riempì di gioia, salutai mia moglie che per far ritorno ad Ancona avrebbe preso il treno, inforcai la bicicletta e mi precipitai all’appuntamento, poche parole di circostanza con i compagni e poi giù a pedalare sulla strada che da Jesi conduce ad Ancona.
Non mi sembrava vero poter camminare in libertà alla luce del sole. Tutto mi sembrava gioioso, bello, sorridente, la bicicletta sembrava volasse, non vedevo l’ora di giungere ad Ancona, trovarmi con i compagni, senza dover tener conto delle norme cospirative, poter parlare ad alta voce e magari gesticolare senza doversi guardare in giro per tema degli sbirri.
Ad Ancona mi trovai in mezzo a decine di compagni che si erano radunai i al “Tappeto verde”, un locale sito al primo piano di un palazzo in piazza S. Maria, dove alcuni pensionati benestanti avevano messo un tavolo da biliardo per passarvi alcune ore del giorno, le chiavi di questo locale erano in consegna ad un nostro compagno che ci consentiva di riunirci nelle ore in cui non serviva ai pensionati.
Mi trovai con i membri del comitato direttivo: Vittorio Marinelli, Gherardo Corinaldesi, Augusto Dino Carelli, Gino Grilli (assente per grave malattia), Ruggero Giannini (assente perché detenuto in carcere), Achille Fiordemondo (responsabile organizzazione zona di Ancona), Mario Medici (responsabile organizzazione zona di Ancona).
Membri del comitato direttivo federazione giovanile: Alessandro Maggini, Renato Bramucci, Aldo Pelliccia, Luigi Acrosso (assente perché detenuto in carcere), Leandro Mancinelli, “Nando”.
I membri del comitato cellula Cantiere Navale: Remo Ricci, Leonida Remaggi.
Responsabile della cellula ferrotranvieri: Eugenio Monti.
Responsabile della cellula portuali: Atlantico Galeazzi, …..e numerosi altri compagni.
È una riunione, questa, che nessuno ha organizzato, ci siamo cercati, sono ore di grande entusiasmo ma anche di confusione, le notizie si comunicano con la rapidità del vento.
Il primo pensiero fu per i compagni detenuti a S. Palazia, quindi organizzare per il mattino successivo una grande manifestazione contro il palazzo della federazione fascista, poi corteo per il Corso Vittorio Emanuele per chiedere appunto la liberazione dei compagni e di qualsiasi altro detenuto politico, che certamente non vedevano l’ora di essere liberati, per il resto ci saremmo regolati in rapporto alla situazione che si sarebbe trovata il mattino dopo.
Il mattino dopo ci si trova di fronte alle restrittive disposizioni del Governo Badoglio, ma la manifestazione popolare è grandiosa. La massa popolare attacca la federazione fascista in piazza Cavour, la invade e distrugge ogni simbolo del regime e nessun fascista è lì a difendere il suo partito. Hai un bel guardare agli occhielli delle giacche degli anconetani, non vedi una “cimice”, cioè un distintivo del P.N.F., nemmeno a pagarlo a peso d’oro.
In piazza Roma mi trovo alla testa di un corteo di dimostranti, qui incontriamo un gruppo di “dignitari” della questura e tra questi il dr. Luigi Russo, capo di gabinetto, il quale per evitare scontri, mi invita a far entrare la massa nella normalità. Gli urlo che ormai il fascismo non c’è più e che pertanto vogliamo siano rilasciati subito i detenuti del carcere giudiziario e lo faccia presente al questore ed al prefetto. Nel corso della giornata infatti molti detenuti politici vengono posti in libertà ma si continua a trattenere i comunisti.
Mentre continuano le manifestazioni popolari per la pace e per la libertà un gruppo di compagni si riunisce e decide di organizzare per il giorno dopo la liberazione violenta dei comunisti carcerati. Il piano è il seguente: mentre tutti i compagni di tutte le cellule si riuniranno al centro della città, insieme a tutti i simpatizzanti ed antifascisti per continuare le manifestazioni di protesta contro il Governo Badoglio e Roatta, e le loro disposizioni repressive che hanno già fatto qualche vittima tra gli antifascisti che vanno distruggendo gli orpelli del regime, quando alle ore l0, la si-rena emetterà il solito urlo di prova, come segnale di incursioni aeree nemiche, tutti i lavoratori cesseranno l’attività, uscendo dal Cantiere Navale.
Un forte gruppo di compagni scelti tra i più capaci, attraversando, in ordine sparso, numerosi vicoli del rione Porto, senza fare eccessivo rumore, si porteranno al Guasco avvicinandosi al carcere e tentare l’assalto e liberare i politici, con l’aiuto di alcuni compagni “addetti alla custodia” che avrebbero dovuto aprire il portone d’accesso. Per la riuscita del piano si faceva affidamento anche sulle condizioni generali del momento.
Senonchè alle 10 la sirena tace, insolitamente tace, questo fatto crea un po’ di disorientamento nelle diverse sezioni di lavoro del Cantiere. Il Comitato di cellula decide di sospendere il lavoro egualmente e uscire dallo stabilimento e così avviene, in parte però, perché mentre le maestranze si dirigono verso la parte centrale di uscita, trovano questa sbarrata da “cavalli di frisia” e diverse mitragliatrici puntate. Sarebbe un inutile massacro, comunque il prefetto dovette convincersi che bisognava soddisfare la nostra richiesta perché, finalmente, anche i nostri compagni vennero rimessi in libertà.
Il mese di agosto 1941, irretiti come siamo dalle disposizioni repressive di Badoglio e dalla circolare Roatta, ci si limita a fortificare la nostra organizzazione politica. Siamo in attesa che maturino gli eventi sul piano nazionale. Ci giungono notizie circa eccidi popolari commessi dalle forze armate del “nuovo ordine”. C’è una stasi anche sul fronte bellico dell’Italia meridionale, dopo che le armate angloamericane hanno completato l’occupazione della Sicilia.
Giunge ad Ancona l’ex deputato comunista Guido Molinelli, chiede di essere tesserato nella nostra organizzazione, ma poi ci ripensa e parte per il Sud. Da Milano è tornato anche il compagno Adelmo Pianelli e lo invitiamo a far parte del comitato direttivo. Gli affidiamo l’incarico di mettere il naso nella direzione dei sindacati degli operai dell’industria allo scopo di rendersi conto della situazione. L’accompagniamo negli uffici siti in piazza S. Maria e lo presentiamo al dirigente Palazzi, facciamo affidamento sulla collaborazione che gli può essere data da elementi democratici impiegati nel sindacato come Alfredo Felici ed altri.
Il compagno Pianelli prepara una serie di articoli di carattere sindacale che appariranno sul quotidiano locale.
Torna ad Ancona anche il compagno Alfredo Spadellini dall’isola di Ventotene.
Anche egli viene invitato a far parte del Comitato Direttivo e in considerazione dell’esperienza fatta nella guerra spagnola tra le brigate internazionali, da dove è torna-to ferito, viene incaricato degli aspetti militari della situazione.
Non abbiamo ancora un’idea di come si metteranno lecose, ad ogni buon conto, in attesa di prendere il contatto con il “centro” del partito, e sapere qual è l’orientamento generale, approfittiamo della situazione per accumulare armi nel caso si debba attaccare visto che ciò è la migliore difesa. L’organizzazione è diramata anche tra i militari che comunque finora stanno ai loro posti. Uno di questi” un romano, il compagno Proietti, ogni tanto esce dalla caserma vicino a Piazza Cavour per portare in un “buco” clandestino che abbiamo in uno stabile situato sopra il cinema Vittorio Emanuele, affittato dai compagni fratelli Lucioni, bombe del tipo “Balilla”.
Prima dell’11 luglio 1943, cioè prima dello sbarco alleato in Sicilia, nelle nostre conversazioni, ci auguravamo che il crollo del regime fascista avvenisse prima che il suolo del nostro Paese venisse calcato dalle scarpe di soldati stranieri (tedeschi o anglo-americani, perché in questi vedevamo comunque strumenti del capitalismo internazionale).
Pensavamo che una volta entrati in Italia gli stranieri ci avrebbero impedito la realizzazione di una società più umana, più giusta. Speravamo nel crollo del regime, in una pace separata, la non belligeranza e la pace con tutti i popoli, la libertà di edificare una società democratica, rivolta al socialismo.
Già nel 1941, prima dell’invasione nazista dell’Unione Sovietica, ne “La Voce del Lavoro” avevamo indicato nella guerra in atto tra il “tripartito”e gli “alleati” una guerra imperialista e che non potevamo stare né con chi “convertizzava” Genova né con chi aveva distrutto Conventry (Inghilterra), Ma su questo aspetto della situazione dovrò tornare più tardi.
Finalmente “ecco il partito”
Ho già riferito come il compagno Mario Zingaretti avesse deciso di mantenere per sé l’incarico ricevuto di ricostituire il partito comunista, non tenendo conto del nostro colloquio. L’organizzazione fu costretta a provvedere per chiarire la situazione che minacciava di disorientare i compagni di emettere una circolare, indicando il compagno Zingaretti con la sigla “Z/42” e cercando di neutralizzare la sua azione.
I tempi che correvano non lasciavano spazio a divisioni, a lacerazioni anche perché per i compagni non esistevano problemi ideologici da risolvere. Certo è che avere tra le mani copia del giornale del partito “L’Unità” era un’arma formidabile per sostenere di essere i genuini rappresentanti del P.C.I. ma dalla nostra parte avevamo anni di attività che annullavano il magico effetto di possedere il giornale del partito. Poi tutto era andato a tacere perché Zingaretti era stato arrestato con il gruppo della “Concentrazione Antifascista” e il rappresentante del Partito, Marco (come sapremmo poi) era stato arrestato anche lui.
Per chiudere su questo episodio dirò che nel mese di agosto 1943 ricevemmo l’invito ad inviare una delegazione della nostra organizzazione nello studio commerciale di Luigi Ruggeri, sito in corso Vittorio Emanuele di Ancona. I compagni delegarono me e il compagno Corinaldesi, e in questo ufficio, oltre al Ruggeri, Mario Zingaretti, un infermiere del manicomio Stefanini, trovammo il compagno “Marco”, cioè il rappresentante del “centro interno” del partito. Questi aveva chiesto notizie sulla consistenza della attività svolta dal Zingaretti e si ebbe come risposta che bisognava rivolgersi altrove e da qui l’invito a noi.
La discussione fu breve, animati, come eravamo, di essere uniti, naturalmente dovetti riferire circa i precedenti che qui ho narrato, ma Zingaretti dichiarò che egli era d’accordo con la linea del partito. Naturalmente tra compagni, poi, tentammo di spiegarci che cosa era accaduto nella sua mente e finimmo col concludere che… tutto è bene ciò che finisce bene… e che le vittorie delle armate “staliniane” riuscivano a demolire quello che ponderosi libri teorici erano riusciti a costruire.
Qui confesso che non ho mai capito, anche perché non me ne sono mai occupato, se il trotzkismo di fronte ai problemi italiani, si trovava alla nostra destra o alla nostra sinistra. Veramente all’isola di Ventotene, i compagni dirigenti, che ne sapevano più di noi, affermavano che il trotzkismo non era che una specie di opportunismo, come certe forme di anarchismo che sono facili da professare in quanto non portano nocumento, consentono di apparire ultra rivoluzionari, e nello stesso tempo ti permettono di far pacificamente i tuoi comodi e interessi.
Chiedemmo la forza organizzativa del gruppo Zingaretti.
Ecco l’elenco: ing. Gino Tommasi, Luigi Ruggeri, Andreoni Armando, Arturo Stefanini, Prof. Vittorio Fanelli, Giovanni Silvestrelli, Sirio Piermattei, Elvezio Grati, Silvio Franchini.
La nostra era un’organizzazione diramata in tutte le Marche e con addentellati in altre regioni d’Italia e in particolare con una forte organizzazione tra i marinai a Taranto come è stato documentato in queste memorie. Il compagno “Marco” chiese alla fine dell’incontro la mia biografia e quella di Zingaretti e se ne andò. Tornò dopo una decina di giorni: il “centro” del partito confermava il mio incarico di segretario dell’organizzazione provinciale anconetana e la costituzione di responsabili per le altre province delle Marche.
9 settembre 1943 – la fuga dei Savoia
Il 9 settembre 1943 in uno studio legale in via Goito sono presenti: avv. Oddo Marinelli, G.L.; dr Piero Pergoli, G.L.; Rag. Renato Gigli G.L.; avv. Alessandro Di Mattia, socialista; Avv. Alessandro Bocconi, socialista; Plinio Canonici, popolare; Mario Zingaretti, comunista; Armando Androni, comunista; Raffaele Maderloni comunista.
Rappresentano i partiti politici nella “Concentrazione antifascista” che, alla luce delle ultime notizie sulla fuga dei sabaudi e dei loro cortigiani, decidono di presentarsi al Prefetto di Ancona. Insieme a costui, che dichiara di essere stato di sentimenti liberali e pertanto un antifascista sono presenti per la Questura il dr. Luigi Russo, per la Legione dei Carabinieri il Maggiore Cassone.
Ad esporre è l’avv. Marinelli: gli anconetani temono che, i tedeschi che scendono dal nord passando per le Marche potrebbero degenerare in atti violenti. Noi desideriamo impedirlo unendo le forze civili a quelle militari, per difenderci. Il Prefetto mena il can per l’aia, alle proposte afferma che bisogna mettere il nero sul bianco, o viceversa, e presentarle alle autorità militari per vedere come la prendono, per parte sua, non ha fatto neppure il soldato di leva… Gli altri, si guardano, annuiscono, io ho la sensazione che salvo noi comunisti, siano tutti d’accordo. Forse sbaglio, ma credo che abbiano una grande paura di armare il proletariato, le forze popolari.
Propongo al Prefetto di “chiudere il becco” “ al “Corriere Adriatico”, il Giornale quotidiano ancora in mano ai fascisti che “sproloquia”.
Il Prefetto risponde: “Fate voi, io non vedo, non sento, non parlo!». È chiaro che è uno schifo.
Scendo in piazza, chiamo una diecina di compagni e l’occupazione del giornale è una cosa fatta. Dopodiché arriva la “Concentrazione Antifascista. Ma qualcuno verrà a dire il giornale non è del partito fascista, appartiene alla proprietà privata e che non si può procedere, così all’espropriazione!
Cos’è facciamo il comunismo?! No! No! Chi dice ste cose? Il giornale serve, facciamo un comitato per l’acquisto della proprietà! Il giornale sarà acquistato da un comitato rappresentante dei quattro partiti politici.
Intanto si crea un comitato redazionale con: prof. Paolo Acrosso, indipendente; avv. Oddo Marinelli, giellista; cav. Plinio Canonici, popolare; avv. Alessandro Di Mattia, socialista; ing. Gino Tommasi, comunista.
Altro comitato con incarico di preparare un piano militare è composto da: magg. (della riserva) Gino Tommasi, Giulio Maggi, Alfredo Spadellini.
Il piano si propone la difesa della città e della provincia di Ancona, ma è evidente che non si vuole armare la classe operaia, non si vuole organizzare una milizia popolare, la guardia nazionale. Come sempre fa capolino la lotta di classe per gli interessi di classe.
Il 10 e Il settembre 1943 presenta il quadro di una società in disfacimento, circolano le notizie più contraddittorie sui tedeschi e suglianglo-americani. Dalla Capitaneria di Porto giunge alla redazione del giornale “Corriere Adriatico”, dove siamo accampati, la notizia che sarebbero giunte disposizioni dal Sud secondo le quali bisogna tenere sgombre le banchine del porto perché da un’ora all’altra dovrebbero giungere navi inglesi. Ma la notizia così importante non viene confermata.
Sono al giornale, un gruppo di giovani mi dicono: alla polveriera Bianchi, sita a Borgo Rodi, i soldati vogliono darci delle armi. Bene, andiamo a prenderle. Il compagno Adelmiro Nacci, ci presta un camioncino e ci rechiamo a Borgo Rodi. Ci avviciniamo alla polveriera, ci accoglie una nutrita scarica di fucilate, noi siamo disarmati. Scappiamo. Che cosa era accaduto? Ci avevano presi per fascisti. Più tardi, chiarito l’equivoco, porteremo in porto l’azione, ma i fucili sono privi del caricatore pertanto inutilizzabili.
Ancora una volta nella clandestinità
Nelle strade si incontrano gruppi di militari sbandati che chiedono indumenti civili prima di avventurarsi sulle strade che conducono al nord, dove potrebbero incontrare i tedeschi. Dopo il deludente colloquio con il Prefetto e il nulla di fatto con il Comando militare, è evidente che molto dipende dall’ iniziativa popolare e l’orientamento è quello di organizzare formazioni militari di “Guardia Nazionale”.
Il problema più angoscioso è quello delle forze armate germaniche che sono tuttora al sud e che intendono contrastare il terreno degli Alleati e soprattutto sono le forze naziste che certamente scenderanno dal nord e che certamente passeranno per la nostra regione con quel che ne consegue di violenza e di sopraffazione. Bisogna che i tedeschi abbandonino l’Italia al più presto.
Invece il giorno 15 settembre, provenienti dal nord, forze armate tedesche, su carri armati, entrano in Ancona senza trovare resistenza alcuna da parte popolare appunto per la negativa posizione presa dai comandi militari. L’arrivo dei nazisti con i carri armati e con tutto il loro armamento provoca il bisogno di mettersi a riparo dalle loro rappresaglie. Infatti la stessa notte del loro arrivo, un manipolo tedesco accompagnato da un elemento fascista, si presenta in Vicolo dei Tribunali, dove abitavo con la mia famiglia, picchia alla porta, chiedono mie notizie al vicinato, aprono con la forza la porta d’accesso, si rendono conto che la casa è vuota, non c’è anima viva. Si sfogano sulle masserizie e se ne vanno. La mia famiglia è stata, insieme alla famiglia di Giannini Ruggero, trasferita a Recanati.
Vige il coprifuoco, molti anconetani sono sfollati in provincia, ma la maggioranza è ancora in città. La vita produttiva è limitatissima; c’è stasi in ogni cosa. L’organizzazione ancora una volta clandestina porta la sua segreteria in casa di un ex fascista, Martino Fiori, che già nel 1940 contribuisce finanziariamente. Il Fiori abita nel rione “bene” al Viale della Vittoria, ovunque potrebbero cercarci fuorché qui. L’appartamento diventa il luogo di contatto con tutta l’organizzazione politica sino al 16 ottobre epoca in cui Ancona subisce il primo dei 143 bombardamenti aerei che la distruggeranno per tre quarti.
Della segreteria provinciale sono rimasto solo. Il compagno Prof. Vittorio Fanelli è stato in missione a Bari per prendere contatto con il partito, il compagno Stefanini ha dovuto trasferirsi a Sassoferrato dove è stata organizzata una sezione dell’Ospedale Psichiatrico di cui è dipendente, Giannini Ruggero si sta occupando con altri compagni dell’organizzazione di gruppi armati, Gherardo Corinaldesi deve occuparsi della tipografia clandestina allestendo la nuova testata “L’Aurora”.
Dopo il primo bombardamento l’esodo degli anconetani si fa massiccio. Essi si sparpagliano per tutta la provincia e la regione alla ricerca di un luogo che li tenga salvi dal furore della guerra, dai tedeschi, dai fascisti. Una parte dei compagni, messi in salvo i familiari, tornano in Ancona e si mettono a disposizione del partito.
Il mio compito è:
– mantenere i contatti con “Marco” responsabile regionale;
– collaborare con “Francia” Luigi Ruggeri, che rappresenta il nostro partito presso il Comitato Liberazione Nazionale per la regione e la provincia di Ancona;
– collaborare con “Annibale” Gino Tommasi indicato dal C.L.N. quale responsabile delle forze armate popolari della regione Marche;
-mantenere il contatto con “Barba di rame” Gherardo Corinaldesi, per la tipografia clandestina e procurare staffette per il trasporto della stampa nella regione;
– reperire i compagni nei luoghi di sfollamento e riorganizzare il partito, premere per la costituzione in ogni dove di C.L.N. locali;
– organizzare gruppi di staffette per il Comando partigiano; per i contatti col “centro al nord” e per recuperare le armi e munizioni nascoste in Ancona.
Ho diviso la provincia in zona creando dei responsabili: Eugenio Monti: Agugliano, Polverigi, ecc.; Alberto Zavatti: Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, ecc.; Mario Zingaretti: Arcevia, Serra S. Quirico, Fabriano, ecc.; Orfeo Massarenti: Camerano, ecc.; Siria Piermattei: Chiaravalle, Castelferretti, ecc.; Bontempi: Castelfidardo, ecc.; Cesaroni-Mosconi: Jesi, ecc.; Libero Vannucci: Sirolo, Numana, ecc.; Giuseppe Mariani: Loreto, ecc.; Romolo Baldassari: Filottrano, Cupramontana, ecc.
Dopo l’inizio dei bombardamenti della città, la segreteria e il “buco stampa” sono stati trasferiti al Borghetto di Ancona. La tipografia è in attività entro una specie di sotterraneo. “L’Aurora” viene redatto da “Marco” (Egisto Cappellini), curato dal “Barbadirame”, stampato dal compagno, tipografo Armando Spoltore, con l’aiuto del compagno Ferruccio Santarelli. La frazione Borghetto è stata abbandonata dai suoi abitanti sia per i continui bombardamenti a cui è sottoposta Ancona, sia per-ché essendo situata sul ciglio della via Flaminia, la strada è frequentata dai militari tedeschi e dai loro collaboratori.
Per quanto non siamo in missione in provincia, a farci un piatto di minestra calda ci pensa la compagna Bianca Sarti, compagna di Corinaldesi, valente, anzi eroica collaboratrice non solo in cucina e in tipografia, ma coraggiosa staffetta e portatrice di stampa da Ancona a Fano, a Pesaro, verso il nord e da Ancona a Porto S. Giorgio verso il sud compiendo centinaia di chilometri in bicicletta con una borsa contenente decine di copie de “L’Aurora” o de “Il Combattente” nascoste sotto uno strato di cicoria, insalata, ecc.
Due parole anche per Lelia Sarti, ugualmente eroica, “la garibaldina”, sorella di Bianca, che con una valigetta con doppio fondo, era capace, lei pur essendo giovanissima, vezzosa, mettersi su strada, fermare camion di tedeschi e chiedere un passaggio per Bologna, dove consegnava la valigetta, riprendendola dopo che altri compagni, prelevate le informazioni sui fatti partigiani delle Marche, le avevano sostituite con copia de “Il combattente” con le ultime notizie sulla Resistenza al nord, che dovevano essere stampate dalla nostra tipografia. Ancona-Bologna e ritorno!
Quattrocento chilometri con la soldatesca! Bisogna dire che in fatto di coraggio non mancavano, e non credo che siano state ripagate in uguale misura.
Altri compagni che si sono distinti nell’opera di staffetta sono: Furio Mazzanti, Rolando Cinti, Rmolo Baldassari, Alba Matteucci, Aurora Matteucci.
La Resistenza perde un dirigente
Negli ultimi giorni del gennaio 1944, i partigiani operanti nella zona di Ostra, sottraggono ad un “seniore” della m.v.s.n. un’automobile munita di salvacondotto tedesco e la consegnano al partito. L’auto giunge a proposito, poiché abbiamo per il giorno 6 febbraio un importante appuntamento in una casa colonica sul fiume Arzilla
nel pesarese.
All’alba di quel giorno, dopo aver falsificato la targa dell’auto e il numero sul salvacondotto rilasciato al “seniore” dai tedeschi, partiamo per Pesaro sulla Flaminia. Al volante un compagno autista, un operaio in gamba, al suo fianco Gherardo Corinaldesi. Io mi trovo tra il compagno Gino Tommasi eil compagno “Ernesto” fratello di Bianca e Lelia Sarti: Rodolfo Sarti.
Il viaggio è un azzardo forte ma bisogna andare. L’autista deve ubbidire a noi. All’occorrenza presenta il “permesso” ad un certo ordine mette in moto, parte ed accelera a tutto gas. Siamo armati di pistole, bombe a mano e, soprattutto, coperto da un grande asciugamano, sopra le mie gambe, puntato verso l’esterno dove si suppone si metta colui che esaminerà il “salvacondotto”, un mitra.
Siamo fermati una prima volta sul ponte del fiume Esino. Sono militari tedeschi. Un attimo, l’autista porge il foglio, il nazi legge, restituisce, si parte. Un sospiro di sollievo. Sul ponte del fiume Metauro invece ci fermano due militi fascisti. Ci guardano, tentennano, forse capiscono che è meglio lasciar correre, oppure pensano che sarebbe troppo sfacciato così in pieno giorno… ripartiamo alla svelta e poco dopo lasciamo alla nostra destra la via Flaminia e ci addentriamo nella campagna.
In una casa colonica troviamo “Marco” e numerosi altri compagni, tutti dirigenti delle Marche. Durante la notte si discutono problemi organizzativi e si prendono accordi sullo sviluppo delle operazioni militari. Un paio di ore di riposo sulla paglia e poi di nuovo partenza per il ritorno.
È evidente che non è igienico, salutare, tornare ad Ancona tramite la via Flaminia, il “furto” dell’auto deve essere stato già segnalato e pertanto decidiamo di rientrare nella nostra provincia seguendo strade interne. Naturalmente in caso di incontri con nemici la nostra reazione deve essere come quella predisposta all’andata.
La fortuna ci assiste, nessun incontro che desti preoccupazione; abbiamo superato Chiaravalle e stiamo filando verso Castelferretti, allorquando ad una curva, dopo un passaggio a livello, per non investire un carretto trainato da un cavallo, il nostro autista non riesce a tenere la strada e… capottiamo in un fosso laterale alla nostra sinistra. Sono il primo, pestando gli altri sotto di me, ad uscire dall’abitacolo, aprendo le portiere come una boccaporta”, esco indenne avendo nella mano sinistra una piccola valigetta con dei documenti e denaro e nella mano destra il “mitra”.
Da alcune case vicine accorrono persone, uomini e donne osservano la scena. Il secondo ad uscire, emergendo dalla boccaporta è l’ingegnere Tommasi, poi gli altri. L’arma che ho in mano indica che non siamo gente pacifica. L’uomo che guidava il cavallo con il carretto per il quale il nostro autista ci ha portato nel fosso, è lì che ci guarda non sapendo cosa fare. Gli ordino di girare il calesse, cosa che egli fa immediatamente. Sempre con il mitra in mano, salgo sul carretto e chiamo “Annibale”, l’ingegnere ha già superato una fratta, e preferisce allontanarsi attraverso i campi. Penso: «Avrà la sua buona ragione! »Dico a Barbadirame: «Ci vediamo al buco!». Sa dove trovarmi.
Ordino all’uomo di sferzare la sua bestia e di camminare alla svelta. L’uomo impaurito dalla mia arma frusta il cavallo che velocemente si avvia sulla strada in direzione di Castelferretti, distante 3 o 4 chilometri. Appena oltrepassata questa frazione di Falconara, dopo un centinaio di metri, faccio fermare, scendo dal carretto, invito l’uomo a tornare indietro alla svelta. Lo vedo allontanarsi, sparire alla curva, e rapidamente entro in una casa colonica sita una cinquantina di metri lontano. È una casa di contadini-compagni che accoglie anche compagni anconetani sfollati.
Sono ormai al sicuro, racconto l’incidente e sto invitando i compagni a correre in aiuto degli altri, quando invece, “bella come una sposa” arriva l’auto che era stata sollevata di peso da coloro che erano accorsi e che avevano capito che eravamo partigiani e che si prodigarono per rimettere la macchina su strada e che era in grado di continuare il suo cammino.
Di “Annibale” nessuna notizia. Ripartiamo dopo pochi minuti e percorsi 6 o 7 chilometri che ci separavano!’ dal “buco stampa” del Borghetto, arriviamo a casa del compagno Rolando Cinti. Ad attenderci c’erano la compagna Bianca Sarti, Ferruccio Santarelli, Armando Spoltore, Furio Mazzantie Lelia la Garibaldina. Non siamo preoccupati per “Annibale”. Gli ho consegnato per le spese diecimila lire.
Andiamo a dormire malgrado i bombardamenti ai quali siamo abituati.
È l’alba dell’8 febbraio 1944. La piccola borgata anconetana del Borghetto è immersa nel silenzio. È abitata soltanto da noi, gli altri sono sfollati in luoghi più tranquilli. Ad un tratto sentiamo uno scalpitio per lescale. Di certo è qualcuno che conosce l’ambiente, cammina, sale rapidamente sino al terzo piano. Entra nell’appartamento Alessandro Bieker, è un dalmata, in servizio nella marina militare di Ancona, già nel periodo cospirativo ha preso contatto con la nostra organizzazione clandestina, credo sia fidanzato con la figlia di un nostro compagno sarto.
La sua presenza in questo luogo e a quell’ora è foriera di cattive notizie. Infatti entra e ad alta voce comunica: «Questa notte tedeschi e fascisti sono entrati nell’abitazione dell’ingegnere Gino Tommasi, lo hanno trovato in letto, lo hanno arrestato!».
Il compagno Bieker era stato destinato, dall’organizzazione alla persona del Comandante. Era riuscito a passare inosservato e sfuggire all’arresto. Egli non era in grado di dirci dove il compagno Tommasi era stato condotto. Era un grave colpo per la Resistenza. E poiché sapevamo quali mezzi usasse la Gestapo per far parlare i detenuti politici, pensai che la prima cosa da farsi era mettere in salvo la tipografia e mettere sull’avviso tutti i punti di riferimento che “Annibale” conosceva perché facessero sparire ogni traccia e se necessario tenere lontane anche le persone per qualche tempo.
Avvertimmo “Marco” per mettere sull’attenti tutta la regione ed invitammo l’organizzazione tutta a fare quanto possibile per ottenere notizie circa il luogo dove avevano rinchiuso Tommasi per esaminare eventuali possibilità di liberarlo. Chiedemmo notizie di “Annibale” anche ad Adone Pierfederici, nostro compagno da vecchia data, figlio di ferroviere licenziato dal fascismo nel 1923, addetto al comando della m.v.s.n., ma neanche lui era in grado di darci notizie in merito.
Più tardi venimmo a conoscenza che non era più nella nostra regione, ma che era stato tradotto al carcere di Forlì. Purtroppo la sua sorte era segnata. Lo portarono in Germania ove morì in un campo di sterminio nazista il 5 maggio 1945.
Supponendo che Tommasi fosse rinchiuso nelle carceri di Macerata, alcuni partigiani vestiti da “militi” che dovevano consegnare un “detenuto” si fanno aprire le porte del carcere ma nelle celle non trovano chi cercano. Si tentò di catturare un “console” fascista per fame materia di scambio, ma inutilmente.
Ricordo del compagno Teodoro Pavoni
Teodoro Pavoni nato nel 1903, si è spento nel gennaio 1944.
Ha pagato la lotta contro il fascismo con il carcere e la perdita della salute, è stato un compagno generoso e onesto.
Gennaio 1944. Scende lentamente la sera, dalla finestra semiaperta entra leggermente un sottile profumo di terra bagnata e di piante. Nella camera della clinica immersa nel silenzio, la notte entra alla chetichella e s’impossessa di ogni cosa. Nel giorno che muore v’è la tristezza dell’addio.
Ogni tanto, nel corridoio, uno strascicar di ciabatte, un lampo di vita senza forza, interrompe per un attimo il grave silenzio che ricade più pesante, più opprimente di prima. Dai quattro letti, l’uno di fronte all’altro, ognuno dei malati vede nell’altro il proprio aspetto, la propria figura il declino finale. Tra questi c’è il compagno Doro.
Del biondo gigante dal cuore generoso rimane ben poca misera cosa.
Il fisico, roso dal male che non perdona, non ha alterato la mente ancora chiara e vivida. La sua fantasia ascolta il cuore che langue… e una selva di ricordi si affollano… una lunga teoria di personaggi, un insieme di episodi, tutta una vita, come una sequenza cinematografica che per un attimo lo distrae, ma..gli occhi dell’altro, degli altri… là… dinanzi a lui che lo guardano… lo indagano… e di nuovo il bianco scoglio di San Clemente, le canzoni, le ragazze sdraiate nella spiaggia di Breccia con il capo riverso e la gola al sole, palpitanti, desiderio d’amore… e S. Palazia, il tinitinnare delle chiavi del “superiore”… il sogno che gli ha riscaldato la vita e a questa ha dato un senso.
Ricorda…. Il tugurio, la misera branda e le arance fradice “tocche” e i suoi miseri clienti. Tutto un mondo di stracci… di poveri… di mesi e mesi… Haimé! Quanto appetito insoddisfatto. Il suo humour fa capolino: no! Non ho mai tribolato la fame, al contrario l’ho sempre goduta. Ne avevo tanta che avrei potuto regalarla, ma a chi? Nel mio mondo tutti ne avevano e in abbondanza che bisognava tenersela.
E ora era lì, con quelli che lo guardavano con gli occhi lucidi, affebbrati… aver atteso tanto… ed ora che il momento era venuto, colpito a tradimento alle spalle, doveva languire, spegnersi così… come uno dei tanti moccoletti, che nella sua stamberga, priva di luce elettrica, attraverso la sua vita, aveva veduto gradatamente consumarsi e morire.
Sentiva la sua vita abbandonarlo mentre il cervello continuava a compiere la sua funzione di cassaforte dei ricordi.
Quanta tristezza nelle cose in declino! Quanta solitudine aveva provato nelle serate invernali al fioco lume del mozzicone di candela che faceva ballare le immagini sul bianco, sporco muro dello stambugio ove andava a rannicchiarsi dopo una inutile serata di sospir passata nella osteria di Antò e nel caffè di Giulio in Piazza del Comune.
Dio, quanti ricordi. Prosperi il “daziere” col suo atteggiamento “ducesco” dopo una serie di bevute di quelle a “occhio di grillo”… e Peruzzi con le sue poesie anarchiche borbottate in sordina e i racconti delle sue geniali trovate per rimediare i “bochi” per il “goto” nel vano tentativo di affogare nel vino il ricordo della sua tremenda miseria, la malattia della moglie e la sua numerosa ed affamata prole… e “Richetu” che narra con arguzia le sue prodezze per prendere a gabbio gli imbecilli… tra un fraterno passaggio di “cicche” un piccolo coro gorgoglia sommesso,… in barba al pizzicato che vigilante sulle libertà fasciste anziché gironzolare per i vicoli del popolare rione in caccia di chi cospira contro il regime, forse dorme nel suo letto sognando dopo trent’ anni i gradi di “appuntato”.
… il canto, in sordina, contiene il racconto di tutte le sofferenze del popolo e la fiducia in un mondo migliore che necessita guadagnarsi lottando.
Ormai fuori la notte è completa. Una fioca luce bluastra scende blandamente da una lampada fissata al soffitto, senza portare alcun segno di vita. Lontano il rombo di esplosioni che fanno crollare case ormai vuote della città di Ancona, quasi completamente evacuata. La guerra fa strage di uomini e di cose.
L’interno e l’esterno s’intonano al freddo dramma che grava opprimente… allucinante……”Arrivederci maschere pagate, arrivederci sulle barricate!”… che cosa faranno i compagni a quest’ora?! Perché non vengono con il carro armato? Me lo hanno promesso!
Non voglio attendere la morte così per vent’anni abbiamo lottato con la certezza che l’ora che volge sarebbe venuta. Perché beffarmi così?! Morir combattendo l’odiato nemico, possibilmente partecipare al lavoro di una nuova società, questo volevo e se non temessi di disturbare quei moribondi vorrei salutare la vita che rinasce cantando… cantando.
Alessandro Maggini
In queste memorie ho voluto inserire la testimonianza del giovane Renato Bramucci (Uliano) a dimostrazione dello stato di ignavia in cui il fascismo gettava i giovani operai. Nella memoria di Uliano si avverte che il tipo di vita offerto dal regime alla gioventù era respinto dai giovani in generale e dai giovani operai in particolare per l’opprimente peso di una inutile vita e si nota invece l’entusiasmo, il mordente, da cui sono presi non appena venivano a contatto con i nostri ideali.
Per il tipo di vita cospirativa a cui era obbligata l’organizzazione, numero degli aderenti può considerarsi alto, tenuto conto dell’estrema prudenza con cui dovevano muoversi per allargare i contatti, diffondere le proprie idee e quindi l’accettazione di nuovi aderenti. Per inciso dirò che la cronaca, a tutto onor dei giovani, non registra fatti dovuti alla leggerezza.
Dal 1939, epoca della ricostituzione della federazione giovanile comunista al 25 luglio 1943 non si sono avuti incidenti politici degni di nota, malgrado il giovanile entusiasmo con cui venivano assolti i compiti a loro affidati.
L’olocausto di Alessandro Maggini è di una purezza adamantina. Suonerebbe offesa ogni apprezzamento che sapesse anche lievemente di lenocinio.
Figlio di operai, studia con decisione, conoscendone il peso economico per la sua famiglia, che si ingegna di aiutare, cercando una occupazione non appena ottenuto il diploma. Viene in contatto con l’organizzazione clandestina, si fa notare per la sua serietà e, quando, vista l’adesione di moltigiovani si decide a dar vita all’organizzazione giovanile, egli viene prescelto per essere tra coloro che costituiranno il comitato provinciale.
Si riuniscono: Aldo Pelliccia, studente liceale; Luigi Acrosso, studente liceale; Renato Bramucci, operaio cantiere navale; Adelmo Matteucci, operaio cantiere navale, Alessandro Maggini, diplomato.
Egli gode già la fiducia e la stima dei suoi compagni e pertanto viene eletto segretario responsabile e si distinguerà per il suo coraggio fatto di oculatezza e di prudenza.
Poi ecco il 25 luglio e 1’8 settembre 1943 e l’organizzazione nel suo complesso entra nella Resistenza. Come altri giovani, Alessandro Maggini partecipa ad un corso per Commissari Politici dopo di che raggiunge una zona dove si è costituito un distaccamento partigiano composto di operai, contadini, studenti e perfino di un ex maresciallo, dei carabinieri: Onelio Manoni.
La zona dove opera il suo distaccamento comprende una serie di paesi che vanno da Ostra, Belvedere Ostrense, giù sino a Senigallia, zona che per il nostro partito è stata affidata al compagno Alberto Zavatti entrato nella nostra organizzazione fin dall’agosto 1937.
Fino alla fine del gennaio 1944, il distaccamento composto di una trentina di elementi, si era limitato al recupero delle armi da guerra e da caccia in caserme abbandonate o quasi, all’ arruolamento dei giovani che volevano sottrarsi alla chiamata alle armi e alle minacce di morte dei repubblichini e dei tedeschi. Il distaccamento aveva provveduto al “prelievo non autorizzato” di un’auto di proprietà di un “seniore” della m.v.s.n,.munito di salvacondotto tedesco, auto che era stata consegnata poi al Comandante Gino Tommasi per i servizi del suo Comando. La stessa con la quale eravamo stati i giorni 6 e 7 a Pesaro.
Secondo una regola della guerriglia, il partigiano ancora prima di colpire deve assicurarsi la ritirata che, sotto un certo profilo, costituisce l’unica sua difesa e poiché la zona, priva di grandi città, di foreste o di montagne, può essere adatta a squadre gappiste, ma non a distaccamenti numerosi, pertanto “stava arroccandosi” in ordine sparso quando Pietro Brutti, Comandante, operaio, Amedeo Calassi,
Vice, contadino, Alessandro Maggini, Commissario Politico, studente, vengono sorpresi dai militi repubblichini.
All’alba i tre giovani vengono condotti sotto le mura di Ostra. Sanno che vanno a morire… Cantano “La giovine Guardia”. Un inno rivoluzionario. Una canzone che indica il motivo ideale della loro azione: una società nuova, diversa, nuovi rapporti di produzione, di libertà e di giustizia.
È con questa visione negli occhi, nella coscienza, il tutto il loro essere, che marciano verso gli ultimi istanti della loro giovane esistenza, non degnando di uno sguardo i loro assassini. Di certo sentono di far parte di quella “Guardia Rossa” che da Stalingrado sta inseguendo i nazifascismi in fuga, verso il cuore dell’Europa, essi, i morituri, sanno di essere i vincitori.
Non potrebbe essere diverso, perché in loro è la convinzione che stanno costruendo la sognata società di eguali, una società senza sfruttati.
Alcuni episodi con un pò di paura
A seguito dell’azione al carcere di Macerata per eventualmente liberare il compagno Gino Tommasi, il compagno Rodolfo Sarti “Ernesto” ha dovuto lasciare il suo posto di dirigente l’organizzazione provinciale del nostro partito, al suo posto provvediamo ad inviare il compagno Augusto Dino Carelli di Ancona, insieme ad altri due compagni trai quali Pasquini di Senigallia.
Poco dopo la notizia dell’arresto di Tommasi, con un camion militare in nostro possesso, carichiamo tutto il materiale della tipografia e ci trasferiamo nella frazione anconetana di Sappanico, abbandonando, per il momento, totalmente il Borghetto.
Sappanico dista 7-8 chilometri da Ancona, situata su di un’altura a circa 200 metri sul mare, si trova a cavallo tra la via Flaminia al nord e la via Adriatica al sud. Ci si può muovere in un senso o nell’altro senza dover attraversare Ancona. Abitata da lavoratori edili, prevalentemente compagni, è il luogo più adatto per portarvi la tipografia e il punto di contatto della nostra organizzazione.
In questa frazione organizziamo una piccola officina per la riparazione delle biciclette che in quell’epoca erano gli unici mezzi di locomozione, oltre le gambe, dei partigiani. I compagni meccanici Guerrino Brasca e Amedeo Ferretti essendo di mestiere meccanici armaioli, provvedevano a dare un’occhiata oltre che ai mezzi di trasporto anche alle armi difettose. Non ricordo come, ma a disposizione vi era un certo quantitativo di pezzi di ricambio per cicli; così come presso un mezzadro avevamo accatastato sacchi di medicinali, in particolare sulfamidici, provenienti dallo stabilimento farmaceutico Angelini.
Con un certo quantitativo di stoffa di lana, proveniente forse dalle carceri giudiziarie di Ancona o dalla Casa di reclusione, un sarto, il compagno Petrini, provvedeva a confezionare abiti per i partigiani.
Ed è in questa frazione che subito dopo i primi bombardamenti di Ancona avevamo organizzato una specie di scuola per “Commissari politici” da avviare presso distaccamenti partigiani. Caratteristico il luogo dove studiavano e dormivano questi studenti: un locale occupato da casse da morto, pronte per l’uso che un falegname compagno teneva in deposito. La compagna Alma, provvedeva al vitto con gli alimenti che i compagni coniugi Ercole e Romagna Carletti riuscivano a rimediare nella campagna.
Già da tempo il “corso” era terminato, i giovani commissari politici erano stati avviati presso i rispettivi distaccamenti, i ragazzi che avevano raggiunto Sappanico per sfuggire all’arruolamento repubblichino erano stati avviati verso zone montagnose quando accadde il seguente episodio.
Qualche giorno prima due gruppi di partigiani, con un’ abile manovra erano riusciti a sottrarre dalla Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, undici casse di sigarette “Nazionali” e “Popolari” e ne avevano depositate nove presso una casa colonica alla periferia del paese. Il contadino aveva fatto sapere che non era in grado di tenere le nove casse di sigarette nella sua cascina per il timore che i tedeschi o i loro collaboratori, le rinvenissero con tutte le tremende conseguenze per lui e la sua famiglia, e che pertanto si provvedesse a riprenderle altrimenti avrebbe distrutto tutto.
Date le condizioni di allora, ogni attività civile sospesa, le sigarette non venivano distribuite agli spacci e questo tipo di merce era preziosa, necessaria per i combattenti. Bisognava recuperare subito le casse di sigarette prima che la paura, più che giustificata, inducesse il contadino a disfarsene.
Ma quel giorno non vi erano elementi disponibili. Chiamai un contadino della zona e gli dissi se era disposto a venire con me a prelevare le casse, Egli acconsentì. Prese un cavallo, lo attaccò ad un carretto e accompagnati dal partigiano Armando Mencucci, che ci precedeva in bicicletta, ci portammo sul posto dove le casse erano state depositate, e con l’aiuto del contadino, caricammo le casse sul carretto e via sulla strada da Chiaravalle conduce a Castelferretti.
Il compagno Mencucci ci precedeva, armato di rivoltella, io e il contadino seduti sulle casse, che avendo le proporzioni di un metro cubo formavano un’alta piramide, avevamo coperto il tutto con delle coperte. Poteva avere l’apparenza di un normale trasloco, in quei giorni molto diffusi dati i bombardamenti.
Era una giornata piena di sole e quel mattino percorremmo la strada nazionale per un tratto poi ci inoltrammo per la strada provinciale fino a superare Castelferretti, poi subito svolta a destra per la strada di campagna che conduce alle Casine di Paterno, per salire la rampa che porta al bivio di Montesicuro e finalmente a Sappanico.Eravamo felici di aver portato a termine senza inconvenienti l’impresa ma non parliamo della preoccupazione che mi aveva fatto compagnia per tutto il tragitto.
Da rilevare che il compagno contadino in caso di brutto incontro avrebbe dovuto dichiarare che egli era stato normalmente ingaggiato per un trasporto di merce di cui non sapeva la provenienza, quindi senza responsabilità. In quanta a me avevo commesso una leggerezza, non avrei dovuto andare, ma mi parveche l’obiettivo va-lesse la pena. Nascondemmo le casse in un intercapedine di un magazzino agricolo e le sigarette avviate ai distaccamenti in ragione di 200 pacchetti alla volta tramite le staffette che portavano la stampa o altre comunicazioni.
Alla fine delle operazioni partigiane, cioè quando rientrammo in Ancona liberata, nei locali della nostra organizzazione provinciale in via Caratatimi, avevamo ancora due sacchi di pacchetti di sigarette che man venivano distribuite ai compagni anche se già era iniziata l’inflazione delle sigarette americane.
Nota umoristica: mandavamo sigarette anche ai distaccamenti nella regione. La staffetta, Stefano di Osimo, al ritorno da una missione dal compagno Coleffi di Porto S. Giorgio, al quale aveva portato stampa e sigarette, riferisce che il compagno Coleffi desidera non le sigarette “Nazionali” ma preferisce le “Serraglio”.
Qualche giorno dopo stavo tornando da una missione in provincia, avevo lasciato il bivio del Pinocchio avviato verso Sappanico, quando giunto al bivio delle Casine di Paterno, vedo scendere e venire verso di me un camion carico di “camicie nere”.
Sono a meno di 500 metri da Sappanico e sto salendo l’erta spingendo, a piedi, la bicicletta.
Penso: «Se mi riconoscono sono fritto!».
Il camion mi raggiunge, mi supera, percorre una decina di metri e…sento il caratteristico rumore di una violenta frenata… continuo a pensare: «Mi hanno riconosciuto!». Depongo la bicicletta sul greppo e mi arrampico su esso entrando nel campo, privo di siepe, e mi inoltro sul campo brullo, privo di alberi, pertanto completamente allo scoperto.
Intanto il camion fa marcia indietro, il che mi convince che perlomeno vogliono sapere chi sono e dove vado. Il camion pieno di fascisti, torna indietro per una decina di metri e si arresta, la paura mi fa credere che i fascisti stiano saltando già dall’automezzo e stiano per gridarmi: «Fermati!» e magari inizieranno una sparatoria… e invece è evidente che avendo sbagliato strada, cioè anziché andare per il Pinocchio la loro strada è quella per le Casine di Paterno, hanno dovuto fare la manovra che mi ha tanto impaurito e fatto ritenere di essere giunto alla mia ultima ora.
Scendo il greppo, afferro la bicicletta e arranco per la salita affannosamente e finalmente mi getto dentro il “buco” dando un sospiro di sollievo, pur non essendo completamente al sicuro.
Dopo quest’ultimo episodio, passa qualche giorno in relativa calma. Ha fatto appena giorno, sono nella stalla della casa colonica dove sono nascoste le casse di sigarette e sto esaminando con Corinaldesi la bozza di un articolo da dare alla stampa clandestina. Ad un tratto cominciano a crepitare colpi di fucile. Tendiamo gli orecchi, usciamo sull’aia, e dobbiamo credere di essere al centro di rastrellamento repubblichino. I diversi gruppi di fascisti stanno rastrellando il perimetro Candia, Sappanico, Montesicuro e la sua vallata.
Sfortunatamente ci troviamo “nell’ occhio del ciclone”. È evidente che noi non possiamo farci trovare nella casa di questo contadino. Ci inoltriamo nella campagna. Corinaldesi sulla cuticagna ha dei capelli eccessivamente rossi, su questi tiene un copricapo, una specie di colbacco nero, è visibilissimo da chilometri di distanza. Camminiamo in mezzo ad un campo da poco seminato contornato da alberi, sentiamo i colpi di fucile sempre più vicini, incontriamo una casa colonica, il cui forno è pieno di medicinali per i partigiani e sotto un pagliaio sono nascoste numerose cane di mitragliatrice per ricambio.
La famiglia colonica è sull’aia, capiscono il pericolo che corriamo, ci invitano ad entraree salire sul solaio e nasconderci lì. Effettivamente non abbiamo altra alternativa, salvo quella di andare incontro ai militi con la speranza che non conoscendoci ci prendano per sfollati. Corinaldesi è sconosciuto alla polizia e io potrei sperare di incontrare fascisti che non mi conoscono. Finiamo con l’accettare l’ospitalità e saliamo nel solaio. Qui troviamo che c’è già un’altro che si nasconde: un soldato. Trattenendo il respiro ascoltiamo quello che succede al pianterreno, sentiamo l’arrivo dei fascisti che scambiano parole ospitali con i repubblichini, sentiamo scricchiolare la scala di legno che conduce al solaio, ci immaginiamo di vedere spuntare la testa del milite dalla “boccaporta”, alcuni attimi di profondo silenzio, poi rumori che indicano che stanno ridiscendendo le scale e poco dopo i fascisti se ne vanno.
E’ accaduto che solaio è diviso in due parti perché la casa ospita due famiglie coloni che con il rispettivo solaio e la “camicia nera” mandata a controllare se nessuno fosse nel solaio si è limitata a fare capolinodalla boccaporta dall’altra parte del solaio, senza approfondire l’indagine, consigliata, forse anche da una certa preoccupazione.
Guardo “Barbadirame”, abbozzo un sorrisino come perdire: “Anche stavolta è andata bene” .Ho i nervi a fior di pelle, si vede che non ho la stoffa dell’eroe. Ringraziamo i contadini e poco dopo riprendiamo ilnostro lavoro.
Dopo quest’ultimo episodio comincio a pensare che Sappanico non fa più per noi. Si tratta di trasportare in luogo più sicuro le sigarette, i medicinali che ogni giorno diminuiscono perché avviati ai distaccamenti e soprattutto trovare un “buco stampa” per la tipografia.
Stiamo discutendo su questo arduo problema io e Corinaldesi quando improvvisamente due tedeschi, cavalcando una motocicletta, irrompono nell’aia e si fermano. Un gruppo di partigiani, che si trovano ai bordi dell’aia, fanno un salto, scompaiono nella vegetazione e vi si acquattano.
Io e “Barbadirame” siamo troppo vicini all’automobile già pronta a partire e non vogliamo dare la sensazione di voler andarcene e pertanto rimaniamo immobili come statue.
I due tedeschi si guardano attorno, puntellano la moto, si avvicinano alla nostra auto (che è quella sottratta al console) e senza fiatare, tentano di sbirciare all’interno, ma non ci riescono, comunque le cose più importanti sono nascoste sotto delle pezze di stoffa. Loro non dicono niente, noi zitti,in quel mentre il contadino si affaccia e dice qualche cosa, e allora l’incanto finisce e comprendiamo che sono alla ricerca delle uova. Così dicono.
Noi continuiamo a star muti e a guardare la scena, ed è forse questo atteggiamento passivo che induce questi nazisti a prendere le uova, pagarle, inforcare la moto e filare. Credo che questa volta siano stati loro a provare un po’ di … “fifa”.
Non mettiamo tempo in mezzo, saliamo in auto e via. Ognuno sa quello che deve fare. Ci rechiamo a Loreto e qui ci informano che i tedeschi hanno arrestato alcuni compagni tra cui Catalini e Muratori. Hanno preso anche Francesco Vivani a Osimo, Orfeo Massarenti a Camerano. Filiamo ancora permezza provincia, rasentiamo
Osimo, Agugliano, Cassero e senza brutti incontri raggiungiamo il “buco” di Castelferretti dove nascondiamo definitivamente l’auto ormai inservibile e mentre la nuova sede della tipografia sarà la casa di un compagno a ‘Passo Varano, la segreteria verrà organizzata all’Aspio di Ancona, località che raggiungo in bicicletta, dove il compagno Irno Rumori ha già provveduto a crearmi un certo ambiente.
La speranza è dura a morire
Necessitava creare le condizioni per ospitare feriti, malati, fuggiaschi, staffette, luoghi per appuntamenti, per incontri, per recapiti politici e militari.
In un raggio di cinque chilometri intorno alla località Aspio, assoluta proibizione di prendere parte ad azioni partigiane, dobbiamo fare in modo che la zona rimanga tranquilla e non sottoposta a rastrellamenti tedeschi e fascisti.
La zona dell’Aspio ospita il Comando della divisione partigiana, la segreteria della nostra organizzazione, l’amministrazione, ecc. E soprattutto perché la tipografia si è installata con tutto l’apparato due chilometri lontano dall’Aspio, cioè nella vicina frazione di Passo Varano. Inoltre all’Aspio organizzammo luoghi dove gli ospiti potessero rifocillarsi, riposare,ecc. Per questi compiti avevamo a disposizione alcune case coloniche e alcune stanzette di una piccola località vicino allo stabilimento di acque termali.
La tipografia nel febbraio 1944 ha cessato la pubblicazione del periodico “L’Aurora” e nel mese di marzo stampa il periodico con la Nuova testata “Bandiera Rossa”e continua a ristampare “Il Combattente” di cui unacopia ci giunge dall’Alta Italia. Questa stampa ha carattere regionale pertanto la responsabilità politica spetta a “Marco” (Egisto Cappellini) al quale spetta anche la responsabilità dei contatti con il centro del partito: quelli con la “Francia” (Luigi Ruggeri) che rappresenta il P.C.I. nel C.L.N. regionale e con il compagno “Alberti” (Alessandro Vaia) nuovo comandante del gruppo divisioni “Garibaldi”. A “Marco” spetta pure di tenere i contatti con i responsabili provinciali del partito: Macerata “Ezio” (Augusto Dino Carelli); io per la provincia di Ancona e Mario Bestini per la provincia di Pesaro-Urbino.
Naturalmente collaboro con lui in ogni campo. Dopo la morte di Fastiggi che viene sostituito da Mario Bestini, “Marco” mi comunica che egli, Bertini ed io costituiamo il Triunvirato insurrezionale delle Marche.
Sono spesso in contatto con i compagni che vengono nella zona per prelevare le sigarette, stampa,notizie, ecc. Pertanto ci sono anche scambi impressioni su quello che accade e sulle prospettive a venire. È naturale che l’argomento principale delle conversazioni è su quale sarà la situazione a fine guerra I nostri compagni appartengono tutti alla classe lavoratrice e pertanto non possono fare a meno a meno di pensare ai loro interessi di classe. Il senno del poi, lo sappiamo, non conta e inoltre a me preme scrivere il vero, ciò che veramente costituiva il nostro obiettivo, anche se poi risulterà irraggiungibile, anche se poi, quasi senza avvedercene sarà la realtà che si presenterà ogni giorno ad indurci a rettificare il tiro.
Saranno gli episodi ai quali partecipiamo a farci sentire ogni giorno di più come la battaglia nella quale siamo fortemente impegnati, non si concluderà con il realizzo integrale delle nostre speranze. Noi siamo immersi fino al collo in questa lotta e non possiamo, né vogliamo sottrarci ad essa, sperando di salvare il salvabile e non deludere, almeno in parte, le aspettative dei compagni che ci guardano (se ancora non sono morti) ed hanno fiducia in noi.
Ripeto, la nostra lotta era da sempre diretta contro il capitalismo tra l’altro responsabile anche del fascismo, mentre le armate anglo-americane sbarcate in Sicilia e ormai anche in Calabria certamente nell’intendimento dei comandi al vertice era di combattere il gruppo capitalista concorrente ma nonfino al punto di favorire la presa del potere da parte dei comunisti o comunque delle forze popolari.
Tale era il nostro modo di pensare, d’altra parte era umano che ci si ponesse l’interrogativo: se i rapporti di produzione dovranno rimanere quelli capitalisti perché rischiare la morte? Non rinunciamo a sperare. Non nascondo che eravamo terribilmente influenzati dalle magnifiche vittorie ottenute dalla Armata Rossa che andava avvicinandosi al cuore dell’Europa.
La nostra organizzazione non era nata nel 1942/43 come tante altre dopo Stalingrado, quando incominciava ad essere evidente che ormai per i nazisti era soltanto questione di tempo. La nostra organizzazione era nata nel 1923 in collegamento con i compagni che nel 1921 avevano dato vita al Partito Comunista e il nostro impegno era essenzialmente anticapitalista, socialista e per questo intento avevamo lottato per 20 anni.
Eravamo illusi? Eppure gli operai di Milano il 25 aprile 1945 insorsero al canto di “Bandiera Rossa”, canzone questa che è tutto un programma e dire che gli operai dell’Alta Italia avevano avuto ben nove mesi più di noi anconetani, che ci siamo liberati (per modo di dire) il 19 luglio 1944, per riflettere sul reale significato della presenza degli Alleati in Italia.
Quanto precede per convincere che la situazione che non avevamo potuto o saputo prevedere non poteva essere “digerita” in un sol giorno e rimane il fatto che invece lo fu nel tempo e senza dar luogo ad incidentidi sorta o comunque degni di nota il che significa che si era in grado di capirel’evolversi delle condizioni.
Non avrei scritto su questo argomento se “Bandiera Rossa”, organo della Federazione provinciale anconetana del P.C.I., il 22 dicembre 1944 nel riportare una lezione fatta da Egisto Cappellini alla prima conferenza d’organizzazione del partito non avesse riferito quanto segue: «… nei contatti con il Maderloni, riconosce accanto a qualche difetto organizzativo e negli atteggiamenti rivoluzionaristici, la buona volontà, la capacità,la dedizione al partito la disposizione all’autocriticarsi e a correggersi».
”Attegiamenti rivoluzionistici”, frase di un contenuto misterioso fino al punto che, vent’anni dopo studiosi, scrittori, ecc. sulla base di questa dichiarazione si mettono alla di documenti, notizie, testimonianze, per individuare in che misura “erano presenti e vivi, attivi,fermenti polemici di tipo insurrezionale e rivoluzionario: fino a che punto i portatori di questi fermenti ne fossero consapevoli è difficile dire”.
Come ho scritto, non ho cercato di nascondere che fino ad un certo punto compagni di base o dirigenti erano convinti che il capitalismo italiano avrebbe pagato il fatto di aver creato il fascismo e che con il crollo del regime avremmo avuto la possibilità di iniziare l’avvio verso una società socialista.
Il capitalismo internazionale ci preoccupava. Dalla storia avevamo appreso quanta solidarietà trova all’estero la classe dirigente nelle fasi di crisi e di decadenza. A tentare di fermare la ruota della storia ci hanno provato tute le classi che non volevano essere spodestate dalla nuova classe apportatrice di nuovi rapporti e mezzi di produzione e come è noto oggi un terzo del mondo è socialista.
E noi abbiamo sperato fino al 12 luglio 1943 e continuammo a sperare anche dopo pur non facendoci soverchie illusioni e ci mettemmo in linea.
E a sperare sino a quel giorno e anche dopo che avremmo avuto la possibilità di creare una società priva di sfruttatori non eravamo solo noi anconetani, poveri tapini, se, oggi 3 settembre 1973, nella quinta pagina de L’Unità, si può leggere l’articolo “Momenti di storia del P.C.I. nelle parole dei protagonisti.
Alla compagna Bavera è stato chiesto di chiarire le radici del dibattito che aprì a Ventotene tra i confinati comunisti. «Fu un confronto duro, con momenti molto amari per me» ha detto Camilla Ravera «e che si concluse purtroppo in modo errato» L’approdo fu l’espulsione della stessa Ravera e delcompagno Terracini.
Il contrasto investiva il giudizio sulla situazione internazionale e italiana, e sui possibili sviluppi: il gruppo che in quel momento costituiva la maggioranza era dell’opinione che il fascismo avrebbe potuto essere immediatamente sostituito da un potere socialista. Mentre la Ravera ed altri sostenevano l’esigenza di un largo schieramento di forze attorno alla classe operaia per porsi come primo obiettivo il problema istituzionale, abbattere il fascismo e avviare poi il processo di costruzione di una nuova società con tutte le forze popolari.
Quindi bisogna convenire che eravamo in buona compagnia a sperare di poter bruciare le tappe così come non era facile avere idee chiare sempre a causa del rapi-do succedersi degli avvenimenti.
Rimane giusto il concetto con cui si chiude l’articolo de “l’Unità”: «Per capire quei momenti occorre inquadrarli nella situazione in cui si svilupparono» .
Una parentesi (che ci vuole)
È dimostrato che non siamo vogliosi di essere messi in evidenza, comunque, per un senso di giustizia, m’interessa mettere in rilievo il fatto che malgrado tutta l’attività data da centinaia di compagni nella città e nella provincia di Ancona in tutto il “ventennio”, tale attività non ha trovato posto, spazio, per essere esposta, sia pure nei modesti limiti come modesti sono i suoi protagonisti, nei quattro volumi della Storia del Partito Comunista Italiano, di Paolo Spriano. Non posso fare carico a Paolo Spriano se i membri dell’organizzazione comunista clandestina non hanno voluto scrivere sulla partecipazione alla lotta contro il fascismo. E quando mancano le testimonianze dirette succedono le cose che dico appresso.
Nel IV volume della Storia del PCI di Spriano a pag. 310 si riporta che un gruppo di vecchi comunisti, guidati dal tranviere Raffaele
Maderloni ad Ancona, si trovano in disaccordo con le indicazioni del partito sostenute da altro gruppo, guidato da Mario Zingaretti (reduce dal confino) è notizia in uno studio particolare. «Ermenegildo Catalini uno dei più autorevoli del gruppo Maderloni era solito rispondere: oggi sulla breccia ci sono solo i comunisti e noi non vogliamo valorizzare altre forze” ( P. Giannotti, Stampa operaia e classi sociali nella lotta clandestina, Urbino, 1972, pp. 38-37).
E’ evidente che si insiste nel presentare la nostra organizzazione come refrattaria ad accettare una politica di unità antifascista, di alleanza con forze democratiche borghesi. Mi sembra di essere stato chiaro in proposito. Però aggiungo che per fare una politica di alleanze necessita che ci siano “altri” disposti ad accettare la nostra alleanza. A meno che per alleanza non si voglia intendere subordinazione, resa a discrezione. Inoltre penso che per “altri” debba intendersi forze organizzate e non alcuni singoli che rappresentano solo se stessi o giù di lì. Ci siamo alleati con tutti coloro che volevano combattere il fascismo, li abbiamo cercati, li abbiamo trovati e ci siamo uniti. Ripeto che ci siamo alleati con tutti coloro che volevano combattere il fascismo, ma bisogna dire che è difficile fare una giusta politica di alleanza con chi prima di essere antifascista era anticomunista. E penso a:
– l’episodio di liberare i fascisti arrestati l’8 settembre 1943;
– l’articolo sul “Corriere Adriatico” scritto da ex squadristi fascisti apparso con il beneplacito di Oddo Marinelli del movimento G.L. con un suo commento favorevole;
– l’apparizione di volantini anticomunisti lanciati a Falconara ad opera di…amici;
– tentativi di impadronirsi della direzione militare delle “Brigate Garibaldi;
– la tendenza ad indurre i partigiani a non provocare i nazifascisti, ad attendere la pace, l’arrivo degli alleati;
– il misterioso arresto del compagno Gino Tommasi, ecc.
Comunque siamo andati avanti, questa è la verità.
Una proposta di trasferimento
La piccola frazione dell’Aspio di Ancona era diventata una zona dove intensa si sviluppava l’attività del partito e partigiana. Vi convenivano partigiani, compagni che avevano compiti di responsabilità politica, rappresentanti del C.L.N. periferici, commissari politici, responsabili di zona.
All’Aspio convennero oltre a “Marco” ed “Alberti” anche “Ilio” (Dario Barontini). Questi venne messo a contatto con “Rifo” (Fabrizi) e Pero. Il primo diplomato in chimica e il secondo operaio specializzato. Questi dovevano essere addestrati alla preparazione di “bottiglie Molotov”,
Un mese prima della liberazione di Ancona giunsero “Armando” (Aristodemo Maniera) e “Dell’Acqua” (Grilli), inviati dal Comando del C.L.N.A.I. Nel giugno 1944, accompagnato dal responsabile regionale “Marco” giunse all’ Aspio un ispettore del “Centro del Partito”, il compagno “Nello”, al secolo Giuseppe Rossi.
Il compagno “Nello” chiese notizie su tutto, volle essere informato di ogni cosa, poi partì per un giro in provincia e nella regione,
tornò dopo alcuni giorni e riprendemmo il colloquio.
Ad un certo momento mi propone il trasferimento in altra regione. Lo guardo stupefatto, poi gli dico che ormai è questione di giorni la liberazione della nostra regione, poi gli chiedo il perché di questo trasferimento. Mi risponde: «Perché un compagno come te per farlo occorrono vent’anni e qui se ti prendono ti ammazzano. Tu sai perché ti è stato proibito di camminare armato?».
Obbietto che conosco la mia provincia e non vedo di quale utilità potrei essere in una provincia che non conosco.
Ribatte: «Sì, ma una volta studiato l’ambiente guadagneresti il tempo iniziale!».
Gli propongo un patto: se entro un mese Ancona non sarà stata liberata, cioè se la guerra continuerà a stagnare sul fronte attuale, potrò prendere in esame la proposta di trasferimento.
Ho rivisto il compagno Giuseppe Rossi nel 1947 in occasione di una sua conferenza al teatro Goldoni di Ancona, membro del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano.
Gli ultimi episodi
Dall’8 settembre 1943 al 18 luglio 1944 sono trascorsi dieci mesi durante i quali braccato dalla polizia fascista e dalle S.S. tedesche, mi sono trovato qualche volta in difficoltà ma, diciamo così, la fortuna mi ha aiutato. I tedeschi mi hanno avuto due volte nelle loro mani, ma non erano S.S” erano soldati di linea e, per fortuna, non sapevano chi io fossi.
Siamo nel giugno 1944, la linea del fronte sta avvicinandosi alla provincia di Ancona. I tedeschi si sforzano di difendere la loro posizione a Filotrano, sguarniscono Osimo evacuandola. In questa cittadina si riunisce il C.L.N per designare gli uomini che dovranno assumere cariche pubbliche in Ancona liberata.
Intanto le autorità della Resistenza armata fanno carcerare un certo numero di fascisti repubblichini. Si è già stabilito che la carica di Prefetto di Ancona andrà all’avv. Oddo Marinelli, repubblicano G.L., la carica di Questore sarà assunta dal compagno Eugenio Monti, si sta si sta discutendo ancora quando giunge la notizia che, chiamati dai familiari dei fascisti arrestati, i tedeschi stanno ritornando ad Osimo.
Ora tocca a noi filare via al più presto. Inforco la bici e scendo la via che conduce all’Aspio, ma scorgo soldati tedeschi che occupano la sede stradale in vicinanza di un piccolo ponte. Scendo, nascondo la bici, entro in un cannetto e mi siedo dietro un pagliaio vicino ad una casa colonica, quasi sul limite della strada. Spero che i soldati si avviino verso Osimo lasciando libera la strada, ma ad un tratto sento una mano afferrarmi un braccio, rimango calmo, in silenzio, mi volto e fisso senza parlare il viso il viso imberbe di un tedesco, che mi fa cenno di seguirlo.
Poco dopo sono di fronte ad un ufficiale che mi interroga. Sono un operaio sfollato da Ancona, sono tbc, abito in quella casa laggiù in fondo, sto prendendo un poco d’aria buona. Tossisco, sputo in un fazzoletto, guardo lo sputo con grande attenzione come preoccupato di trovarvi ramette di sangue. Non serve e indicandomi un piccone mi invita a fare una buca a terra che dovrebbe servire per collocarci una mina da far brillare prima di ritirarsi.
Sto facendo del mio meglio quando un vocio mi fa alzare la testa e vedo il neo eletto Questore di Ancona compagno Monti che, infischiandosi dei tedeschi, scende con la sua bici, a grande velocità e in un baleno è fuori dalla vista e dai fucili dei nazi.
Non sono più solo perché i tedeschi rastrellano le case coloniche in cerca di “zappalori” come me. Uno dei “fermati” è una staffetta che viene dal fronte con un messaggio per il Comando, vuole passarlo a me, lo accetto e lo infilo tra le calze. Poi comincio a tossire, scatarrare e chiedo all’ufficiale di andarmene, facendogli rilevare la mia magrezza veramente notevole. Questa volta acconsente.
Torno nel canneto, inforco la bicicletta e approfitto del fatto che in quel mentre i tedeschi hanno fermato nientedimeno che il Comandante “Alberti” per fargli continuare a fare la buca; egli vi si adatta di buon grado per poter poi dare ordini più precisi ai partigiani per il disinnesco delle mine ed evitare la distruzione del manufatto.
Qualche giorno dopo in bicicletta e con una piccola valigia mi sto dirigendo dall’Aspio verso Passo di Varano. Nell’ultimo incontro con “Marco” si è stabilito che egli ed altri compagni, passeranno il fronte per andare in zona liberata ed affrontare i problemi dell’organizzazione del partito. Il fronte sta avvicinandosi e non bisogna farsi sorprendere dalle compagnie di guastatori, rotti a tutte le violenze.
Ho appena lasciato la strada statale 16, mi sono inoltrato in una strada laterale che un soldato tedesco mi intima di fermarmi, io continuo a pedalare, ma un gruppo di contadini mi avverte che il soldato sta prendendo la mira con il suo fucile… Mi fermo, depongo la bicicletta nella fratta, lascio scivolare la valigetta nel fossato e mi avvio verso il soldato, ma costui mi fa cenno che devo tornare indietro con la bicicletta (è una bici fuori serie “Gloria Garibaldina”, proprietà di Luigi Ruggeri, pesa soltanto 6 chili e mezzo, non ha mai forato, in montagna la mettevo sulle spalle).
Torno indietro, comincia col togliermi gli occhialida sole (Salmoiraghi) poi vuole l’orologio da polso (che è di mio cognato Enrico Ciasca) poi mi toglie la bici perché, dice, vuol farne un dono al suo comandante. Sono disarmato, non so se vi sono altri tedeschi vicino, protesto, poi capisco che è meglio che me ne vada e lo lascio al suo posto di predone.
19 luglio 1944 – Liberazione di Ancona
Qualche giorno dopo questo ultimo episodio, precedendo di alcune centinaia di metri avanguardie polacche del Generale Anders, per correndo Passo di Varano, Tavernelle, Grazie, “Grasciari”, via Canale, via Montebello dove stanno. ad attendere i partigiani che non avevano mai abbandonata Ancona.
I compagni delle cellule del Cantiere Navale, dei Vigili del Fuoco e dell’ospedale civile, avevano preparato anche i locali per la federazione del nostro partito e per-tanto ci installammo in via Calatafimi.
Purtroppo i sacrifici compiuti in tanti anni di lotta avevano sì contribuito a far cadere il regime fascista ma non a modificare la condizione della classe operaia. Fin dalle primissime ore della liberazione, la realtà confermava giusti i nostri giudizi negativi già espressi.
Avevamo già avuto durante la latta partigiana della riluttanza degli emissari anglo-americani ad avere rapporti con i resistenti comunisti, così come ci era giunta notizia che gli Alleati avevano abbandonato il paese di Sirolo alle rappresaglie dei tedeschi che tornando avevano sfogato sui cittadini la loro rabbia per le accoglienze che essi avevano riservato alle truppe liberatrici.Eravamo convinti che la lentezza delle operazioni belliche da parte degli Alleati, fosse uno stratagemma per non favorire i partigiani comunisti impegnati a fondo nella guerriglia contro i nazifascisti e con ciò ci spiegavamo la scarsità dei lanci dagli aerei.
Altri fatti furono:
– l’immediato disarmo di tutti i partigiani;
– l’odio contro i fazzoletti rossi al collo dei garibaldini;
– la proibizione di uscire dal perimetro della città senza il permesso delle autorità alleate per i dirigenti comunisti;
– la “requisizione” “manu militare” di tre auto civili in possesso della federazione comunista;
– violenze esercitate dai militari polacchi di Anders ai danni di militanti e sezioni del partito comunista;
– la pretesa delle autorità militari alleate di non autorizzare la stampa e la diffusione del giornale “Bandiera Rossa” organo della nostra federazione con la scusa che non avevano carta da fornirci, carta che però noi non chiedevamo.
E poiché non potevamo tener conto della mancata autorizzazione (che non avevamo chiesto, come non avevamo fatto con i tedeschi), in quanto “Bandiera Rossa” era stampata e diffusa anche sotto la dominazione nazista, il nostro periodico continuò ad uscire con la conseguenza che in 20 giorni, per ben due volte venne dato l’ordine al Questore dr. Luigi Russa, di “fermarmi” e condurmi dinanzi al TawnMajor, quale segretario della federazione comunista e sentirmi accusare, tramite una interprete di essere “un cattivo democratico”.
Respingono la decisione del C.L.N. per la nomina a Questore del compagno Eugenio Monti, mentre non fanno obiezione per quella a Prefetto di Oddo Marinelli. Evidentemente gli Alleati conoscono il “curriculum”dei proposti alle cariche pubbliche e sanno che il Marinelli ha già esperienza di amministratore in quanto ha già fatto parte della Giunta comunale repubblicana di Ancona nel 1922 con la carica di “Pro sindaco” (Amministrazione comunale che purtroppo non terminò il sua man-dato perché il sindaco repubblicano Domenico Pacetti, all’invasione fascista preferì andare incontro alle orde squadriste e a Porta Pia,simbolicamente, consegnò le chiavi della città).
È indicato come rappresentante dell’antifascismo moderato e borghese e nella seconda decade del settembre 1943 tenta di addolcire l’attrito tra fascisti ed antifascisti, appoggiando la richiesta di liberare i fascisti carcerati e fraternamente abbracciarci. All’arrivo dei tedeschi in Ancona si ritira nella sua villa sita in salita Pinocchio e non curante del rischio, per il fatto che i nazisti e repubblichini sappiano della sua attività e facciano della sua villa un comando militare, egli partecipa all’attività del C.L.N.; portandosi nei luoghi di riunione servendosi di un calesse trainato da un cavallo. È del parere di non dare troppi fastidi ai nazi per non subirne la reazione, perciò, giustamente, gli alleati lo premiano…
Quindi una serie di fatti che avevano tutta l’aria di provocazioni, come quella che avevamo incontrato nei difficili rapporti nei Comitati di Liberazione Nazionale, dove avevamo l’impressione che si cercassero pretesti per paralizzare l’attività della Resistenza, provocazioni tendenti a farci perdere la calma, farci commettere errori, per giustificare poi la loro reazione.
Era evidente che il principale obiettivo degli “alleati interni ed esterni” era la restaurazione della società capitalista e che vedevano nella organizzazione comunista un ostacolo ai loro piani e da ciò la necessità di ridurne l’efficienza e quindi l’influenza sui lavoratori.
Non potevamo non tener conto di questa realtà, quindi accettare la linea politica indicataci dagli organi centrali del partito, linea che giustamente, più tardi, il compagno Togliatti indicherà come la politica più conseguentemente rivoluzionaria, e pertanto non c’era che da continuare la lotta di classe per strappare sul piano democratico migliori condizioni di vita, una maggiore indipendenza economica e conseguentemente una più grande libertà politica.
Con la liberazione della città, mentre le ostilità belliche si allontanano verso il nord, migliaia di cittadini tentano di rientrare in
Ancona per reinserirsi nella vita civile e partecipare alle battaglie politiche. Il piccolo nucleo di compagni organizzatosi nel 1923 è divenuto dopo anni ed anni di cospirazione e dieci mesi di guerriglia, una forza non trascurabile. In questa lotta, l’organizzazione si è guadagnata prestigio e fiducia tra i lavoratori che a migliaia chiedono la tessera del partito comunista italiano. Errori certo se ne sono commessi, comunque l’organizzazione in tutto il lungo periodo della cospirazione politica e militare, ha certamente assolto, sia pure con difficoltà e alle volte con indecisione, ma pur sempre nella continuità, il suo ruolo di guida e di avanguardia della classe operaia e di tutti i lavorator
Missione compiuta
Dal 18 luglio1944, assolvo, finalmente, alla luce del sole la mia funzione di segretario provinciale del P.C.I. Mi convinco che la stessa funzione in periodi diversi comporta una diversa capacità.
Nella nuova vita sono necessarie qualità che nel periodo clandestino non bisognava assolutamente possedere. Per esempio se nel periodo cospirativo bisognava saper tacere (e non è facile) nel periodo – diciamo così – democratico, bisogna saper parlare in pubblico, in piazza, nei comizi, nelle assemblee, ecc. La funzione del responsabile provinciale, la funzione del responsabile non è facile neppure nei tempi normali, ma in quelli che stiamo attraversando è sommamente difficile a causa dei vent’anni di dittatura fascista e della guerra con i suoi 143 bombardamenti che ha sinistrato la città al 73%, la guerriglia, tutto a contribuito a distruggere il tessuto sociale.
Molti lavoratori stanchi della misera vita di “sfollati”, desiderano tornare alle loro case per immettersi nella produzione, ma le abitazioni sono rase al suolo, le fabbriche chiuse, i servizi pubblici (treni, autobus, tranvie, ecc.) fermi per mancanza di carburante. Le condizioni di paese liberato sono uguali a quelle di un paese occupato per ciò che riguarda la penuria di generi alimentari e quindi la “borsa nera” con tutte le degenerazioni che tale condizione comporta. C’è da ricostruire tutta la struttura di una società democratica ma non abbiamo strumenti politici, né economici perché tutto è in mano degli Alleati e dei… loro alleati che intendono ricostruire secondo un loro schema.
Sono diversi gli episodi da raccontare che caratterizzano l’epoca: i partigiani che vengono arrestati per azioni di guerra, i polacchi di Anders che convinti che finita la guerra contro la Germania dovrebbe aver inizio la guerra contro l’Unione Sovietica e intanto si allenano facendo violenze contro i comunisti italiani e le loro sezioni, le polemiche con i partiti e le organizzazioni di destra o alla sinistra del nostro partito, ecc. Inoltre mi rendevo conto che se nel periodo clandestino si doveva essere estremamente gelosi o ritrosi al cambio nei posti di responsabilità, che comportavano anche il passaggio di dati, nominativi segreti che dovevano essere gelosamente conservati, ora non solo era possibile ma diventava necessario aumentare il numero dei compagni dirigenti e farsi sostituire e mettere alla direzione delle attività provinciali elementi più preparati, con maggior cultura, con più grande esperienza.
Feci del mio meglio nei mesi di luglio, agosto, settembre 1944. Ai primi di ottobre, ad una riunione del comitato direttivo pregai i compagni di sollevarmi dalla carica perché, sostenni, ritenevo che il posto poteva essere tenuto con miglior risultato da A. Maniera che tornato in Ancona nel giugno 1944 dopo vent’ anni di assenza, non veniva utilizzato per quello che io allora ritenevo poteva esserlo.
Avrei potuto dare altre indicazioni ma il compagno Augusto Dino Carelli sin dal 1933 e con me aveva condiviso due anni tra carcere e confino, in quel momento assolveva li compito di segretario provinciale del partito a Macerata. Il compagno Gino Grilli, che con me aveva diviso la direzione dell’organizzazione, come Carelli, sin dal 1933 e con me aveva condiviso due anni tra carcere e confino, era stato fortemente ammalato comunque in quel periodo non era in condizioni di salute tali da consentirgli tale gravoso incarico. Il compagno Adelmo Pianelli (Agonia) era impegnato in qualità di Commissario Politico in un distaccamento partigiano al nord. Il compagno Pianelli aveva scontato circa otto anni di carcere e confino ed era noto per aver fatto dichiarazione di fede al comunismo nel 1932 al Tribunale Speciale.
Numerosi altri compagni erano del mio stesso calibro, operai con cultura elementare e per essi si stava preparando una scuola di partito; rimanevano i giovani e tra questi alcuni ben preparati ma era evidente chedovevano ancora farsi “le ossa” per incarichi come quello in discussione.
Avevo conosciuto Maniera nel 1924 in alcune attività di partito, poi era emigrato in Val d’Aosta. Lo vidi tornare nel giugno 1944 e lo riconobbi ad una riunione tra un cannetto all’Aspio, insieme a Cappellini e a Dell’Acqua. Era giunto dall’Alta Italia con un mandato per il Comando Divisione Garibaldi. Venne utilizzato dal Comandante “Alberti” che inviò tutti e due – Maniera e Dell’Acqua – verso il sud per raccogliere e far pervenire tramite staffette informazioni al Comando Divisione Garibaldi di stanza all’Aspio di Ancona.
Dopo la liberazione credo che venisse utilizzato sul piano regionale in un comitato che passata la guerra venne disciolto, lo vedevo spesso nella federazione anconetana e me lo spiegavo con il fatto che pur essendo il Maniera nativo di Castellamare Adriatico aveva studiato in Ancona dove appunto risiedeva nel 1923.Egli era assolutamente sconosciuto alla nostra organizzazione salvo per alcuni dirigenti avendolo io stesso ricordato nelle nostre conversazioni nel periodo clandestino. La proposta di sostituzione venne respinta dai compagni convinti che io avessi la capacità di continuare nel compito di segretario.
Ma io conoscevo meglio me stesso e il 21 ottobre posi con più forza il problema delle dimissioni, nel prendere la decisione ubbidii agli insegnamenti dei compagni nella dura scuola della lotta clandestina: autocritica, modestia, senso di responsabilità ed attaccamento al partito. Intesa l’organizzazione centrale, il comitato direttivo, anche se malvolentieri, dovette accettare la mia sostituzione con Maniera.
Questo mio modo di comportarmi dimostra in maniera lampante che era lontana da me ogni idea che potesse solleticare il mio amor proprio ed indurmi a tentare di sfruttare il mio passato e la nuova situazione, sottoponendomi ad una dura disciplina e prepararmi ad assolvere altri incarichi di maggior soddisfazione e meglio retribuiti. Non vi sarebbe stato nulla di strano, anzi sarebbe stato rendermi giustizia che facessi il possibile, nell’interesse del partito, elevare la mia capacità e anche per ripagare la mia famiglia, mia moglie, i miei figli Roberto e Uliano, per le sofferenze patite nel lungo periodo delle persecuzioni subite Sotto questo aspetto sinceramente sono stato un ingenuo, molto probabilmente altri si stavano preparando per combattere la loro battaglia, io comunque non ho mai dimenticato né ho cercato di dimenticare i modesti limiti della mia personalità, ed ora pago di quanto potevo dare di buono e di meglio al partito.
Prima considerazione
Da sempre, ma in particolare in questi ultimi decenni, lo spionaggio e il controspionaggio sono stati materia che ha interessato numerosi scrittori che si sono sbizzarriti, mescolando, talvolta, fantasia e realtà. Un fatto però è certo. Nella lotta tra “centrali” di spionaggio nemiche nessuna colpa può essere esclusa, tutto può essere usato per spiare, ma è assolutamente impossibile che una “centrale”, nell’atto di abbandonare un sua cava, lasci tra le sue scartoffie documenti importanti e soprattutto nomi singoli o elenchi di nomi dei propri agenti segreti, specialmente di quelli che lavorano nel campo nemico che tra l’altro hanno certamente nomi, sigle convenzionali. Potrà anche accadere che i nomi isolati, o elenchi di nomi di agenti segreti finiscano in possesso della centrale avversaria, ma certa non perché questi elenchi siano stati abbandonati come elementi di nessuna importanza. Infatti a distanza di trent’ anni dal crollo del regime fascista non è stata ancora possibile avere in mano, o perlomeno conoscere, l’elenco degli agenti dell’O.V.R.A. o di altre organizzazioni spionistiche del regime.
Nel caso specifico, in considerazione che la lotta politica sarebbe continuata, malgrado le vicissitudini del momento (anno 1944), come non mai, sarebbe stato nell’interesse della “centrale” che abbandonava la città, di non abbandonare nelle mani del nemico i nomi degli agenti a qualsiasi livello. Se poi, tra questi vi fosse stato il nome di un elemento che in rapporto ai fatti che andavano svolgendosi sul piano politico, nel tempo avrebbe potuto e dovuto svolgere un particolare e delicato lavoro, il nome di costui sarebbe stato certamente ancor più preservato.
Anzi, per i compiti che lo avrebbero atteso nell’avvenire, questo elemento avrebbe dovuto essere oggetto di particolare cura, come quello organizzare attraverso i propri canali informativi una corrente di notizie tendenti ad ascoltare presso la pubblica opinione la voce “sull’eroico atteggiamento tenuto in carcere, al confino, negli interrogatori” nell’intento di creargli, o meglio, dargli l’alone di virtù rivoluzionaria, perché potesse salire sempre più alto nella gerarchia del partito per meglio utilizzarlo nel momento più delicato e indicato, obbligandolo, nel caso di resistenza, e di riluttanza, con il ricatto a prendere posizioni ufficiali contro la politica del suo partito.
Così si sarebbero comportati i dirigenti dell’organizzazione spionistica, se avessero avuto tra i loro agenti un elemento che svolgeva attività di primo piano regionale e provinciale nel partito avversario. Un elemento con un passato di attività e responsabilità politica regionale che non lo faceva primo e che pertanto con un po’ di buona volontà, avrebbe potuto fare molta strada nel partito e quindi elemento da utilizzare al momento buono in modo da portare il più gran caos possibile, facendogli prendere una posizione di “fronda” in appoggio a “gruppuscoli” che nel tempo avrebbero potuto essere formati.
Questo discorso non meravigli perchè è normale in una società dove la lotta di classe è in pieno svolgimento e dove si combatte per raggiungere l’ultima spiaggia”. Comunque era una considerazione che avrebbe dovuto essere fatta da chi si accingeva ad indossare nel 1944 la “toga” del giudice.
Conclusione
I ricordi della mia vita potrebbero concludersi con quanto scritto nella pagina precedente. Da allora ho dovuto ritirarmi dalla vita politica attiva.
Sono trascorsi decenni da quell’epoca, ma malgrado ciò non riesco a mettere il mio cuore in pace per diversi motivi:
- a) il fatto che le ingiustizie, gli arbitri subiti dai fascisti avevano un loro logica; gli arbitri e le ingiustizie che si ricevono dai compagni, no!;
- b) ho continuato a vivere, ad avere rapporti con i lavoratori che sul posto di lavoro hanno voluto che accettassi la loro fiducia;
- c) che i miei figli combattono tutti la mia stessa battaglia;
- d) che spesso compagni di partito che non conoscono le ultime fasi della mia battagli apolitica nel 1944, mi chiedono perché mai non assumo maggiori responsabilità nel lavoro del partito;
- e) il fatto che in questi ultimi anni numerosi sono stati gli studiosi, per tesi di laurea, per ricerche storiche, per scrivere libri intorno alla lotta clandestina e alla Resistenza, sono andati a frugare negli archivi dello Stato, in quelli dei partiti, dei giornali dell’epoca e magari nelle coscienze dei protagonisti sopravvissuti.
Pertanto il mio nome spesso, sempre più spesso, viene a galla e certamente, magari per curiosità, qualcuno di questi scrittori, studiosi, lettori, si chiederà: ma costui che fine ha fatto?! Lo troviamo presente nella vita politica clandestina per vent’anni, poi raggiunta con il crollo della dittatura fascista, l’epoca della libertà e della giustizia, costui sparisce. Strano,no?!
Qualcuno invece scava ancora e legge….
La lotta di classe – un senso alla vita proletaria
Dedicato alla memoria di mia madre morta nel 1942, preconizzandoci la vittoria.
1923
Sprazi di luce s’alternano al buio
Lasciando negli occhi il barbaglio del disorientamento
Nel buio, false o nichilistiche voci emergono,
mentre la bufera, d’intorno sempre più rugge.
La nera barbaria semina odio e violenza
Che fa crescere sempre più forte l’amore per la verità.
Matteotti, Gramsci ed altri mille martiri cadono,
idee che riscaldano il sangue impedendone il ragrumo
1932
l’universitàha cambiato sede ed è piena di cimici,
nella cella manca l’aria ma, aguzzino, della morte
mi hai dato la vita rendendo la mia fede contagiosa.
Batti! Picchia o brigante! L’alba verrà,
l’aurora darà un colore ai miei stracci
e tu tremerai dalla paura.
Lo spirito evade dall’inferriata,
e spazia nell’infinito ebbro di verità
che non puoi bruciare come fai con L’Unità.
1936
C’è polvere di tutti i paesi d’Italia
nella “cella di transito” e c’è scritto:
“tira il giusto anello della catena, compagno, vincerai”.
Le carceri, tutti nomi di santi e la Regina Coeli,
la “squadretta” di Napoli, Ponza e Ventotene,
ma il cuore sempre pieno di benedetta speme.
Compiti la tua prima lettera o donna?!
Ciò che non vide l’antico borgo natio,
s’avvera ora, sotto l’influsso del nuovo che preme,
Cammina o Madre, ora stai con le figure del Gorkij.
Vedrai l’essenza di te stessa,e comprendendo vivrai
1943
Vent’anni ed altri enti quaranta; le ore più belle
di una santa battaglia che ha dato,un senso alla vita,
altrimenti destinata a passare senza aver vissuto.
Qualche precisazione
Nello scrivere le ultime righe dei miei ricordi politici credevo di aver concluso, ma giustamente mi è stato chiesto di fare qualche precisazione circa quanto accaduto nella riunione del 28 novembre 1944, e dopo…
Allora riprendo il discorso.
Quel giorno nell’ufficio della federazione anconetana del P.C.I. erano presenti: Aristodemo Maniera, Alfredo Spadellini, Gherardo Corinaldesi, Vero Candelaresi, Ruggero Giannini, Raffaele Giorgini, Bianca Sarti, Eugenio Monti, Umberto Coen, Raffaele Maderloni.
In un angolo siede Egisto Cappellini. Non interverrà mai.
Prende la parola Maniera informando i compagni che l’avvocato Oddo Marinelli, repubblicano, neo Prefetto di Ancona, rovistando negli archivi della prefettura, tra le scartoffie, ha rinvenuto cinque ricevute di denaro per modeste cifre che mi sarebbero state versate tra il 23 ottobre 1937 ed il 29 marzo 1939.
Solo qualche giorno dopo saprò che mi si attribuiva di aver percepito £.40 e £.30 nel 1937; 8.50 e £. 100 nel 1938 e £.25 ne11939.
A questo punto per indicare il valore delle cifre cito il “Bollettino mensile statistico del Comune di Ancona”, anno 1938: «Un arsenalotto specializzato percepiva, per dieci ore di lavoro, giornaliere, 320 lire alla quindicina…(v, Paolo Giannotti in Stampa operaia e classi sociali nella lotta clandestina,
pagina 31, Argalia Editore, Urbino).
Rispondo subito: «Certo! Nel 1937 o 1938 ho ricevuto un paio di sussidi di 40 e di 30 lire. ma non è un segreto, poiché io stesso all’epoca raccontai ai compagni l’episodio. I compagni qui presenti Corinaldesi e Giannini possono subito testimoniarlo» La stessa testimonianza potrebbe essere fatta dai compagni Gino Grilli e Vittorio Marinelli, assenti, che all’epoca 1938-38
e negli anni seguenti condivisero con me la responsabilità della direzione nell’organizzazione clandestina.
Il Maniera si alza di scatto inveendo e gridando: «Infatti abbiamo le prove del tuo tradimento! ».
A queste parole rimango esterrefatto. Protesto contro l’abominevole insinuazione.
Ma il Maniera continua: «Abbiamo le prove»
Naturalmente chiedo:« le prove di che? Di quale cattiva azione?! Il fatto che io abbia accettato 7 o 8 anni, or sono, in pieno fascismo, un modesto sussidio non significa che abbia nociuto a qualcuno o a qualche cosa. Cosa significa parlare di tradimento? Chi è stato tradito? Si tratta di un problema morale del quale rispondo personalmente di fronte a chi di dovere. In ogni modo affermo che delle cinque ricevute tre sono false, cioè denaro che io non ho ricevuto!»
Ma il Maniera ha fretta. Propone che i presenti esprimano la loro opinione e senza attendere altro passa a fare la sua dichiarazione secondo la quale di fronte ad un atto del genere non c’è che l’espulsione dal partito. Alfredo Spadellini che dice: «Fortunato che la guerriglia è terminata altrimenti bisognava fucilarlo!» e chiede l’espulsione.
E’ la volta di Gherardo Corinaldesi che dice: «Verso la fine del 1937 venni presentato a Maderloni e non tardai a condividere le sue idee. Mi introdusse nell’organizzazione comunista sino alle più alte responsabilità. All’epoca mi raccontò l’episodio del sussidio, io trovai la cosa normale dati i tempi correnti allora, sul piano politico non ho mai avuto noie né con la polizia né con i fascisti. Ma se questo è un grave errore: espulsione!»
Parla Vero Candelaresi che dichiara di non aver assolto nell’organizzazione compiti direttivi, ma di non aver mai avuto a che fare con la polizia, comunque vada per l’espulsione.
Ruggero Giannini dice: «Mi par di sognare, proporre l’espulsione di Raff. Il compagno Maderloni è stato il nostro maestro e guida per tanti anni e per tutti noi, escluso Maniera che è andato via da Ancona nel 1924o 1925. Io sono nell’organizzazione dal 1929. Siamo sempre stati vicini e mi ha sempre raccontato quello che gli accadeva compreso l’episodio del sussidio, ogni cosa gli serviva per trarne insegnamento. Non abbiamo mai pensato che nelle condizioni create dal fascismo il prendere un sussidio potesse costituire materia di colpevolezza. Io non vedo il motivo dell’espulsione, comunque c’è uno Statuto del Partito che regola questa materiae noi qui non possiamo decidere per l’espulsione».
Dopo Giannini parlano: Raffaele Giorgini, Bianca Sarti, Eugenio Monti, Umberto Coen, che si dichiarano d’accordo con il compagno Giannini e chiedono che Maderloni venga sottoposto a regolare inchiesta dandogli la possibilità di difendersi, di dare spiegazioni.
Il Maniera s’imbestialisce e alzando la voce minaccia la maggioranza di denuncia alla commissione di disciplina e per finirla invita tutti i membri del C.D. provvisorio della Federazione a rispondere al seguente quesito: «È tradimento accettare danaro dalla polizia?». Rispondere SI o NO, e inviare il tutto alla Direzione del Partito a Roma.
È evidente che posto così il problema, il risultato è scontato.
Sono talmente frastornato dalla ignobile accusa che non penso che i miei giudici naturali sono i miei compagni di Ancona, quelli che hanno vissuto con me la lotta contro il fascismo in Italia, non penso neppure che a Roma liberata da appena cinque mesi, con mezza Italia ancora occupata dai nazisti, con il partito impegnato a continuare la Resistenza, possano occuparsi del mio problema personale.
Comunque ho fiducia nel Partito solo che ritengo necessario inviare a Roma una mia biografia per dar modo di far sapere chi sono altrimenti chi non mi conosce, come farebbe a dare un giudizio?!
Ho poche ore di tempo. Chiedo un dattilografo per dettare i fatti più salienti della mia vita, mi viene negato. Chiedo una macchina per scrivere, mi viene rifiutata. Il compagno prof. Giulio Bombi mi offre la sua fraterna ospitalità e l’occorrente per scrivere.
Passo tutta la notte a rievocare la mia vita e al mattino consegno sette cartelle dattiloscritte relative alla mia attività politica e quattro cartelle al problema del sussidio e all’autocritica. Concludo quest’ultima chiedendo l’espulsione se si ritiene che abbia commesso un grave errore ma con una giusta motivazione perché in coscienza sento di non aver mai commesso azione riprovevole. Non ho mai appurato se il materiale da me dattiloscritto sia stato effettivamente consegnato alla direzione del partito a Roma.
Il giorno dopo mi vengono tolte le chiavi del mio ufficio (del movimento giovanile comunista), la bicicletta che mi serviva per l’attività politica in provincia, mi ritrovo disoccupato, senza un mestiere, senza un soldo per mantenere mia moglie e due figli.
Trovo modo di occuparmi come portuale notturno ma dopo la prima notte di lavoro, quando al mattino scendo sulla banchina trovo
il compagno Fanesi, presidente della Compagnia Portuali, che quasi vergognandosi mi dice che non può farmi lavorare perché… il Maniera non è d’accordo. Anche lui è schiavo del falso concetto della disciplina di partito.
Vado a casa, trovo mia moglie che m’informa che Maniera le ha fatto pervenire il consiglio di abbandonarmi. Di fronte a questo fatto che considero una vigliaccata, decido di dargli una lezione. Mi reco in Federazione per affrontarlo e dargli quello che si merita, ma è assente e vecchi compagni (Giannini e Adone Pierfederici) riescono a calmarmi. Facendomi sperare in un positivo giudizio della Direzione del partito.
Rimango in attesa degli avvenimenti, invito centinaia di compagni che mi visitano ad avere fiducia nel partito. Sono convinto che i compagni del “centro” sapranno l’equilibrio considerando che l’episodio di per se non ha rilevanza alcuna incastonandolo nel mosaico della mia vita. In ogni caso, penso, dovranno darmi la possibilità di provvedere alla mia difesa, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto del Partito. Ritengo che non si può condannare un compagno, chiunque, senza sottoporlo ad inchiesta e regolare processo.
Intanto mi meraviglio che i compagni non reagiscano, pur vedendo che si procede contro di me con una forma che non ha nulla di comune con quanto stabilisce lo Statuto del partito e comincio a rendermi conto chela colpa è la mia perché durante la dittatura fascista sono io che ho tenuto alto ilricordo di Maniera, che ritenevo ramingo per il mondo a causa delle nostre idee e ne avevo fatta sempre l’apoteosi.
Ero io che avevo proposto e con insistenza che egli prendesse il mio posto di segretario della federazione prima ancora della conferenza di organizzazione, contribuendo così ad aumentargli la stima di rivoluzionario. Ora i compagni subivano l’ascendente che io stesso avevo contribuito a creargli: tornato ad Ancona dopo 20 anni Maniera sarebbe stato un illustre ignoto.
Il 10 dicembre 1944, al cinema Marchetti di Ancona, inizia la prima conferenza di organizzazione provinciale. Il giorno dopo, Egisto Cappellini, ufficialmente, formula l’accusa di tradimento nei miei riguardi. Le dichiarazioni di Cappellini provocano dimostranze da parte di numerosi delegati.
Di quello che il relatore dice sul “Caso Maderloni”potrò leggerlo soltanto il giorno 23 quando esce il periodico del P.C.I. “Bandiera
Rossa”, nella seconda pagina.
Il Comitato federale aveva proceduto alla mia espulsione dal partito, sulla base della relazione Cappellini.
Quindi per conoscere i motivi del provvedimento preso contro di me bisogna leggere la relazione Cappellini. Ci si può rendere conto subito come Cappellini non sia in grado di dare un concreto contenuto alle accuse.
Prima crea un’ombra, poi cerca di darle un corpo.
Inizia con il farmi apprezzamenti positivi circa lavolontà, la capacità, la dedizione al partito, la disposizione ad autocriticarmi e da correggermi.
Scopre in me “atteggiamenti rivoluzionaristici” (senza dire in che consistono). Fin dall’inizio cerca di far colpo sull’animo dei compagni affermando che dopo il 25 luglio aveva saputo dei rapporti di “carattere amichevole” tra me e un funzionario di P.S.
Egli si guarda bene dal dire che sono dati contenuti nel rapporto a voce che gli feci quando dopo il 25 luglio ebbi il primo contatto con lui. Rappresentava il “centro”, pertanto gli feci una relazione generale sulla Provincia e sulla regione, situazione che egli ignorava poiché da molti anni era lontano dalle Marche. Fra le notizie fornitegli, parlai del dottor Luigi Russo, commissario di P.S. come lo informai dei rapporti che l’organizzazione, tramite il compagno professor Ermenegildo Catalini, intratteneva con il Colonnello Ravenna, Comandante della Legione C.C. al quale si faceva pervenire anche materiale clandestino, così come parlammo dei rapporti che avevamo con agenti di custodia, ecc.
Nella nostra vita di perseguitati ci siamo imbattuti in persone feroci, altri invece che facevano il loro dovere, il loro mestiere, senza accanirsi. Che nelle circostanze vissute allora si tenesse conto del modo con cui si erano comportati certi elementi è lo stesso Cappellini che propone al “centro” di prendere una decisione nazionale per l’accettazione nel partito di ex fascisti, ex podestà, ex squadristi (v. pag. 179 del libro P.C.I. e la Guerra di Liberazione 1943-45, di Pietro Secchia, Edizioni Feltrinelli, 1971). E certamente una differenza esisteva tra uno squadrista ed un funzionario statale.
Comunque dopo aver affermato quanto precede, Cappellini spara la seconda bordata e dichiara il suo dolore quando scopre… che Maderloni dal periodo 23 ottobre 1937al 20 marzo 1939 ha firmato alla Questura di Ancona cinque ricevute per danaro riscosso. Pudicamente Cappellini non dice di che cifre si tratta. Se egli avesse indicato l’entità delle somme che mi si attribuiva di aver percepito, i compagni presenti avrebbero ancor più rumorosamente contestato le sue dichiarazioni.
Non dice le somme, mente, quando dichiara che le ricevute sono firmate, che le firme sono autentiche e che il motivo dei versamenti è di carattere infamante.
E’ evidente che ha bisogno di calcare la mano per aver ragione delle rimostranze dei compagni che rimangono increduli anche perché il relatore non si decide, malgrado gli inviti, a concretizzare le accuse. Circa l’autenticità delle firme, in una normale inchiesta, sarebbero state sottoposte ad esame di un perito calligrafico e certamente, salvo una, sarebbero risultate firme false. Ma forse non si voleva perdere tempo.
Il relatore si rende conto che l’uditorio attende l’elenco dei miei malfatti e cerca di salvarsi affermando: «Se è vero che non ha fornito informazioni importanti, questo non esclude che abbia dato piccole informazioni, magari vaghe e poco consistenti, ma bastevoli, insieme ad altre a permetterealla polizia di controllare il movimento cospirativo!».
In sostanza secondo il Cappellini avrei fornito informazioni sia pure vaghe e poco consistenti per avere in tre anni, in cinque riprese, riscosso lire duecentoquarantacinque.
«In tal modo la polizia poteva controllare il movimento cospirativo» (che in quel periodo insieme ai compagni Vittorio Marinelli e Gino Grilli andavo ricostituendo e che forte di alcune centinaia di compagni raggiunge il 25 luglio 1943, senza incidenti degni di nota, malgrado la grande attività portata avanti).
Dopo quanto precede il Cappellini si aggancia a “strane coincidenze”. Per esempio sulle licenze dell’isola di Ventotene di cui trattato nelle mie memorie. Sul ritorno da Ventotene dopo soltanto due anni e non cinque di cui io scrivo.
Su certi fermi avvenuti nel novembre 1937 di cui ho già narrato e che si riferisce all’episodio che Alfredo Spadellini narra a pagina 341 e seguenti nel libro I compagni. La storia del partito comunista nelle”storie” dei suoi militanti a cura di Enzo Rava, Editori Riuniti.
Per queste “strane coincidenze” cito testimonianze che ritengo al di sopra di ogni sospetto. Circa il viaggio fatto a Roma con il compagno professor Ermenegildo Catalini, alla ricerca, nel gennaio 1943, del contatto con un “centro” interno del partito, non ha nulla a che fare con gli arresti del 30 maggio 1943, dovuti alla delazione di uno slavo di Zara, certo Olivari, legato all’organizzazione giellista, che fa arrestare gli aderenti alla Concentrazione Antifascista, di cui la nostra organizzazione ignorava l’esistenza.
È ridicolo affermare, come fa Cappellini, quando dice che quattro mesi dopo (e non due) il capo dell’OVRA contesta al Catalini (arrestato il 31 maggio 1943) circostanze troppo esatte circa l’arrivo “a Roma di notte” delle visite e giri fatti per non lasciar “sorgere sospetti”.
Come si può leggere nella relazione del Cappellini, che servirà al Comitato Federale per l’espulsione per tradimento dal partito, di Raffaele Maderloni, si fa molto uso di “strane coincidenze”, di “sospetti” molto vaghi, di “informazioni vaghe e poco consistenti” che i poliziotti pagano con un’elemosina, come se non avessero ottenuto che chiacchiere di nessun valore.
Malgrado ciò si procede contro Maderloni ritenendolo un “traditore”. E si deve supporre che la decisione attribuita da “Bandiera Rossa” al Comitato Federale, deve essere stata presa, senza attendere, a dir poco, il giudizio dei compagni del “centro romano” sempre supposto che l’abbiano interpellato.
Il Cappellini s’avvia alla fine biasimando due compagni (Ruggero Giannini e Gherardo Corinaldesi) che, a conoscenza del sussidio commisero il – grave errore – di non riferirlo a “ chi di dovere” -. Ma i compagni responsabili avevo già provveduto io a renderli edotti dell’episodio.
Poi il relatore concluse che io negavo di aver tradito e che mi riconoscevo colpevole. Giocando sull’equivoco non dice di che mi dichiaro colpevole. Io chiedo l’espulsione se si riteneva che avevo commesso un “errore”, con una giusta motivazione: questo ho chiesto!
Come ho chiesto che nei miei confronti si procedesse tenendo conto di quanto è stabilito dallo Statuto del Partito, approvato dal V congresso nazionale che recita:
art. 10 – Ogni iscritto al Partito Comunista ha diritto: a), b), c), d)…e) di essere, in caso di mancanza disciplinare giudicato da un organismo regolare del partito e potere in ogni caso fare appello alla assemblea della sua organizzazione o agli organi centrali del Partito.
ART. 42”-“ :::: il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla contestazione degli addebiti e alla discolpa.
Egli può appellarsi al Comitato Direttivo dell’organizzazione superiore a quella che ha preso la misurare in ogni caso alla Direzione del Partito al Comitato Centrale”
Ho citato lo Statuto approvato dal V° Congresso del P.C.I. ma sono sicuro che tali norme sono state approvate anche nei Congressi precedenti.
Mi si potrà chiedere perché nel dicembre 1944 non mi ribellai alla tremenda ingiustizia!
All’epoca si era usciti da un lungo periodo di vita cospirativa che necessariamente obbligava ad una concezione e alla pratica di disciplina di partito di carattere più che rigido.
Per tale tipo di disciplina, per l’attaccamento e la fedeltà al partito, considerai come commettere un delitto contro di esso, per il male che ne sarebbe derivato qualora l’avversario di classe di destra o di sinistra, avesse avuto come la prova che il partito comunista era inquinato di “stalinismo” (quando con questo termine s’intenda che è possibile, non solo commettere un arbitrio nell’ambito del partito non applicando nei confronti di un suo membro, quanto è previsto dallo Statuto del Partito, ma essere anche possibile commettere un delitto, per non pagare il prezzo dell’ erro-re-arbitrio, sacrificando il principio dell’ autocritica al culto della personalità).
Ero preoccupato che attaccando il gruppo di minoranza e per esso il vero responsabile (Maniera) le conseguenze sarebbero cadute sul partito.
Ero geloso dell’integrità ideologica del partito, vittima come ero della campagna intesa per 20 anni da parte dei fascisti, degli anarchici, dei trozkisti, dei repubblicani e di altri ancora che tutti d’accordo, con sfumature diverse, avevano attaccato il partito per la sua struttura interna.
Supponevo che nel mio caso potesse derivare sfiducia al Partito nel momento della sua ricostruzione, in un momento difficile, avere la prova che un partito, che prometteva di rendere giustizia a milioni di lavoratori non era capace di impedire una ingiustizia nell’interno dello stesso partito.
Dopo aver letto il cumulo di menzogne dette sul mio conto da “Marco” alla P Conferenza d’organizzazione, compresi che in Ancona avrei potuto farmi giustizia solo se avessi accettato la collaborazione dei numerosi compagni che mi suggerivano di andare allo scontro frontale e cioè cacciare Maniera e soci dalla federazione,
Ma questo metodo mi ripugnava, e rimproveravo coloro che mi indicavano tale strada. Ritenevo impossibile che i compagni della Direzione avessero autorizzato un modo così arbitrario di procedere nel mio caso.
Pensai che molto probabilmente a Roma avevano preso visione delle undici cartelle dattiloscritte contenenti la mia biografia, consegnate il mattino del 29 novembre.
Allora decisi di scrivere ancora una volta i miei cenni biografici e portarli personalmente alla Direzione Nazionale per chiedere giustizia. Mi misi al lavoro, non fa date le circostanze e il mio spirito accasciato da quanto mi stava accadendo, dopo vent’anni di lotta contro il fascismo.
Avevo appena terminato di approntare il documento che il 10 gennaio 1945 il n. 1 di “Bandiera Rossa” riporta la notizia della mia espulsione.
Si rileva subito la volontà di farla finita col caso Maderloni. Non si parla più di alcuni sussidi per poche decine di lire, ma si afferma che sono stato espulso perché “stipendiato” dalla polizia dal 1937 al 25 luglio 1943.
Ma il comunicato della mia espulsione non convince i compagni che nelle sezioni e nelle cellule continuano a chiedere notizie più precise sul caso Maderloni.
Il 23 gennaio 1945, mi presentai alla Direzione Nazionale, in via Nazionale a
Roma. Mi introdussero nell’ufficio di Antonio Cicalini, al quale consegnai la mia biografia, la cronaca di quanto accaduto di arbitrario (secondo me) dopo la riunione del 28 dicembre 1944, cenni d’autocritici e chiedendo alla Direzione del Partito un giudizio obiettivo sul mio caso.
E qui continuo nell’errore di non capire che i miei giudici naturali sono i compagni di Ancona, con i quali ho collaborato sul piano politico dal ritorno al confino nel 1937 al 1943/44.
Non potevo essere capito dal compagno Cicalini per due ragioni:
- egli era stato carcerato nel 1931 poi inviato al confino sino al 1943. Mancando così per 12 anni dalla vita reale. Avrebbe potuto avere, forse, l’animo sgombro da ogni astiosità, malgrado le sofferenze della detenzione ed esaminare il “caso” con obiettività ma…….
- Anche lui doveva essere stato influenzato da come, da parte di Maniera, era stato compilato il primo rapporto, dal modo come vennero presentati i fatti.
Il compagno Cicalini, senza degnare di uno sguardo il pacchetto contenente la mia memoria non seppe rispondermi che nel modo seguente: “Non è il partito che deve giudicare se sei innocente, sei tu che devi dimostrare che non sei colpevole.», se fu una affermazione settaria lo diranno i. posteri, se non avranno altro da pensare. Ebbi un attimo di terrore all’idea che certi uomini potessero diventare arbitri della giustizia in Italia… Ma la fiducia nel Partito prese il sopravvento e ….preso il treno tornai ad Ancona.
Tornato ad Ancona mi trovai di fronte al grosso problema di come portare avanti la mia famiglia.
Bisogna convenire che mi trovavo in una condizione molto difficile, proprio per le condizioni create dall’attacco sul piano politico dal segretario della federazione comunista della città.
Intanto nel partito i compagni di base continuavano a chiedere di più circa come era stato scritto su “Bandiera Rossa”. I compagni ribattevano che quello lo avevano letto ma che desideravano sapere come il tradimento aveva potuto verificarsi.
Si obiettava che pur avendo avuto rapporti organizzativi dal 1923, dal 1929, dal 1934, poi dal 1937 sino al 1943, a loro nulla era accaduto che si potesse sospettare la presenza nell’organizzazione di un traditore.
Avendo letto su “Bandiera Rossa” che Maderloni era stato un informatore stipendiato dal 1937 al 25 luglio 1943, i compagni desideravano sapere a quanto ammontava lo stipendio che è una somma percepita ogni fine mese. Sostenevano che la domanda non era opziosa perché essendo essi stati vicini per tanti anni al compagno Maderloni avevano bisogno di capire perché malgrado lo stipendio mensile percepito, che certamente sarà stato consistente di centinaia o migliaia di lire, Maderloni si era ostinato fin dal suo ritorno dall’isola di Ventotene ad abitare, con la vecchia madre, la giovane moglie e un bambino, in un magazzino indicato con il civico numero 14/a, sito in un vicolo del rione Guasco, sprovvisto di ogni conforto, anche il più elementare come la canna fumaria, ciò dal 1937 al 25 luglio 1943, malgrado lo stipendio percepito come dichiarato nel comunicato del C.F. su “Bandiera Rossa” del l0 gennaio 1945.
Comunicato che contrasta con quanto dichiarato da Egisto Cappellini secondo il quale il compagno Maderloni avrebbe percepito tra il 1937 e il 1939 cinque sussidi di poche decine di lire.
I compagni desideravano sapere qual era la verità, chi aveva mentito, perché era stato detto il falso, chi aveva interesse a falsare la verità?!
La coscienza popolare si rifiuta di convincere se stessa della giustezza dell’accusa di tradimento perché non si riesce a stabilire chi Maderloni ha tradito, in quale circostanza, chi sono le vittime, chi chiede giustizia.
Questi interrogativi non trovano risposta.
Al contrario tutte le “strane coincidenze” sono state chiarite con testimonianze di compagni altamente qualificati.
È noto che Maderloni è sempre stato uno dei compagni dirigenti dell’organizzazione clandestina, quindi depositario di segreti di cui mai la polizia è venuta in possesso.
Prima di sottoporlo a linciaggio morale bisognava ricordare che Maderloni ha al suo attivo:
- arresto gennaio 1926 a Milano – delegato al Congresso di Lione;
- arresto marzo 1927 a Taranto – durante il servizio militare;
- fermo settembre 1929 ad Ancona – corrispondente con compagni siciliani;
- arresto gennaio1932 ad Ancona, poi a Roma – Tribunale Speciale;
- fermo gennaio 1933 ad Ancona – sospetta attività antifascista;
- arresto 1936 ad Ancona – per difendere il compagno Pianelli;
- febbraio 1935 ad Ancona- al confino per attività antifascista;
- arresto agosto, fermo ottobre 1937 ad Ancona – sospetto lancio manifesti antifascisti;
- arresto settembre 1939 ad Ancona – due anni di ammonizione per sospetta attività antifascista;
10) fermo febbraio 1940 ad Ancona- apparizione ordigno esplosivo;
11) gennaio 1943 alla macchia per salvare il compagno;
12) maggio 1943 alla macchia per sfuggire all’arresto;
Dal ritorno dal confino nel 1937 al 25 luglio 1943, l’organizzazione clandestina raggiunge il massimo della sua attività che si concreta nella propaganda, nei gruppi di studio della gioventù comunista, in manifestazioni di massa, senza che la polizia riesca a mettere le mani sui responsabili. Cioè tutta una vita dedicata al partito comunista.
Invece il “caso Maderloni” venne aperto e chiuso in una decina di giorni.
Mentre tutte le sezioni del partito comunista sono in subbuglio, malgrado la mia personale azione tendente ad ottenere una posizione di attesa, di fiducia nella Direzione nazionale, si sviluppa l’azione per il reclutamento di volontari per l’Esercito di Liberazione. Allo scopo di creare un periodo di riflessione.
Decido di arruolarmi nei costituendi “ Gruppi di Combattimento” che dovevano essere la spina dorsale del nuovo esercito nazionale.
Il 21 febbraio 1945, dopo visita per l’idoneità, insieme ad altri 120 giovani, parto da Ancona diretto a Brisighella sul fiume Seno dove il fronte bellico si è stabilizzato. Aggregato nel plotone collegamenti (telefonista) della compagnia comando del 2° battaglione dell’88° Reggimento Divisione “Friuli” partecipo alle operazioni belliche che con l’offensiva iniziata l’11 aprile 1945, porterà alla liberazione di Bologna e all’insurrezione del 25 aprile 1945.
Tornato alla vita civile, mi precipito a Roma, tentando di prendere contatto con la direzione nazionale del partito, alla quale, durante il periodo della mia partecipazione alla guerra di Liberazione, avevo continuamente inviato lettere chiedendo giustizia, ma inutilmente. Aiutato dal compagno IdrenoBedini, telefonista notturno al centralino del Campidoglio a Roma, dopo un mese di permanenza in questa città alla fine del mese di giugno 1945, riesco ad ottenere l’indirizzo privato del compagno Palmiro Togliatti in corso Risorgimento. Da un mese vivo “a scrocco” del povero compagno Bedini, non ho più una lira, sono disperato e stanco di affrontare ogni giorno il gruppo di compagni che mi impediscono di salire alla direzione nazionale sempre in via Nazionale.
Dopo l’informazione del compagno Bedini, ci appostiamo davanti al portone dove abita il compagno Togliatti che poco dopo le ore otto, scende le scale ed esce dal portone.
Attraverso la strada, ho in mano una lettera, lo avvicino e lo prego di leggerla.
Togliatti si ferma, prende la lettera, legge, poi dice: «Ma la tua questione è già stata risolta! »,
Rispondo: «No, e attendo giustizia!».
Togliatti: «Vieni in direzione! »,
Dico: «È un mese che ci provo, non mi fanno passare!». Togliatti: «Vieni e vedrai che passerai».
Togliatti sale in auto con Rita Montagnana, un compagno e l’autista. Mi precipito con il compagno ldrenoBedini in via Nazionale. Stavolta le “guardie del corpo” mi lasciano passare.
Al secondo piano della direzione vengo introdotto in un ufficio e poco dopo mi trovo alla presenza di Rita Montagnana, Umberto Massola e un altro compagno.
Per due ore narro la mia triste vicenda, la mia vita, le testimonianze, i sacrifici, ecc, e chiedo giustizia.
I compagni si rendono conto che qualche cosa di grave è accaduto in Ancona, però bisogna essere cauti, potrebbe andarci di mezzo il partito.
Mi dicono : « E’ evidente che tu hai amato e tuttora ami il partito. Ti sta a cuore il suo sviluppo? E allora devi avere molta pazienza! Torna ad Ancona, col tempo il tuo caso si sistemerà! ».
Mi rendo conto che, purtroppo, allo stato delle cose, bisognerà che il tempo adolcisca gli animi e si possa gradualmente rendermi giustizia senza ledere gli interessi del partito. Di fronte a questa situazione non c’è che attendere lo sviluppo della situazione.
La vita continua. Ed essa continua se si riesce a dar da mangiare alla propria famiglia.
Presentato (dietro consiglio di mio cognato Guido Formica, marito di mia sorella Nella) dal Comandante Lupo, della Capitaneria di Porto, accompagnato dal Presidente del Liceo Rinaldini di Ancona, il prof. Paolo Acrosso, padre del compagno Luigi Acrosso, al Colonnello Castellani, direttore della Sezione Stacc. Art. di Ancona, vengo assunto come operaio specializzato in questo stabilimento militare. È il l0 settembre 1945.
Nel dicembre 1945, nello stabilimento militare, per il personale civile (operai e impiegati) si svolge la votazione per l’elezione della Commissione Interna. Malgrado sia riluttante ad accettare la candidatura, vengo eletto all’unanimità e nella commissione unitaria vengo eletto segretario.
Maniera, segretario della Federazione del partito comunista, tramite Mario Zingaretti, segretario della Camera del Lavoro di Ancona, interviene perché i lavoratori dello stabilimento mi ritirino la loro fiducia.
Ma i compagni e gli altri lavoratori rispondono eleggendomi anche a loro rappresentante sindacale. In quanto tale, entro nel Comitato Provinciale del Sindacato dei dipendenti civili del Ministero della Difesa e vengo eletto segretario.
Nel dicembre 1946, devo subire un vilissimo attacco alla mia onorabilità da parte del periodico locale del partito repubblicano. In difesa della verità, scrivo una lettera che diramo a tutta la stampa di tutti i partiti con preghiera di pubblicazione.
Non è che la storia della mia vita, della mia attività politica, una spiegazione del mio caso, non attacco il giornale repubblicano, ed affermo che è una questione tra me e il mio partito; gli altri non c’entrano.
Ebbene nessun giornale raccoglie la mia preghiera, tutti attuano la “congiura del silenzio” compresa la stampa del P.C.I. salvo quella della D.C. “Lo scudo” regionale, che con caratteri cubitali pubblica l’articolo: «Maderloni si difende».
Preso nell’ingranaggio dell’attività sindacale, nella quale in sostanza continuo la mia battaglia politica per l’emancipazione dei lavoratori, in quanto segretario provinciale del sindacato nazionale dei lavoratori civili del Ministero della Difesa, divengo di diritto membro del Comitato provinciale della Federazione degli Statali.
Nell’aprile 1947 vengo ad essere eletto delegato al Congresso Nazionale della Federazione degli Statali a Roma.
I lavori congressuali stanno per terminare, la sera precedente l’ultima giornata, mi trovo con numerosi congressisti membri del partito comunista nelle vicinanze della Direzione del P. C. I. in via delle Botteghe Oscure.
Ad un certo momento mi accorgo che il gruppo sta dirigendosi verso il portone della direzione comunista, sto salutando il bolognese Osvaldo Saguatti quando questi afferrandomi per un braccio mi comunica che tutti i comunisti sono invitati ad una riunione al partito, per alcune decisioni circail Congresso in cui siamo impegnati. So già che alla porta chiedono di mostrare la tessera del partito. Dico a Saguatti che non posso andare, primo perché ho da fare una cosa importante, secondo perché non ho la tessera del P.C.I.
Sono due anni che intrattengo rapporti sindacali con Saguatti che nel campo dell’organizzazione sindacale degli operai civili che lavorano negli Enti militari del Comando Territoriale Emilia-Romagna-Marche, è il massimo responsabile. Egli non conosce la mia posizione politica, né io mi sento di spiegargliela, non ne avrei avuto, quella sera, il tempo. Saguatti interpreta la mia affermazione nel senso che sono un tesserato del P.C.I. ma non ho la tessera in tasca.
Mi trovo in mezzo ad un folto gruppo di comunisti emiliani con i quali collaboro da molti mesi sul piano sindacale, mi credono un membro del partito sia per le idee che ho espresso nell’attività sindacale, sia perché ho avuto occasione di indicare nomi di compagni emiliani con i quali ho passato qualche tempo in carcere o al confino nel periodo fascista.
Mi mettono in mezzo a loro dicendomi che saranno loro a garantire per me; poco dopo mi trovo all’interno del palazzo della Direzione del Partito Comunista in via delle Botteghe Oscure a Roma. Salgo con gli altri sino al 4° piano, mi trovo in un gran salone insieme a numerosi compagni di tutta Italia. Mi siedo accovacciandomi essere più piccolo possibile.
Ho paura che qualcuno mi riconosca con tutte le conseguenze, date le circostanze. Il compagno Giuseppe Di Vittorio, segretario generale della C.G.I.L. pronuncia una relazione e dopo alcuni interventi è lo stesso Di Vittorio che legge ad alta voce l’elenco dei nomi dei compagni che per la corrente comunista dovranno essere eletti l’indomani al Congresso quali membri del nuovo Comitato Direttivo Nazionale della Federazione degli statali.
Il Direttivo nazionale è composto di 35 membri. I compagni della corrente comunista devono essere 18; Il compagno Di Vittorio legge i nomi e al decimo pronuncia il mio.
Ho l’impressione che il mio cuore stia per cessare di battere. Quasi quasi mi meraviglia che non scoppi un tumulto. È evidente che non posso accettare. Sarebbe una truffa, pertanto attendo che finisca l’elenco poi chiedo la parola al compagno Di Vittorio e dico che per una serie di ragioni, che non posso elencare, non posso accettare l’incarico.
Ma il compagno Di Vittorio insiste, allora io prometto che l’indomani prima di recarmi dove si svolge il congresso, mi farò il dovere di presentarmi in Direzione per dire i motivi che mi impediscono di assolvere il compito che mi si vuol affidare.
Fu quella una notte tremenda; poi decisi di presentarmi a Egisto Capellini (Marco) che alla direzione nazionale svolgeva allora funzioni amministrative e così feci.
“Marco” ascoltò il mio racconto, poi pregandomi di attendere, uscì dall’ufficio.
Tornò dopo una mezz’ora. Era con lui il compagno ‘Tonino Tatò, responsabile del lavoro sindacale, che dopo avermi fissato lungamente in faccia, mi dice: «Come hai fatto a resistere! Vai al Congresso e comunica al compagno Dott. Fiorentino (capo della corrente comunista) che il tuo nome deve rimanere nell’elenco dei comunisti che devono essere eletti nel Consiglio Nazionale».
Erano trascorsi 29 mesi da quando il periodico “Bandiera Rossa”, ad opera di Egisto Cappellini, aveva pubblicato la notizia che erostato espulso dal partito comunista per tradimento. Per procedere così vuoi dire che lo stesso Capellini era convinto che nel mio caso non si doveva né si poteva parlare di tradimento.
La nuova posizione di Cappellini non poteva essere effetto di compassione o che so io. Perché nei riguardi dei traditori non ci può essere pietà, compassione.. .
Membro della Direzione nazionale della Federazione Statali, divengo responsabile regionale (Marche) e pertanto obbligato a curare i rapporti tra centro e periferia dell’organizzazione sindacale, quindi avere rapporti con compagni statali delle quattro province marchigiane.
Nel dicembre 1947, sul giornale “l’Unità”, sperduto tra gli annunci di cronaca, chiunque avrebbe potuto leggere il comunicato della segreteria della federazione comunista di Ancona, secondo il quale Raffaele Maderloni veniva riconosciuto non colpevole di tradimento e pertanto riammesso al partito.
Lo stesso giorno, portata a mano da Alfredo Spadellini mi veniva recapitata la lettera per la mia riammissione al partito che è indirizzata alla Sezione del P.C.I. di Capodimonte (rione) di Ancona.
Al compagno Raffaele Maderloni, la lettera viene spedita p.c. (per conoscenza), come se l’argomento di cui si tratta lo riguardasse marginalmente, quasi per inciso.
Tanto che la lettera, visto il modesto argomento, può essere firmata dal responsabile dell’organizzazione e non dal segretario della federazione.
Sembra quasi che la decisione di rendermi giustizia gli sia stata strappata, e pertanto, imbronciato, si sia ritirato nei suoi appartamenti, lasciando l’incarico ad altri di firmare la lettera. Ma forse si vergogna di firmare la decisione del Comitato Federale con la quale mi si riammette al partito, poiché egli, il Maniera, è lo stesso segretario dell’organizzazione che fece pubblicare su”Bandiera Rossa” nel gennaio 1945, che ero stato “informatore stipendiato della polizia politica di Ancona dal 1937 al 25 luglio 1943”.
Ma il “caso” Maderloni non può essere risolto così semplicemente, dire che non ha tradito, che non è vero che era un “informatore della polizia”, detto questo andare tranquillamente a dormire, come se l’accusa su ”
Bandiera Rossa” del gennaio 1945, allora fosse stata equa, giusta e non invece un fatto mostruoso.
Per fare affermazioni con cui si condannava alla morte civile Maderloni, avere la prova, le prove. E se queste c’erano, se sono un traditore non può essere riammesso al partito. Ma se viene riammesso vuol dire che le prove non ci sono, non ci sono mai state e che pertanto il responsabile, o meglio i responsabili della feroce calunnia, gli autori della coltellata alle spalle di un compagno, non possono andare tranquillamente a dormire.
Si modifica la motivazione dell’espulsione alla luce di “nuovi fatti”. Quali nuovi fatti? Nulla “di nuovo” è accaduto dopo il 1944. Nell’attività politica dell’organizzazione clandestina dal 1923 al 25 luglio 1943, nulla accade che possa far supporre, sia pure lontanamente, che ci sia qualcuno che fornisca alla polizia informazioni, “magari vaghe, poco consistenti” ecc.
E il giudice (Maniera) che con tanta incoscienza e in così breve tempo portò a compimento l’eroica impresa, si mette la coscienza a posto dichiarando semplicemente : «Non era un tradimento quello di cui si era reso colpevole Maderloni, ma una “grave leggerezza”».
Ma ci rende conto del valore della parola?
Tradimento significa usare frode contro colui che si fida e crede nella nostra amicizia, venire meno ai propri doveri verso il partito.
Leggerezza significa avere un carattere disposto a non considerare attentamente un fatto,un episodio, non dare soverchia importanza a cose che invece l’hanno.
Se con tanta “leggerezza” (ed è il caso di dirlo) si usò nei confronti del Maderloni, la parola tradimento, ingannando i compagni di
Ancona e delle Marche, i membri del “centro” del partito, compiendo un atto di cannibalismo, bisogna che il, o i, responsabili dicano perché lo hanno fatto.
Inoltre, ancora una volta, si prende una decisione arbitrariamente, si decide di qualificare un atto compiuto da Maderloni “leggerezza grave”, senza permettergli di spiegare, consentirgli di fare autocritica, ecc.
Maderloni avrebbe commesso una “leggerezza grave” perché nel periodo della cospirazione contro il regime fascista, allo scopo di stornare eventuali sospetti da parte della polizia, circa l’esistenza di “soccorsorosso” per le vittime politiche, nel 1937 ritenne più opportuno accettare un non richiesto sussidio di poche lire offerte-gli da un commissario di P.S. piuttosto che autorizzare la nascita di sospetti che avrebbero potuto ostacolare lo sviluppo dell’organizzazione?
Da rilevare che rende immediatamente conto dell’episodio ai compagni più vicini e responsabili, come da testimonianze fatte nel 1944.
Maderloni ritiene di aver agito in conformità alla terribile leggerezza della “giungla” nell’interesse dell’organizzazione che, come la cronaca anconetana dice, è sempre stata al riparo dalle grinfie del nemico di classe.
Da rilevare ancora che malgrado la modifica del motivo, l’espulsione rimane, giacché nella lettera si legge “riammettere il Maderloni al partito in considerazione del buon comportamento da lui tenuto durante il periodo del suo allontanamento dal partito stesso”.
Ma non per l’episodio del sussidio bisogna accusare Maderloni di “leggerezza grave”, perché ben altre “leggerezze gravi” egli ha commesso.
Elenchiamole:
a)nel 1923 non sa resistere all’influenza che su di lui esercita la violenza fascista e anziché fare come fanno milioni di italiani, che abbandonano la lotta politica, Maderloni organizza il primo gruppo di giovani comunisti;
- b) gennaio 1926 è così debole da farsi influenzare dal segretario della sezione comunista di Ancona a partire per una missione politica (3 o Congresso del P.C.I. a Lione) anziché prendere il treno per Taranto per il servizio militare;
c)malgrado l’arresto del gennaio 1926 a Milano, e la pessima vita militare a causa della sua posizione di giovane comunista, già schedato, benché una volta in congedo, ottenuto un posto di lavoro che assicura alla madre, ormai anziana, una esistenza decorosa, non resiste, per debolezza di carattere, all’invito del partito di riprendere il lavoro organizzativo clandestino nel 1929;
d)dal 1930, il “centro” del partito non riesce a farsi vivo, mentre urge materiale di propaganda, Maderloni è così leggero che organizza una piccola stamperia e finisce, con altri, al Tribunale Speciale nel 1932;
e)tornato dal carcere (reati estinti per amnistia del decennale) nel 1933, è anco-ra una volta vittima volta vittima della leggerezza del suo carattere, malgrado sua madre, sua moglie e un bambino, siano sprovvisti dei mezzi di sussistenza, torna al lavoro politico e nel febbraio 1935, dopo due mesi di carcere viene spedito, con altri, per cinque anni al confino di Ventotene (dove continua ad impicciarsi di fatti che non gli rendono la vita più dolce);
f)torna a casa nel 1937, e il suo carattere debole ancora una volta lo tradisce, malgrado che il fascismo sembra vincere ovunque, Maderloni si ostina a combatterlo, invece di rendere meno pesante la vita alla sua famiglia, ridotta a vivere in una catapecchia. Naturalmente paga questa sua leggerezza con arresti e ammonizione per gli anni 1939, 1940, 1941.
Molte sono le “gravi leggerezze” che commette Maderloni, ma oltre a quelle che si possono rilevare leggendo le sue memorie, diciamo l’ultima.
Siamo nel gennaio 1943, la polizia ha arrestato la compagna Borghi, impiegata all’EIAR (l’odierna RAI) perché trovata in possesso di una copia de “ La Voce del Lavoro”. La Borghi, sottoposta a stringente interrogatorio, rivela il nome di chi le ha passato il volantino antifascista. Viene arresta
to il compagno Rolando Pellegrini, autista dell’EIAR. Questi, purtroppo, dichiara di averlo ricevuto dal compagno Libero Regni che viene arrestato e associato alle carceri giudiziarie di Ancona. Siamo di fronte ad una serie di arresti a catena. Si esamina la situazione, Regni sotto interrogatorio senz’altro non parlerà, ma in caso contrario può fare i nomi di Ruggero Giannini e Remo Cappelletti. Ma questi due compagni non possono andare alla “macchia”. Come andrà a finire è possibile leggerlo nel mio libro.
Per fare il “vuoto” dietro Regni, verrà fatto sapere a lui, detenuto, che se non potrà fare a meno faccia il mio nome.
E questa è stata un’altra debolezza perché come dirigente avrei il massimo della libertà di muovermi.
Il segretario della federazione, quindi crede di essere a posto. Forse si è tolto un peso dallo stomaco, dopo questa dimostrazione di equilibrio politico e si prepara lui, Maniera e l’altro, Cappellini, ad essere eletto in Parlamento, il primo deputato e il secondo senatore, rappresentanti di un partito carico di gloria, che combatte per rendere giustizia a milioni di lavoratori.
Sono talmente presi dalla loro alta missione, convinti di essere stati capaci di amministrare la giustizia con equità, che da quella alta vetta non si rendono conto che gli anni passano, ma l’infamia resta e serve a qualche farabutto a far riaprire la tremenda ferita, ma che non serve a richiamare i diretti responsabili a prendere una onesta posi-zione autocritica perché sia ridato a Maderloni quello che è di Maderloni.
Ma forse si ritiene menomazione eccessiva confessare apertamente di aver commesso, anche se involontariamente, un delitto, per chi coltiva il “culto della personalità” non c’è posto per l’autocritica.
Il 19 dicembre 1959, devo subire ancora un attacco da parte di un giornale anticomunista, e i responsabili della federazione comunista anconetana, tramite “l’Unità”, pur dichiarando che l’episodio dei sussidi non è infamante per la mia fedeltà al partito e alla causa dei lavoratori, ancora una volta senza soppesare oggettivamente il “caso” ricordano che, “a suo tempo” l’atto venne giudicato di “leggerezza grave”.
Nel 1959, come il Cappellini era stato eletto senatore della Repubblica, il Maniera era diventato deputato al Parlamento.
Alla direzione della federazione anconetana vi sono giovani, che probabilmente non se la sentono di prendere in mano un affare “che scotta” e che rimesso in discussone potrebbe generare all’organizzazione più male di quanto non se ne sia arrecato nel 1944/45 per la disgraziata soluzione che allora il Maniera e il Cappellini vollero dare al “caso”.
Come sempre sono tanti e gravi i problemi che stanno davanti al partito che una ripresa in mano del “caso”, che tanta emozione provocò nel 1944/45, potrebbe degenerare in una grande tempesta, qualora si dovesse concludere che oltre a non essere stato Maderloni un traditore, era stato anche un grave errore averlo giudicato colpevole di “leggerezza grave”.
I compagni Renato Bastianelli e Raffaele Giorgini mi fanno leggere il comunicato che pubblicheranno su “l’Unità” in risposta all’articolo apparso sul periodico anticomunista e mi rendo conto che ancora una volta devo rimandare nel tempo la speranza che al mio caso il partito dia ufficialmente la soluzione che io ritengo giusta.
Comunque, mentre scrivo queste note, non dispero che un giorno una commissione incaricata dal partito possa prendere in esame quanto mi è accaduto.
Esaminati i documenti intesi i testimoni, le testimonianze, considerando che senza riferimento ai precedenti generali e particolari, l’indicazione perderebbe qualsiasi senso, risulterebbe distorta, qualsiasi analisi priva di logica. Per dare un giudizio bi-sogna prendere in considerazione tutti i fattori quali l’origine, la cultura, l’evoluzione, la psicologia, l’esperienza, la personalità ufficiale e quella clandestina del tipo in questione.
Credo che in una società sconvolta dall’arbitrio, come quella del periodo fascista, dove regnava sovrana la violenza di parte, le regole di condotta dell’antifascista non potevano essere che quelle indicate dalle circostanze.
In quelle condizioni, i combattenti, uomini alla mercé di se stessi, avevano il diritto, che derivava dalla loro responsabilità, di fare quanto possibile per salvare, prima che se stessi, gli altri, cioè l’organizzazione e qualche volta fare una scelta tra due casi non sempre simpatici, allo scopo di non dar luogo a sospetti.
La mimetizzazione è un atto di coraggio o di viltà?!
Può considerarsi un vile quel combattimento che si nasconde per non farsi colpire dal nemico.
Quel compagno che nega ogni addebito che il poliziotto gli contesta?!
Colui che profitta della notte attaccare manifestini antifascisti o l’altro che cambia discorso all’avvicinarsi di un elemento infido?!
Mimetizzarsi di fronte al nemico, sempre presente nei luoghi di lavoro, nelle strade, nei locali pubblici, ecc., mimetizzarsi non era solo un diritto, ma una esigenza umana, una necessità primordiale che avveniva spontaneamente, meccanicamente, quando ci si sentiva in pericolo.
Mimetizzarsi era anche un dovere per i militanti antifascisti, per difendere l’organizzazione, metterla al riparo dai sospetti e dalla persecuzioni a costo anche di compiere atti che potessero nuocere alla propria personalità.
Anche di ciò bisogna tener conto nell’esaminare fatti, fatti, episodi accaduti durante il fascismo.
fine
4) Di MARISA SARACINELLI
Presentazione del libro “Raffaele Maderloni. Ricordi 1923 -1944
Prima di entrare nel merito del libro, che oggi viene presentato, ritengo opportuno fare qualche rapida considerazione sul valore dell’autobiografia (su cui per altro esiste una 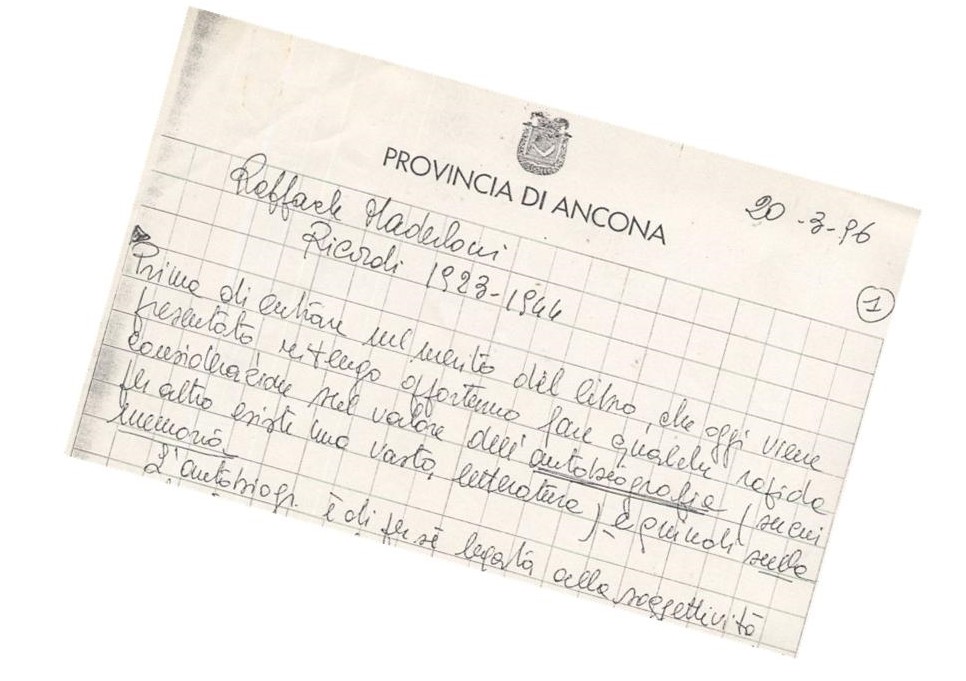 vasta letteratura) e quindi sulla memoria.
vasta letteratura) e quindi sulla memoria.
L’autobiografia è di per sé legata alla soggettività e solo in tempi relativamente recenti essa è entrata nella storia, ne è diventata una fonte legittima.
E questo è un dato molto importante che conferisce dignità storica alla memoria soggettiva.
Ma è anche qualche cosa di più: scrive Luisa Passerini, esperta di testimonianze orali, che l’autobiografia consente ad un soggetto di “essere nella storia, di avere una storia” anzi la Passerini rivendica il “diritto all’autobiografia”.
Resta tuttavia un problema che riguarda tutte le narrazioni autobiografiche, che è quello di coniugare il soggettivo con l’oggettivo, di muoversi cioè tra psicologia e storia.
Chi scrive di sé tende a ricomporre la sua identità attraverso la memoria e la memoria mette in moto un processo attraverso il quale si rielabora il passato e se ne trasmettono significati per il presente.
Difficile definire le operazioni della memoria, dalla Passerini accolgo questo assunto: “La memoria è l’atto narrante di me individuo in un contesto sociale, nel tentativo di conferire significati condivisibili a certi eventi o aspetti del mondo ed eventualmente mettere in secondo piano gli altri”.
L’atto di narrare è nello stesso tempo memoria autobiografica, trasmissione di una esperienza di vita, ricomposizione di una identità, ma anche silenzio, cose taciute.
E questo non per scelta precostituita o travisamento, ma perché tale è il funzionamento della memoria autobiografica (sulla quale è ancora aperto il dibattito).
Di qui la necessità di evidenziare anche i silenzi che hanno sempre un significato e soprattutto di storicizzarli (darò poi alcuni esempi).
Questa premessa ha lo scopo di chiarire con quale sguardo è stato letto il libro.
Questa di Raffaele Maderloni è una storia che egli definisce “semplice” in realtà intensa e drammatica, vissuta in un particolare contesto storico: Ancona, la provincia, l’Italia dagli anni venti agli anni quaranta.
Una storia tesa a dimostrare l’esemplarità di vita di un militante comunista, che diventa tale “non certo per maturità politica”, come lui stesso ricorda, ma determinante fu il fascismo con la sua azione persecutoria contro i comunisti, oltre che naturalmente per lo sdegno e la ribellione contro la sua violenza brutale.
Un militante generoso che vive l’esperienza dell’antifascismo, del carcere, del confino, della resistenza e che, alla fine della guerra, viene colpito da una accusa infamante “tradimento”, espulso dal partito per esserne poi riammesso ventinove mesi dopo e quindi riabilitato.
Sono duecento pagine che partono da una premessa dello stesso Maderloni: “i casi della sua vita” hanno come destinatari i suoi figli, perché sappiano la verità e ne traggano insegnamento.
Contestualmente, risuona alta la condanna contro il pregiudizio, il settarismo, di chi precipitosamente volle arrivare ad una conclusione ingiusta, sbagliata, quale fu l’espulsione dal partito.
C’è una evidente circolarità nella struttura narrativa dei Ricordi: l’incipit della storia, appena citato, si ricollega con la conclusione ”qualche precisazione”: sono venti pagine finali che ricostruiscono con minuzia l’ultimo atto dell’accusa infamante alla assoluzione, che tuttavia non rimargina la ferita.
Dentro queste due coordinate si snoda la vicenda umana e politica di “Raffa”, rivissuta con puntigliosa precisione che restituisce alla fine un ritratto a tutto tondo, ma anche con alcuni significativi silenzi (su cui tornerò).
Sostiene Papini, nella introduzione, che queste memorie si possono leggere in tanti modi, ognuno di essi di qualche interesse, ed è vero.
Papini stesso ha offerto alcuni percorsi di lettura, ha posto interrogativi, suggerito ipotesi interpretative, concludendo con un ringraziamento rivolto allo stesso Maderloni, perché con le sue memorie “se non altro smentisce l’immagine del comunista, privo di personalità, tutto apparato e niente umanità”.
Sinceramente questa “conclusione” mi ha lasciato un po’ perplessa, perché l’ho trovata un po’ riduttiva rispetto ad un personaggio come Maderloni al quale per altro lo stesso Papini ha rivolto la sua attenzione nelle “Biografie di comunisti marchigiani: da Livorno alla clandestinità”.
Biografia che così inizia “Pochi dirigenti del PCI marchigiano hanno suscitato sentimenti tanto contrastanti come Raffaele Maderloni” e così conclude “Il compagno Maderloni non mancò di contribuire a rendere viva la dialettica nel partito anconetano”.
Da parte mia, desidero precisare che non mi addentrerò nella lettura “politica” del libro, forse ancora difficile, nonostante le profonde trasformazioni ideologiche sopravvenute in questi ultimi anni (lo farà credo Ruggero Giacomini). Mi limiterò a focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti, che a me sembrano significativi, con questa altra annotazione: ho letto il libro con emozione, perché la storia di Maderloni mi ha fatto rivivere fatti e personaggi, che hanno attraversato la mia adolescenza, intrecciare tra loro fonti diverse ed illuminarle (anche se di questo non parlerò).
La prima cosa che colpisce nell’autobiografia è la passione politica che connota tutta la vita di Maderloni e germoglia in modo del tutto autonomo, come risposta ad una esistenza segnata dalla povertà da un lato (orfanotrofio), da un lavoro spesso massacrante (quando c’è), ma dall’altro da un bisogno forte di giustizia sociale che lo spinge, giovanissimo, a cercare di capire, ma anche di reagire contro la violenza gratuita del fascismo (pag. 29) – aggredito da fascisti avvinazzati subito dopo la loro invasione di “Ancona città rossa” (pag. 33).
Il bisogno di cultura è una nota forte: tornato dal servizio militare nel 1928 “si sprofonda nella lettura”.
Si abbona ad una libreria circolante e legge ciò che può, ma “i libri ameni” non gli sono di alcun aiuto per quello che cerca di sapere: “classi, lotta di classe, ferree leggi dell’economia, diritto, morale, religione, lo Stato con le sue sovrastrutture mi è ignoto. Nota e convincente c’è solo la mia condizione di lavoratore in preda alla necessità dell’esistenza e sono convinto che tutti gli altri lavoratori la pensino come me”. E aggiunge con rammarico: “La stampa del partito che ho distribuito tra il ’23 e il ’26 è passata tra le mie mani senza lasciare traccia, preoccupato soltanto della sua diffusione”.
Poi, la sete di cultura viene in parte soddisfatta con libri che il fascismo ha lasciato in circolazione ed altri che vengono scambiati tra i giovani comunisti “clandestinamente” si va dal Mariani, al Notari, a Victor Hugo, a Carlo Pisacane, a Repaci, fino alla scoperta di Jack London e “La madre” di M. Gorki.
Ma sarà il confino nell’isola di Ventotene ad accrescere la sua cultura politica perché nell’isola i confinati comunisti organizzano gruppi di studio, soprattutto su economia politica e storia del movimento operaio.
Dello studio aveva grandemente bisogno (pag. 85): oltre l’economia politica, si “inoltrò” nel terreno filosofico leggendo il Materialismo storico di Bucharin tradotto dal francese da alcuni compagni (pag. 86).
Tornato dal confino, poiché il direttivo del partito ha deciso di affrontare il problema del lavoro ideologico e della diffusione delle idee con la stampa, si organizzano gruppi di studio utilizzando il materiale che Maderloni ha portato da Ventotene, unito ad altri testi che si riesce a reperire.
Il materialismo storico di A. Labriola e il Manifesto dei Comunisti, unito alle costituzioni inglese, francese, americana.
Grande effetto ebbe nel 1938/39 la proiezione al cinema Goldoni del film “Tempi moderni” di Chaplin (pag. 94).
Se insisto su questo tema della cultura, è perché a me sembra di grande spessore.
- Flora: ritratto di un ventennio:
– 23 marzo 1939 – non pubblicare più lettere intime di D’Annunzio
– 31 ottobre 1938 – non occuparsi di eventuali candidature di scrittori e uomini italiani per il premio Nobel anche se le proposte sono fatte da giornali stranieri.
– I giornali si astengano di parlare della Storia della letteratura italiana del De Sanctis nella edizione pubblicata in questi giorni dalla Hoepli finché non esca la II edizione.
– Non occuparsi di Moravia e delle sue pubblicazioni
– Non occuparsi del libro di L. Russo “La critica letteraria contemporanea (Laterza)
– Interessarsi della Storia della rivoluzione fascista di Gioacchino Volpe.
– Non dare troppo rilievo al manifesto di Marinetti.
– E’ bene insabbiare la polemica sulle varie tendenze dell’arte italiana.
Il fascismo mostrava disprezzo per le opere di pensiero che considerava povere ancelle dell’azione; del resto il primato dell’azione sulla cultura fu sempre sostenuto dai dittatori.
Al disprezzo per la cultura si univa un controllo capillare di tutta la stampa e le pubblicazioni: nelle famose “veline” che ogni giorno arrivavano nelle redazioni dei giornali venivano impartiti ordini di ogni tipo: per questo la sete di sapere dei giovani militanti mi pare significativa: ma io aggiungo anche un ricordo personale (v. G. Gobbi – vedi documento).
In questo tema si inserisce l’episodio della madre di Maderloni “I miracoli dell’amore materno”: analfabeta, impara a leggere e a scrivere per poter comunicare con il figlio al confino. La Madre di Gorkij è il testo base che la donna legge e rilegge. Una pagina commovente che conferisce alla donna una grande statura (pag. 85).
Le altre donne, invece, fanno un’apparizione fugace (se si esclude la manifestazione del marzo 1943): da Adalgisa Breviglieri “una insegnante di scuola elementare” alle mogli di compagni che “provvedono” a cuocere il pasto per una ventina di detenuti, alla suocera Maria Ciasca “una coraggiosa e intelligente romagnola” alla stessa fidanzata prima e moglie poi.
Di questa donna soprattutto sappiamo poco, ma una frase ne illumina il temperamento: quando Raffa la prega di non legarsi alla sua vita, poiché prevede anni di carcere, lei risponde: “aspetterò trent’anni!”
Nella ricostruzione della sua vicenda politica la presenza della moglie e dei figli rimane nello sfondo ma questo non ci deve stupire: Maderloni è teso a “narrarsi” per dare un senso alla propria vita.
Per lo stesso motivo colpiscono certi silenzi che accompagnano altri momenti: nessun riferimento paesaggistico quando è nell’isola di Ventotene, come se ogni divagazione togliesse forza all’impegno politico.
Chi legge i suoi Ricordi ed intreccia tra loro alcune fonti storiche (di varia natura) non può non ricavarne l’immagine di un uomo generoso, capace di dare corpo ad alcune iniziali e confuse esigenze di giustizia, di infonderle in altri giovani, che lo seguono sulla strada dell’antifascismo e della Resistenza.
Richiamo brevemente il ritratto che ne fa Caimmi nel suo recente libro “Ottavo chilometro” (pag. 36) “All’ottavo chilometro, vicino all’Aspio, lungo la strada che esce a sud di Ancona, si trova il Centro del Partito, in una casa di contadini, una delle tante dove sono ospitate famiglie sfollate dalla città, con quella solidarietà che costituisce la prima grande nemica del fascismo, perché è il mare in cui nuotano i pesci della clandestinità. Raffaele Maderloni, detto ‘Raffa’, è il capo riconosciuto della struttura clandestina. E’ stato il costruttore del Partito, ha subito per questo la repressione del fascismo: arrestato più volte, confinato, rientrato e, subito, tornato al lavoro di organizzazione della struttura nell’anconitano ed in parte delle province di Macerata e di Pesaro. I giovani, soprattutto, lo amano moltissimo ne ammirano le doti umane prima ancora delle capacità politiche e per Raffa sono disposti a tutto. Anche per questo i fascisti lo cercano, lo braccano, vorrebbero riprenderlo. Ma per lui c’è la protezione particolare: quella della gente del quartiere dove è rimasta la sua famiglia, quella dei contadini disposti a rischiare la vita pur di tenerlo nascosto in casa loro, quella dei militanti che gli impediscono di partecipare ad azioni, di rischiare la vita, perché Raffa e solo Raffa, con poche, rapide parole, può mandare uno di loro in montagna, a rischiare la vita per le ragioni che Raffa e solo Raffa ha saputo spiegare loro.”
Che oggi i tempi siano ormai maturi per restituire a Maderloni il senso della sua vita (quello che egli cerca di fare con la sua autobiografia) lo dimostra il fatto che in così poco tempo ci si sia occupati di lui in modo tanto diffuso (tre libri che lo riguardano).
Un’ultima considerazione.
Anche alla famiglia va restituita il senso della sua vita: ai figli e alla moglie, che nei Ricordi sembrano vivere solo nello sfondo.
Scrive nella sua breve presentazione il figlio minore Claudio Maderloni, riferendosi a suo padre e ai suoi compagni: “quelle storie mi hanno sempre affascinato. Erano storie di uomini e donne in carne ed ossa, storie di angosce, di gesti semplici che a me sembravano eroici”. Claudio recupera forse inconsapevolmente un noto passo di una lettera di Antonio Gramsci, che dal carcere scrive al figlio Delio esortandolo ad amare la storia “perché riguarda gli uomini viventi … che lavorano e lottano e migliorano se stessi”.
E’ sempre Claudio che convince il padre a sistemare i suoi ricordi, ma non lo convince a pubblicarli: rimane ferma in Raffa la volontà di non offrire un’arma agli avversari del partito.
Ma, a mio parere, nella presentazione pur così essenziale e quasi piena di pudore, una frase merita di essere sottolineata, e con questa chiudo: “Sono convinto che la storia di mio padre sarebbe stata sicuramente un’altra se non avesse avuto al suo fianco una donna come mia madre Rinalda. Questo lavoro dovrebbe essere dedicato a molte compagne e compagni, ma credo che solo lei possa dire quanto sacrificio gli è costato stare accanto all’uomo che ha amato. Ed è a lei che lo dedico anche perché in tutto il libro non viene mai menzionata se non per aver risposto di no alla richiesta del partito di lasciare suo marito”.